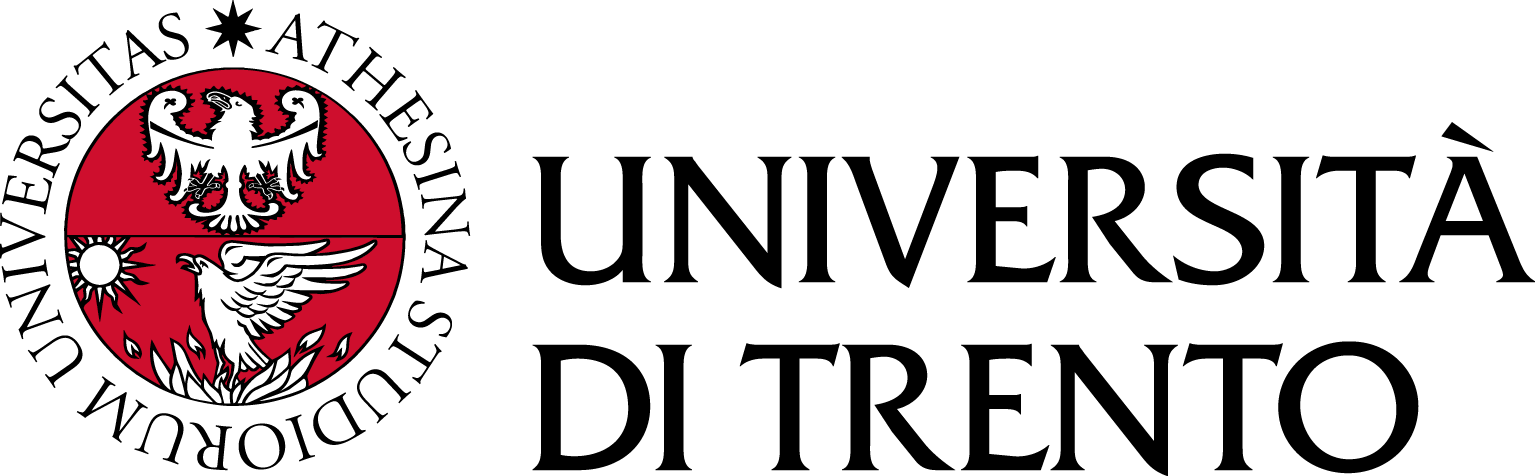I: Prefazione
I: Luogo che la logica dee occupare nell'enciclopedia delle scienze.
1.
L'Ideologia è la scienza del lume intellettivo, col quale l'uomo rende intelligibili a se stesso i sensibili, da cui trae l'universo sapere. Certo l'Ideologia non crea nè inventa questo lume che nell'idea si trova o piuttosto è l'idea stessa, nè pure lo fa intuire, opera del solo creatore e istitutore dell'umana natura; ma essa dall'ordine dell'intuizione lo trasporta in quello della riflessione scientifica, e così ne forma una scienza.
Le scienze sono il prodotto del pensiero riflesso e libero (1), col quale l'uomo si rende consapevole di quello che già sa, ma non sa di sapere, e rende più esplicito, ordinato e maneggevole o applicabile all'azione il sapere, di cui è consapevole. L'ordine non lega solamente insieme le parti di ciascuna scienza, ma anche le scienze stesse.
2.
Quest'ordine avvincolando tra loro tutte le scienze rende non solo utile, ma anche bello il sapere umano consapevole, ed è quello che costituisce l'Enciclopedia delle scienze, non presa come un aggregato materiale quasi gittato a caso, o distribuito secondo la norma delle lettere dell'alfabeto, ma come un tutto organico, uno e armonico.
E tostochè l'Ideologia abbia fatto scientificamente conoscere qual è il lume naturale della mente, il principio d'una tale Enciclopedia è ritrovato (Ideol. 1462—1472); e, trovato quel principio, è trovata l'Enciclopedia stessa, cioè l'ordine naturale delle scienze, che in esso è virtualmente contenuto e da esso si può dedurre.
3.
Questa è una nuova ragione, che dimostra doversi collocare l'Ideologia alla testa di tutte le scienze, le quali da essa ricevono la loro principale distribuzione. Da quell'ora si può assegnare anche a ciascuna dell'altre scienze il suo posto. E noi crediamo, che tutti quelli che assumono di trattare qualche scienza dovrebbero prima darsi il carico di determinare diligentemente il posto che le si aspetta nel gran corpo dello scibile; poiché dal conoscere il posto che conviene alla medesima, e qual membro formi di sì gran corpo, ella stessa riceve compimento e bellezza, e si può definirne l'ambito e assegnarle i confini: condizione indispensabile se si vuol dare alla trattazione delle scienze un sistematico progresso.
4.
Accingendoci dunque noi a compilare un'esposizione della Logica, abbiamo creduto dover principiare dalla questione: «Qual posto occupi la Logica nell'Enciclopedia delle scienze» (Sistema fil. 9.- Preliminare alle Opp. Idd. 31 e 32).
E primieramente da quel che abbiam detto apparisce, che la Logica non può essere anteposta all'Ideologia. Le idee, di cui tratta l'Ideologia, sono il fondamento del ragionamento, intorno a cui s'aggira la Logica. Onde «coloro, come disse Platone, che tolgono via le idee, nè pure al ragionamento lasciano più a luogo alcuno (1)».
5.
Che poi la Logica deva seguitare immediatamente all'Ideologia, in questo modo si può mostrare.
Lo spirito umano produce a se stesso tutte le cognizioni di cui è capace, applicando il lume intellettivo a quello che cade nel suo sentimento, ne' termini e negli oggetti del medesimo. Se l'uomo fosse un ente dotato di sola intelligenza, e di sensitività animale e non avesse oltracciò delle facoltà attive, quale sopra tutte è il libero arbitrio, egli non isbaglierebbe mai nel fare una tale applicazione. Poichè la maniera d'applicare il detto lume, se si fa astrazione dall'arbitrio, è istintiva e d'un istinto razionale, cioè guidato dallo stesso lume, che è ad un tempo quello che viene applicato, e che guida l'uomo ad applicarlo.
Per la stessa ragione se il libero arbitrio si trovasse sempre in uno stato perfetto, e in questo stato eleggesse sempre il bene morale, l'uomo anche colla sua intelligenza procederebbe di sicuro passo alla verità e non cadrebbe in errore (1). Ma non essendo questa la condizione presente dell'uomo, e come l'esperienza ci mostra, la libertà dell'umano arbitrio essendo lontana dalla sua ideale perfezione, e spesso eleggendo il male a preferenza del bene, ond'anche la ragione rimane scossa e vacillante, conviene soccorrere all'uomo da un doppio lato, cioè dal lato della volontà, coll' Etica e cogli eccitamenti alla virtù, rimovendola dal vizio, e dal lato dell'intendimento colla Logica e cogli esercizi del diritto ragionare.
6.
Vediamo dunque come nasca la Logica e con essa l'altre scienze, e se a queste deve essere anteposta o fatta seguire.
Quando il buon'istinto razionale (che non è mai svelto interamente dalla natura umana) s'esercita lungamente in applicare il lume intellettivo, ragionando, senza esser travolto dall'impeto delle passioni cieche, o dall'arbitrio, egli coll'esperienza e coll'abitudine si rinforza, e l'uomo acquista facilità e sicurezza di ragionamento. Arte significa abito operativo, e così nasce nell'uomo una prima Arte di ragionare.
7.
Ma la mente umana in appresso riflette sopra quest' Arte ed osserva che questa, come tutte l'altre (che altramente non sarebbero arti), segue costantemente certe regole, allora le raccoglie e le ordina queste regole, e così nasce la Scienza dell'arte logica, qual prodotto maturato della riflessione.
8.
Questa riflessione, produttrice della Logica come scienza, si fa dunque coll'applicazione del lume intellettivo al ragionare e all'arte di ragionare, che s'acquista dagli uomini prima e indipendentemente dall' esistenza d'una scienza del diritto ragionare.
E poichè ogni ragionare è un'applicazione continua del lume della ragione, apparisce che nel ragionare c'è sempre una dualità, cioè: 1º il lume che s' applica, e 2º ciò a cui s'applica.
Ciò a cui s'applica il lume dell' intelligenza può essere 1° o il lume stesso, 2° o altre cose diverse dal lume: quest'altre cose sono sentimenti per sé ciechi, o appartenenze di questi sentimenti, come la materia, termine del sentimento animale.
Quando il lume intellettivo s'applica a se medesimo per mezzo d'una riflessione, egli fa due uffici ad un tempo, quello di lume, e quello d'illuminato; il che è quanto dire serve di regola e di regolato, di misura e di misurato, di norma secondo cui la mente giudica, e di giudicato, di guida alla mente e di termine a cui ella è guidata, di mezzo e di fine, e così via: tutte queste dualità sono comprese nella prima, lume, e illuminato. E di qui le scienze formali, che sono appunto l'Ideologia e la Logica. Quest'ultima si può dunque definire «la dottrina del lume intellettivo considerato come principio e guida del ragionamento» (1ª def.).
Che se il lume intellettivo non s'applica a se stesso, ma ai sentimenti e a tutto ciò che essi contengono, allora si producono le scienze materiate, che così si dicono, e non materiali, perchè quantunque abbiano una materia, non sono però destituite dalla forma, che altramente non sarebbero scienze.
9.
Ora chi considera l'assunto indicato della Logica (5) e la sua relazione coll'altre scienze, facilmente intende, come essa deva non poco aiutar la mente a trovare l'altre scienze e ad evitare in tale opera gli errori, di che con ragione fu chiamata dagli antichi «Organo», cioè strumento del pensare, e di qui ancora la ragione, perchè all'altre scienze, eccetto all'Ideologia, cioè a tutte le scienze materiate, s'antepone.
II: Ufficio ed utilità della logica
10.
Se non ci fossero nell'uomo delle forze perturbatrici della mente, e atte a sedurre la sua facoltà dell'assenso, che sovente da lui si nega alla verità e si concede all'errore, basterebbe all'uomo, come dicevamo (5), per procedere ragionando direttamente al vero, l'istinto razionale, e l'arte naturale acquistata coll'esercizio del medesimo (6). Ma contro la perturbazione della mente, che gli viene in parte dalle passioni e in parte dalla debolezza della sua propria volontà, o dalla malizia, egli prova il bisogno di premunire il suo intendimento, e il fa colla riflessione su questi stessi pericoli, e sui modi d'evitarli. Quindi dalla consapevolezza della propria infermità d'animo, e fallacità di pensiero, gli uomini furono mossi all'invenzione della scienza Logica.
Poiché, rimanendo sempre in non pochi di essi, tuttochè difettosi, qualche rettitudine, e non potendosi abolire mai interamente la naturale ordinazione e inclinazione della natura umana alla verità ed alla virtù, subiscono a mal in cuore, sebbene in parte volontariamente, quel giogo della sensitività, che oscura loro il sereno della mente o ne limita lo sguardo. Dopo essersi dunque accorti gli uomini ed avere lungamente esperimentato il rischio, a cui sono, di traviare dal vero, anche nelle cose più gravi, se ne misero in guardia, e nacque allora in essi il desiderio di riflettere attentamente sulle fallacie della propria e dell'altrui mente, e sugli andamenti del pensiero, vegliandone i passi, notando quelli che sembrano più difficili e lubrici, come gli scogli nelle carte de' navigatori. Chè venuti in tanto sospetto, non si contentarono più di lasciar andare da sè la propria facoltà di ragionare, ma vollero di più rendersi consapevoli di ciò che ella faceva, sperando così di torsi d'attorno il timore de' suoi naufragi. Quando dunque gli uomini già prevedono e incontrano più volte il pericolo, per ovviarlo quanto più possono, inventano la Logica, cioè «la scienza dell'arte del ragionare» (Def. 2).
A questo tempo e a questo modo la scienza si fa guida dell'arte naturale, e la perfeziona e l'assicura. Poichè come il lume della ragione dirige l'uomo all'uso del ragionare, e quest'uso, durando molto tempo, diventa abito ed arte, così la scienza sopravveniente che si trae dalla riflessione scientifica ripiegata tanto sopra il lume, quanto sopra l'abito già acquistato, arricchisce la mente umana di principi e di regole formolate, fisse, e certe, alle quali riscontrando ogni movimento della propria e dell'altrui mente, l'uomo rileva, se procede per via diritta, o per una torta, e lo ravvia sulla diritta se mai si torce.
III: Utilità storica della logica
11.
Di qui la somma utilità della scienza logica.
È degno d'osservazione, che in tutte quelle nazioni, nelle quali la Logica o non fu inventata, o non pervenne alla perfezione nè pure l'altre scienze poterono farvi buona presa, o non allignarvi al tutto, o se anco v'allignarono un po' di tempo presto imbastardirono; attalchè la scienza Logica, secondo la costante deposizione della storia, si può riguardare come condizione necessaria d'un grande sviluppamento, e incivilimento dell'umanità. Il che noi vediamo comprovato dal confronto del mondo orientale coll'occidentale. Il vigore razionale ed operativn di questo sopra di quello, si dee attribuire, chi ben considera, in grandissima parte all'essere in questo nata e fiorita la Logica, laddove in quello o essa non nacque, o fu poco coltivata ed esercitata (1).
12.
L'invenzione della Logica e della Dialettica, che riguarda il ragionare vestito di parole, secondo le notizie che ci pervennero, è dovuta all'Italia. Zenone d'Elea nella Lucania (1), il primo forse tra' filosofi che scrivesse il dialogo, introdusse quella maniera rigorosa e coerente di disputare, di dimostrare, di difendere e d'impugnare, che procede per via di regole e di principi precedentemente stabiliti. E appunto da quest'epoca, in cui la Dialettica fu trovata (secolo V avanti Cristo) incominciò quel progresso regolare delle scienze, e quello sviluppo ordinato dello spirito umano, che non interruppe di poi mai più il suo filo, ma trapassando per tutte le più strane e le più crudeli vicende della società, lo condusse fino a noi, e lo condurrà fino agli ultimi uomini, se non si distrugga prima quella scienza dialettica che lo rende immortale.
13.
Dall'Italia questa scienza passò in Grecia, dove ricevette la sua perfezione, e diede a quelle scuole filosofiche tanta vita e tanto calore, che si possono assomigliare ad altrettante palestre, in cui s'esercitava un'atletica del pensiero; e in quelle pugne intellettuali, tutte a regola e a misura d'arte, fu educata robusta, ardita, destra e moltiplice la mente greca, onde non ci fu mai alcun'altra nazione, tra le gentili, che desse al mondo lo spettacolo d'una filosofia più ricca, più forte, e divisa in iscuole con tanta precisione definite, e con formole, volea dire, tanto incisive.
14.
La dottrina dialettica che aveva educati i filosofi della Grecia, come altrettanti atleti del mondo intellettuale, e che s'era perfezionata ella stessa in questi esercizi ginnastici, trovò quivi stesso un uomo singolare, che la raccolse con somma sagacità e straordinaria esattezza e pazienza, e la consegnò in libri, che, trionfando delle ingiurie de' tempi, giunsero fino a noi; non è necessario dire, che quest'uomo è Aristotele. Gli originali suoi scritti passarono a Teofrasto, che Aristotele fece suo successore nella scuola, ed erede della sua biblioteca, e da Teofrasto gli ereditò Neleo di Scepsis nella Troade. I discendenti di questo molto tempo appresso li vendettero guasti dall'umidità e dalle tignole a caro prezzo ad Apellicone di Téos che ne moltiplicò gli esemplari assai scorretti. Finalmente Silla, presa, nell'anno 85 prima di Cristo, Atene, trasportò in Italia la biblioteca d'Apellicone, e il grammatico Tirannione diede ordine a buona parte di que' libri. Andronico poi di Rodi avendoli da lui, ci lavorò pure intorno, e ne comunicò al pubblico altri non pochi esemplari (1).
15.
E difficile poter determinare con precisione quali sieno i meriti d'Aristotele nel perfezionamento della Logica (1).
Certo, egli trovò presti al suo lavoro molti materiali; poichè la scuola d'Elea e di Megara e sopra tutto Platone aveano usato con ogni sottigliezza del ragionamento, e scopertine tutti gli artifizi e gli andirivieni, sia per avviluppare l'avversario, sia per disciogliere i viluppi, e v' ha chi reputa che le stesse categorie sieno state fornite ad Aristotele da' suoi predecessori (2). Laonde quello che dice Giovanni Filopono, che Aristotele abbia il primo ridotta a scienza l'arte del ragionare, la quale prima di lui si usasse senza principio regole (3), crediamo doversi restringere alla teoria del sillogismo, che indubitatamente è invenzione di quell'acutissimo e perseverante ingegno, e Aristotile stesso a sè la rivendica (4).
(2) Vossio, De nat. Art. Log. IV, 8, § 3. — Alcinoe vuole che nel Parmenide e in altri dialoghi di Platone, sieno già adombrate le dieci Categorie (Instit. ad doctr. Platon. 8).— Boezio espone l'opinione di quelli che attribuivano le Categorie ad Archita Tarentino in questa maniera: Architas etiam duos composuit libros quos Καθόλους λόγους inscripsit, quorum in primo hæc decem prædicamenta disposuit. Unde posteriores quidam, non esse Aristotelem huius divisionis inventorem, suspicati sunt, quod Pythagoricus vir eadem conscripsis„set; in qua sententia Jamblicus Philosophus est non ignobilis: cui non consentit Themistius, neque concedit eum fuisse Archytam, qui Pythagoricus Tarentinusque esset, quique cum Platone aliquantulum vixisset, sed Peripateticum aliquem Archytam, qui novo operi auctoritatem vetustate nominis conderet (Præfat. l. I. Prædicam.). Lo scoliaste armeno David (Ed. Bekk. p. 50. 4.) dice che il titolo dell'Opera d'Archita fosse πρώτων τυπῶν. Simplicio poi, ora afferma che s'intitolasse περὶ τοῦ παντός (ib. p. 40 4.), ora che il titolo fosse περὶ τῶν καθόλου λόγων (ib. p. 33. A. not.). Ma tanto David quanto Simplicio citano Archita il Tarentino, e quest'ultimo dice, che Jamblico confrontò le dieci Categorie d'Archita con quelle d'Aristotele e ne mostrò le differenze e le ragioni di queste. Forse Aristotele alludeva ad Archiτa senza citarlo, quando nella Metafisica (1, 3) enumera i dieci principi de' pitagorici, pe' quali devonsi intendere i pitagorici posteriori. Poichè nominando poi Alcmeone di Crotona che visse essendo vecchio Pitagora, dice, che questi avea ammessi i principi contrari, ma non ancora definito quanti e quali fossero —V. Alessandr. Afr. in Metaph.
(3) Magnam item accessionem fecit ad artem disserendi quandoquidem ab ipsis rebus normas præceptaque secrevit; et demonstrandi rationem cum via instituit. Nam superioris memoriæ Philosophi demonstrare quidem, ac evidentibus probationibus uti sciebant, sed demonstrare, ac evidentes probationes conficere ignorabant, atque idem illis usuveniebat quod sutoribus, qui coria secare non queunt, calceis autem uti probe queunt. Philop. in vit. Arist.
(4) Aristotele parla sempre sfavorevolmente dello stato della dialettica prima che venisse lui a darle legge, ma il luogo più classico è quello con cui conchiude il libro degli Elenchi sofistici. Quivi dopo aver detto, che l'oratoria politica e l'altre arti s'erano avanzate un poco alla volta, aggiungendo quelli che venivano appresso, il che è facile, al poco che era stato inventato da prima, e che era il difficile; soggiunge, che all'opposto la dialettica non esisteva affatto prima di lui come arte. «Di questa trattazione della dialettica non c'era già parte di coltivato e parte no, ma non esisteva affatto nulla». Poichè i maestri precedenti «non credevano già d'istruire rettamente coll'insegnar l'arte e quelle cose che dall'arte si fanno, come se chi professasse d'insegnar la scienza d'evitare che dolgano i piedi, poi non insegnasse già come si deva tagliare il corame e come formare gli stromenti da riparare i piedi, ma desse invece molti generi di variati calzari: avrebbe giovato all'uso, ma non insegnata l'arte. Ora circa la Rettorica c'erano molte cose dette in antico; ma della maniera di fare i sillogismi prima non avevamo nulla che potessimo dire, ma abbiam faticato gran tempo cercando noi coll'esercizio». — ·Alessandro Afrod. attribuisce pure l'invenzione dell'arte sillogistica ad Aristotele, in I, Prior. 2, 3.
16.
Ma qualunque sia la parte che questa scienza deve alle meditazioni individuali d'Aristotele, certo è che il suo Organo rappresenta e raccoglie tutta l'arte di ragionare che ebbe mai il mondo antico; e questa rivocata a principi fissi e connessa e divisata nelle sue parti con una brevità precisa, e una sottigliezza maravigliosa, e l'incatenamento delle diverse proposizioni procede così stretto, che può esser chiamata la Matematica pura della Filosofia.
Nè altra opera importante scritta a modo di scienza pervenne a noi da quella età, a talchè l'Organo Aristotelico rimane il solo grande monumento di questa scienza, come Piramide nel deserto (1).
17.
A veder mio apparisce provvidenziale la coincidenza di questi due avvenimenti, l'Organo d'Aristotele portato da Lucio Cornelio Silla in Roma ne' suoi originali, e il Cristianesimo, che trova diffusi gli esemplari dell'Organo negli 85 anni trascorsi dalla presa d'Atene alla venuta di Cristo, ne' quali l'Organo potè essere studiato, commentato e spiegato pubblicamente in Atene da Cratippo di Mitilene e da altri peripatetici, e in Roma stessa da Nicola di Damasco e da Xenarco di Seleucia al tempo d'Augusto, sotto cui nacque Cristo. E di vero la Logica e il Vangelo sono due dottrine che in modo ammirabile s'accordana, si chiamano e reciprocamente si confermano: poichè tutti e due hanno per loro oggetto la verità; ma come il Vangelo dà agli uomini la Verità compiuta, così la Logica non ragiona che della verità formale, il che però basta a poter esser chiamata essa pure con S. Agostino scientia veritatis (1).
Certo era stato tutto preordinato dalla Provvidenza alla più celere e più stabile diffusione del Vangelo. Come a questo intento dovea servire la vastità dell'Impero romano e la diffusione della sua lingua, così pure era necessario, che gli uomini che doveano ricevere, conservare e difendere la dottrina evangelica, possedessero l'Organo del ragionamento. Il popolo romano era già dotato per natura d'un pensiero retto e logico, e questa potenza di pensare solidamente era stata non ultima delle cause, che avean formata la sua grandezza. Chè sempre accade, che per la forza prevalente del pensiero una nazione imperi alle altre, come un individuo acquista per essa una superiorità sugli altri; e là dove si affievolisce il valor della mente, il che avviene ordinariamente pe' viziosi costumi, anche la prosperità, lo splendore, la grandezza, l'indipendenza, la libertà delle nazioni irreparabilmente declinano. Non è dunque a maravigliare, che Cicerone chiamasse massima l'arte del ragionare, ed eloquentemente ne celebrasse la morale e civile importanza (2).
(2) Attulit (Servius Sulpicius) hanc artem omnium artium maximam; quasi lucem ad ea, quæ confuse ab aliis aut respondebantur, aut agebantur. Dialecticam mihi videris dicere, inquit. Recte, inquam, intelligis. Brut. c. XLI. — Dialectica habet rationem, ne cui falso assentiamur; neve unquami captiosa probabilitate fallamur; eaque quæ de bonis et malis disserimus, ut tenere tuerique possimus. Sine hae arte quem vis arbitramur a vero abduci fallique posse. De fin. c. XXI.
18.
Poichè dunque in Roma fu posto il centro del Cristianesimo e la sede del sommo sacerdozio, dore le menti e per natura e per scientifica disciplina erano acconce al ragionare; si strinse fin da principio una federazione utilissima e maravigliosa tra il Cristianesimo e la scienza dialettica, e quello armato di questa potè combattere anche col discorso il paganesimo e l'eresia, e gli errori più cavillosi, e snidarli dagli ultimi loro ritiri, dove più tentavano nascondersi con argomenti sofistici, che pareano inestricabili. E alle distinzioni logiche, il dogma stesso andò in parte debitore di quelle sue forme così precise, e de' vocaboli, di cui fu rivestito, così propri. Laonde scrivea un Padre della Chiesa, che coll'arte dialettica si rovesciava ogni dottrina per versa, per quanto ella paresse robusta (1). Alla qual arte si formarono i Padri della Chiesa, e gli scrittori ecclesiastici che riuscirono così stringenti ragionatori e difensori invitti dell'evangelica verità, e Agostino stesso confessa, che si crederebbe ingrato, se non confessasse di quanto egli andava debitore allo studio dell'arte dialettica, di cui pronunzia questo magnifico elogio: Dialectica, disciplina disciplinarum: hæc docet docere; hæc docet discere; in hae se ipsa ratio demonstrat, atque aperit, quid sit, quid velit, quid valeat (2).
(2) De Ordin. II, 45. — Vedi ancora ciò che questo gran Padre osserva sulla dialettica, in Crescon. I, 15; in Acad. III, 3; Confess. VIII, De doct. Christ. II, 38.
19.
Ma come la Logica ha una affinità strettissima col Cristianesimo (1); così, congiunta a questo, ella si mantenne più durevole nella società, e nella coltura degli uomini. Il perchè quantunque gli sciami de' barbari, che come onde accavalcate le une sulle altre piombarono e ripiombarono sull'Europa, rovesciassero la mole del romano Impero, distruggessero tutte quasi le altre scienze e l'arti gentili; tuttavia furono impotenti a sveltere la Dialettica che ebbe sempre cultori, riparata nel sicuro asilo del Santuario.
E come essa si trovava raccolta nell'Organo d'Aristotele, così questo, almeno in alcuna delle sue parti, fu sempre studiato e intorno a questo studio e a quello della Teologia, a cui andava intimamente congiunto, si raggrupparono quasi a tavola di sicurezza, que' brandelli delle antiche scienze disperse, che si salvarono nell'universale naufragio dell'umana coltura. Così se non si salvaron le intere scienze, si salvò nondimeno il vigor delle menti, dalla dialettica esercitate: e le menti robuste possono quando che sia riprodurre le scienze. Laonde la Dialettica, riparata sotto l'ali della cristiana Teologia dalla violenza della barbarie, non solo impedì che non si spegnesse mai nè anche per entro ai secoli più oscuri ogni lume di cognizione e di scienza, come parea dovesse avvenire; ma a questo sacro fuoco, passato quel tempo di tumulti e di desolazioni, poterono poi riaccendersi facilmente le facelle delle altre scienze oppresse dal turbine, e il mondo così riebbe in picciol tratto di tempo un nuovo e più magnifico incivilimento, quasi direi di più puro e generoso sangue, non figliato dalla gentilesca confusione delle menti, ma ingenerato dal connubio di quelle due fonti di verità purissima, la verità dialettica e la cristiana.
20.
E potea forse la Dialettica sola reggere all'urto che scoteva dai fondamenti l'antica società? Fuori del Cristianesimo, colle sole forze che traea dalla sua profana origine, non pare che avrebbe potuto reggere a cotant'urto. Di che è prova questa che i soli sacerdoti ed i monaci la raccolsero derelitta e la coltivarono a vantaggio del cristianesimo, onde senza la Chiesa, sarebbe rimasta come uno esposto, mangiato da' cani. Oltre di che come potea avere bastevoli forze a mantenersi contro all'universale barbarie, essa, che prima non avea potuto resistere alle passioni de' suoi cultori, i quali la disciolsero colle armi de' cavilli prese da lei stessa? Onde la profana filosofia fini ne' primi secoli dopo Cristo in quello scetticismo, che è il sepolcro della stessa dialettica, e, chiuse nel 529 le scuole in Atene, si può dire non fiatò più. Chè la scuola profana d'Alessandria, di così poca vita anch'essa, non era per avventura dialettica, ma entusiasta, e non tirò avanti quel breve spazio, se non respirando un po' dell'aria nuova e vitale, che effondeva il Cristianesimo, contro il quale poscia cozzando interamente peri. Laonde se il decreto di Giuliano, l'Imperatore filosofo, che proibiva a' cristiani gli studi della Filosofia, avesse potuto durare, quel solo decreto avrebbe diffuso sul mondo di gran lunga più fitte tenebre, che non tutte le invasioni barbariche.
21.
Alcuni superficiali e retrivi si odono ancora ripetere le declamazioni degli Enciclopedisti contro il linguaggio barbaro e spinoso della Dialettica scolastica. Si mostrano costoro forniti, a dir vero, d'una grand'opinione di se stessi; ma affatto stranieri alle lettere greche. Poichè qualora in queste si fossero un tantino esercitati, dalla lettura de' migliori dialettici del medio evo trarrebbero non picciol diletto anche per questo, che parrebbe loro di essere trasportati in Atene, nel mezzo appunto di que' filosofi, che all'età di Platone e d'Aristotele con tanta vita intellettuale esercitavano le dialettiche pugne. Infatti la lingua della scuola è tutta letteralmente greca, e non latina appunto per questo che è troppo greca; le sue frasi sono quelle né più né meno, che ne' libri d'Aristotele si contengono (1), frasi brevi, efficaci, precise, armi affilate, necessarie ad un forte e serio certame della verità coll'errore, dell'argomento col sofisma. Vero è che non essendo state queste maniere della greca filosofia latinizzate all'età di Cicerone, perchè allora i libri d'Aristotele non erano bastevolmente conosciuti (2), fanno afa a quelli, che ripongono la cima del sapere nella purità e nella schiettezza della lingua romana. Ma chi considera quanto valore avesse per l'uman genere il vero, e l'arte, con cui la mente s'agguerrisce e lo trova, e lo difende, acciocchè non perisca; non potrà a meno di reputare degni di somma lode coloro che nel naufragio irreparabile del sapere, della coltura e della lingua stessa, intesero a salvare la logica disciplina legandola alle greche formole rigorose e sicure, senza badare ad altro, come sogliono fare appunto i navigatori in tempesta, che col gitto dell'altre merci salvano in piccolo astuccio le gioie più care.
La Dialettica dunque si può chiamare la cittadella dell'altre scienze, come la chiama con felice imagine uno scoliaste d'Aristotele (3): e pel corso di mille anni, le armi de' barbari sorde alla ragione ed alla pietà, non poterono espugnarla. E in fine esse stesse, l'armi, rimasero vinte dalla ragione perseverante. Laonde alla Dialettica, per dirlo di nuovo, alla quale il Cristianesimo somministrò una materia degna di lei perchè divina, l'Europa va debitrice della sua presente civiltà.
(2) Plutarco osserva, che gli antichi peripatetici non aveano una cognizione molto estesa ed esatta degli scritti d'Aristotele e di Teofrasto; e lo stesso afferma Strabone (L. XIII), che asserisce pochi de' libri di Aristotele essere stati conosciuti da' più antichi peripatetici, e quelli che fiorirono più tardi, averli ricevuti già guasti non poco.
(3) Τοῦτο δὲ πάντως ὅλον τέμενος ή Αριστοτέλους φιλοσοφία, ἡ δὲ λογικὴ τοίχου δίκην φρουρεῖ. David ed. Bekker, p. 26. Β.
IV: Danni venuti dalla decadenza della logica
22.
Ma la suprema importanza della Logica è riconfermata da un argomento contrario, sulla fine appunto del medio evo. Diragioni, tra le quali il risorgimento frettoloso, per cause improvvise, degli studi d'umane lettere, e la falsa riforma di Lutero, poterono quello che non aveano potuto i barbari, cioè fare scadere in tutte le scuole lo studio della Logica.
Gli umanisti rifuggivano inorriditi dagli spineti della Dialettica (1): i protestanti temevano l'Organo d'Aristotele, onde niente omisero per iscreditarne lo studio. E nell'uso stesso che si facea della Dialettica nelle scuole, s'erano introdotti gravi difetti e infiacchita l'alacrità de' maestri, addormentando il pensiero sul comodo guanciale dell'autorità. Quai tempi corrisposero a un tale avvenimento? Noi li abbiamo sott'occhio: il mondo degli spiriti si oscurò e confuse: la società perturbata non intese più se stessa: la grandezza intellettuale e morale dell'uomo s'impiccolì, la vanità s'aumentò, la Filosofiɑ, perduto il suo vigore e ogni sublimità di concetto, rimbambì nel sensismo, ed anzi, quasi direi uscita dalle rotaie, si fracassò nel materialismo, nell'utilitarismo, nell'ateismo, nel panteismo, nel comunismo e nel nullismo. Veramente l'Europa è inondata di giornali, milioni di pensatori vi hanno trasfusa la loro scienza. Poveri pensatori! e quale scienza! Non furono così confuse le lingue al tempo di Nembrotte. Pure la pretensione non ha limiti come non l'hanno la sconnessione, l'incoerenza, la superficialità, le stravaganze, gli assurdi. Non è a sperarsi che l'ingegno umano riprenda la traccia perduta, e gli uomini ritrovino la concordia con esso la verità e la pietà, se lo studio della Logica non riprenda l'antico vigore.
23.
Si risponderà che non ostante tutto ciò, contemporaneamente alla decadenza delle scienze morali e sociali e all'impoverimento del buon senso, ebbero luogo immensi progressi delle scienze materiali. Non vogliamo nè possiamo negarlo, ma il fatto si spiega in questo modo. Due maniere di Logica si distinguono, l'universale, e la speciale: la prima raccoglie i principi universali ed i modi di ragionare comuni a tutte le materie; la seconda raccoglie de' principi e de' modi più speciali dalla considerazione d'una speciale materia (Cosc. mor. 2, 4). Ora sul finire dell'età di mezzo, gli uomini sentirono un gran bisogno di darsi allo studio delle cose naturali, per istrappare alla natura que' secreti, senza la cognizione de' quali non avrebbero potuto ristorare i danni della barbarie, e racquistare uno stato sociale florido, e un vivere agiato. Nè a soddisfare a questo loro bisogno bastava la Logica universale d'Aristotele, nè questa, come dicevamo, si trovava nelle scuole in buona condizione, ma legata soverchiamente a forme convenzionali o autoritative. Tuttavia gl'ingegni erano già fatti robusti e vigorosi, perchè l'antica Logica gli avea segretamente fortificati in quel lungo corso di secoli, che avea regnato nelle scuole. Quando dunque abbandonarono l'antica scienza della Logica, perchè pareva infeconda, essi ebbero la coscienza di poter andare da sè, per l'Arte che loro tuttavia rimaneva, e così persuadendosi d'andar più liberi, volsero gl’ingegni, con una fresca energia, alla natura, ricca di tesori e quasi ancor vergine. Le scoperte crebbero il desiderio e la speranza d'altre scoperte. Dal qual movimento ricomparvero nuove arti utili alla convivenza. Ma in questi stessi esercizî e sforzi, s'accresceva agl'ingegni l'Arte del pensare, che già possedevano, quasi direi, senza la scienza, e quindi si vennero ancora formando, senza pure avvedersene, una Logica speciale delle cose naturali, di cui presso di noi il Vinci ed il Galileo fecero un uso così stupendo e così felice, e di cui il Bacone in Inghilterra raccolse alcuni precetti, pubblicandoli col titolo di Nuovo Organo (1).
V: Imperfetta ristorazione della logica tentata dal Bacone
24.
Nel Nuovo Organo del Bacone si vede quanto s'era dimenticata la Logica universale: tutta la critica che egli fa ad Aristotele appalesa una cognizione superficialissima della dottrina che vuole impugnare, come dimostrò il severo ma sagace Giuseppe de Maistre (1).
Francesco Bacone, che prometteva dare al mondo un Nouvo Organo, non dava che una sconnessa raccolta di precetti spettanti alla Logica speciale della natura. Tutti sanno, che nel secolo scorso fu fatta al Verulamio una celebrità a mano, di cui rimane la memoria, unicamente come una prova di più della debolezza dello spirito umano e della vanità de' semidotti, la turba de' quali aggiunge grida che assordano, alle prime grida. Ma il Bacone, sterile egli stesso, risvegliò in qualche modo gli spiriti, eccitandoli agli studi naturali non con una scienza logica, ma con immense promesse, avvivate da uno stile immaginoso e figurato, a quel modo che può fare un poeta o un oratore.
Tali studi dunque per tutte queste cause rifiorirono ne' tempi moderni, e non sarebbero fioriti se i loro cultori, co' rimasugli dell'antica Logica, non avessero potuto formarsi mano mano da se stessi una Logica speciale e pratica della natura. Certo questa stessa, dicevo, non se l'avrebbero potuta formare, se non ci fosse stata prima e a lungo nelle scuole la Logica universale d'Aristotele, benchè poi gran parte d'essi la dispregiassero, come fa il cattivo fanciullo adulto che dispregia la vecchia sua madre.
Volendosi dunque dire il vero, la Logica d'Aristotele nello stesso spegnersi non cessò d'esser benefica, chè quando patì la sentenza d'ostracismo dalle scuole d'Europa, ella lasciò, qual sua prole, la Logica della natura, piuttosto conservata nelle menti e praticata nell'esperienze, che scritta ne' libri; poichè l'Organo del Bacone, lo ripeto, non la contiene nè intera, nè precisa, nè sicura. Ma dalla sua universalità ridotta la Logica in così breve cerchio, non rimanendo più di essa che una forma di speciale applicazione, si trovò inetta a sostenere le dottrine più universali di cui abbisogna la vita intellettuale e morale dell'uomo; e però le umane menti di subito apparvero indebolite, e le persuasioni scosse, e il discorso confuso e vacillante, e i principi immutabili tratti in dubbio, e l'evidenza stessa negata, le cose umane e le divine perturbate.
25.
La scienza antica della Logica universale era venuta meno: ma quello che dee ancor più stupire, sono i vanti che i novi sapienti si davano d'ignorarla. Si riputava un segno certo ed infallibile della superiorità dell'uomo progressivo e filosofo il dare de' morsi rabiosetti in quella Logica aristotelica che s'ignorava. Il Condillac in un libro, che osò pure d'intitolar Logica, toccando un poco della natura del sillogismo, che è la forma rigorosa e inevitabile d'ogni ragionare, soggiunge: NOUS NE FAISONS AUCUN USAGE DE TOUT CELA (1). E il sig. Lasalle traduttore e annotatore di Platone, tratta Aristotele con questi modi, e sono modi comuni agli scrittori di quel tempo: EN LAISSANT DE CÔTÉ LE BAVARDAGE D'ARISTOTE (2). Col rifiuto del sillogismo, e col dispregio del linguaggio rigoroso, qual è quello d' Aristotele, (e il dispregio è il surrogato, che i moderni diedero all'autorità!) che cosa ne doveva avvenire? L'abolizione della ragione umana, quando si procedesse di coerenza, e questo frutto si maturò veramente in Germania dal Kant all'Hegel. Disarmata dunque la mente e privata dell'organo universale del ragionare, si videro le più forti intelligenze cadere, e non avvedersene, in paralogismi e in contraddizioni da fanciulli, tosto che uscivano dalla sfera delle scienze naturali, e basti citare in esempio un grande calcolatore (poichè vogliam prendere gli esempi dagl'ingegni migliori), il conte di Laplace. Quanto non è egli facile il cogliere quest'uomo in fallaci ragionamenti ogniqualvolta abbandona il meccanismo del calcolo? La sua Teoria filosofica delle probabilità n'è la prova più lampante.
È dunque necessario riconoscere il voto immenso che lo scadimento della Logica e della Dialettica lasciò nel mondo intellettuale: ed è necessario rinunciare a quella vanità, divenuta oggimai ridicola, che versava un dispregio insipiente su quella Logica ch'era stata la maestra de' secoli, e l'educatrice degl'ingegni stessi che contro lei s'abusavano: è necessario che la Logica universale, come scienza, riprenda il suo posto e ne rifiorisca lo studio, che le menti ricuperino la loro guida, abbandonata la quale l'uomo va palpando le tenebre, e finirebbe forse coll'andar carpone. E quantunque noi non siamo da tanto, tuttavia abbiamo scritto il presente libro a questo intendimento di eccitare i filosofi alla ristorazione della scienza dell'Arte di ragionare.
(2) OEuvres, t. II, p. 341. — Già i maggiori uomini dell'antichità rimproverarono ai materialisti e ai sensualisti de' loro tempi l'ignoranza e la presunzione ne' giudizi e il dispregio degli altri. Aristotile parlando Ippone lo dice de' filosofi φωρτικωτέρον (De An. I, 2). Cicerone introducendo a parlare Caio Velleio epicureo, gli dà il carattere proprio di tali filosofi quando dice: Tum Velleius fidenter sane, ut solent ipsi, nihil tam verens quam ne dubitare aliqua de re videretur; tamquam modo ex Deorum concilio et ex Epicuri intermundiis descendisset ecc. (De N. D. I, 8). E osserva oltraciò, che gli Epicurei non avendo nulla d'elevato nel loro pensiero, nulla aveano nè pure d'elegante e d'eloquente nel loro parlare, onde li chiama or minuti, or plebei. Licet concurrant plebei omnes Philosophi (sic enim ii qui a Platone et Socrate et ab illa familia dissident, appellandi videntur) non modo nibil unquam tam elegantef explebunt: sed ne hoc quidem ipsum quam subtiliter conclusum sit, intelligent (Tusc. 1, 25. Cf. De N. D. II, 17, 50, 65).
VI: Partizione dell'organo d'Aristotele
26.
Nel qual lavoro dobbiamo prima di tutto far conoscere qual via abbiamo seguito.
Già dal detto fin qui il lettore intende, che noi non possiamo far capo che all'Organo d'Aristotele come all'unico grande monumento che esista di logicale dottrina. Ma contando quest'edifizio ventidue e più secoli d'esistenza, benchè il vero che contiene sia sempre giovane, tuttavia le forme delle quali è rivestito, non possono esser tutte accomodate alla presente età, nè i centinaia di Scoliasti e i pensatori originali che fiorirono dopo lo Stagirita, devono essere stati inutili, nè tampoco si vuol credere che l'ingegno umano, di natura sua sempre operoso, non abbia raccolto nulla nel lungo suo corso, non sia divenuto almeno più analitico e più ricco. Non sarà dunque riputato temerario il proposito, o immodesta la speranza d'accrescere e di modificare utilmente l'opera antica.
Nondimeno prima d'esporre il disegno del presente lavoro conviene che esaminiamo brevemente l'Organo Aristotelico e ne facciamo un'equa critica, la quale giustifichi le variazioni nostre e le aggiunte.
27.
Noi crediamo, che Aristotele prima di scrivere il suo Organo non abbia punto tracciato la regolare distribuzione delle sue parti; ma che sotto la parola Organo si deva intendere una collezione di trattati diversi, scritti in tempi diversi, riguardanti questioni particolari. Nondimeno in questa collezione troviamo qualche ordine, e ciò per la ragione che quegli scrittori che hanno una mente bene ordinata e possedono la scienza con una certa interezza, imprimono l'ordine nelle opere loro, e nel complesso di esse, anche senza aver avuto da principio un piano generale, o averlosi proposto. Vediamo dunque anche noi, dopo tant'altri, d'investigare qual posssa essere l'ordinata disposizione de' trattati Aristotelici spettanti alla logica disciplina.
28.
Tre operazioni assegna Aristotele allo spirito umano, colla prima la mente apprende il semplice, e questa facoltà o atto è da lui chiamato intelligenza. La seconda è il giudizio, che unisce una cosa coll'altra affermando o negando, e la terza raziocinio, col quale da una cosa conosciuta se ne raccoglie un'altra mediante una terza di mezzo. L'Organo dunque si divide naturalmente in tre parti: trattati che versano intorno alla prima operazione, trattati che versano intorno alla seconda, e trattati che versano intorno alla terza.
29.
Gli Scoliasti attribuiscono le Categorie alla prima operazione, e i libri dell'Interpretazione alla seconda. Forse quest'opinione è loro venuta da questo, che, atteso il disordine in cui furono pubblicate da Tirannione e da Apollonio da Rodi, le opere aristoteliche, parve loro che non restasse altro libro che trattasse della prima operazione, e però s'appigliarono a quello delle Categorie, che, secondo lo scoliaste David «è intorno a semplici voci significanti semplici cose per via di semplici intellezioni (1)». Ma se si riguarda non tanto il titolo del libro, quanto il contenuto, non sarà difficile a persuadersi, che le Categorie e i libri dell'Interpretazione riguardino egualmente la seconda operazione dello spirito, cioè il giudicare, e che i trattati aristotelici intorno alla prima operazione, che è quella delle idee, che sono alla Logica quasi materia, più probabilmente stanno tra i Metafisici. I quali non paiono formare un'opera sola, ma piuttosto essere un affastellamento di vari scritti accozzati insieme più a caso che a ragione, e alcuni di essi sono logici, anzichè metafisici.
Nella qual sentenza io sono venuto per le ragioni seguenti.
Il libro delle Categorie analizza il giudizio in se stesso, al che si continuano i libri dell'Interpretazione che lo analizzano espresso in parole, e danno le regole per conoscere la verità e la falsità delle proposizioni e per evitare le false intelligenze. E rispetto a questi ultimi nessuno mette in dubbio che la cosa sia così; riguardo poi al libro delle Categorie, benchè si considerino gli elementi del giudizio in separato, tuttavia non vi si tratta della semplice operazione che fa lo spirito coll'intuire le idee; ma le categorie non sono altro che sommi predicati, cioè elementi del giudizio ridotti a dieci generi; e vi si considera la relazione o le relazioni varie che ciascuno d'essi può avere ccl suo subietto. E da prima s'accennano in quel libro i tre modi co' quali si nominano le cose, l'equivoco, l'univoco e il denominativo, poi, distinte le cose che si dicono semplicemente, come ne' singoli vocaboli, da quelle che si congiungono, come nelle proposizioni, si passa a parlare de' modi di questa congiunzione, cioè delle relazioni tra certi predicati e certi subietti. I quali modi si riducono a quattro; e sono, che 1º certe cose si predicano del subietto e non sono nel subietto; 2° altre sono nel subietto, e non si predicano del subietto; 3° altre e si predicano del subietto e sono in esso; 4° altre poi ne sono nel subietto, nè del subietto si predicano. Dopo di che si danno due regole che insegnano a trovare o ad escludere certi predicati. Appresso si distinguono i dieci predicati generici e loro si applicano le quattro relazioni indicate de' predicati co' subietti e le due regole e i tre modi di nominare: si paragonano i predicati tra loro rispetto allo stesso subietto, e si mostra come o riescono opposti o d'una priorità logica, o simultanei: e in ultimo si accenna in quanti sensi si può predicare il moversi, e l'avere. Tutto questo libro dunque ha per iscopo l'analisi del giudizio.
Che se vi si trattasse de' semplici intuiti dalla mente, ne mancherebbe la parte principale che è la dottrina dell'essere e de' suoi astratti elementari: e di più vi si parlerebbe del verbo e non del solo nome, chè secondo Aristotele il verbo indica un semplice altrettanto quanto il nome (2). Il che osservarono gli stessi scoliasti, cavandosela col dire, che del verbo tratta nell'opera dell'Interpretazione (3).
L'Ideologia dunque aristotelica, che è la scienza che versa intorno alla prima operazione, è da cercarsi altrove. Ne' libri perduti περὶ εἰδῶν, ο περὶ τἀγαθοῦ, ὁ περὶ φιλοσοφίας (4) esposte si trovano certamente quelle questioni, che s'agitavano nella scuola di Platone intorno alla dottrina delle idee (5). Ne' libri che noi abbiamo sotto il titolo di Metafisici, si parla della natura della scienza e della sapienza e delle idee, e si propone un'innumerevole serie di distinzioni concettuali, che costituiscono appunto la parte dirò così materiale della Logica. Diogene Laerzio parlando della Logica Aristotelica, dice, che questo filosofo le assegnò due scopi il persuasivo (τὸ πιθανόν) e il vero (τὸ ἀληθές), e assegna al vero l'Analitica e la Filosofia (6). I quattro libri «Degli Analitici» ci rimangono. Ι libri poi della Filosofia si trovano citati da Aristotele stesso (7), da Cicerone, e da altri, ma ommessi con questo titolo nel catalogo Laerziano. Essi dunque, secondo il cenno che ne dà lo stesso Laerzio, vogliono considerarsi come appartenenti all'Organo (8), ed essi certo riguardavano la prima operazione, cioè l'intuizione delle idee, ossia la semplice intelligenza. Alcuni eruditi moderni pretendono, che i medesimi tre libri «Della filosofia» sussistano tuttora tra i Metafisici, ma discordano nel definire quali sieno, volendo Samuele Petit riconoscerli nel M, N, Δ (XIII, XIV, XII), e parendo al Titre più probabile, che sieno A, K, Λ (I, XI, XII). Il Trendelenburg all'incontro congettura, che nel Catalogo di Laerzio sieno indicati i nostri XIV metafisici, sotto il titolo ἐξηγούμενα κατὰ γένος τέτταρα καὶ δέκα, e in un indice anonimo citato dal Menagio (9) sotto i titoli μεταφυσικὰ κ' ἐξηταςμένων κατὰ γένος ιδ (10). Comecchessia la cosa, i libri che ci rimangono della Metafisica appartengono in parte alla Ideologia e alla Logica trattandosi d'idee e di distinzioni concettuali, oggetto della prima operazione della mente (11).
(2) Categ. c. I.
(3)« Ma poichè e il nome per sè ed il verbo sono voci semplici significanti semplici cose per mezzo di semplici intellezioni, intorno al « nome ed al verbo ricerca non qui, ma nel περὶ Ἑρμηνείας, e lo scopo «del libro delle Categorie è intorno alla posizione prima delle semplici voci significanti semplici cose per mezzo di semplici intellezioni. Poichè coloro, che per convenzione posero ab antiquo i nomi, nominarono tal cosa uomo, tal altra, poniamo, cavallo, tal altra corre, tal altra vince, non distinguendo inoltre quali significhino tempo e quali no, e si chiamano questi nomi di prima posizione, per l'essersi nominate così semplicemente le cose. Essendo poi sopravvenuti altri, quante parole trovarono significanti ancora tempo, chiamarone verbo, quante non significanti ancora tempo, chiamarono nome». David, ed. Bekk., p. 29.
(4) V. De perditis Aristotelis libris de ideis et de bono s. philosophia, Diatribe Acad. C. A. Brandis. Bonnæ, 1823.
(5) Il Trendelenburg, Platonis de ideis et numeris doctrina ex Aristotele illustrata. Lips. 1826, p. 3 not. congettura che a questi libri si riferisca quel di Plutarco ὡς Αριστοτέλης ἐν τοῖς Πλατωνικοῖς εἴρηκε. Adv. Colot. p. 1118, ed. Francof.
(6) L. V, 3. 28. — Cf. Arist. Metaph. III, 2, dove Aristotele dà alla Dialettica e alla Filosofia lo stesso oggetto, ma dice che quella «tenta ciò che questa conosce» ἔστι δὲ ἡ διαλεκτικὴ πειραστική, περὶ ὧν ἡ φιλοσοφία πειραστική; e quest'oggetto è l'ente come ente. Ma poichè Aristotele componeva le specie stesse colla materia, dal qual composto facea risultar la natura, così egli non ebbe propriamente un'Ideologia, ma anche i suoi libri della Filosofia doveano trattare dell'ente senza separazione delle due forme, mescolando insieme, come fa per tutto, le considerazioni intorno al reale, ed altre astratte e puramente razionali.
(7) De An. I, 2; e De gen. Anim. II, 3, se pure le διαιρέσεις di Platone nominate in quest'ultimo passo sieno lo stesso che l'opera di Aristotele «Delle scuole Platoniche» come opina Alessandro Afrodisio, e Filopono, e però lo stesso ancora co' libri «Del bene» secondo il Brandis (De perditis Aristot. libris etc. p. 12, 13); benchè il Trendelenburg (Plat. de ideis. p. 49, 20) s'allontani da questa sentenza; parendogli che Aristotele a quel luogo faccia solo allusione a υn passo del Timeo, p. 35. È anche da notarsi che nel Catalogo di Diogene è registrato un libro col titolo di Διαιρετικόν.
(8) Dice Diogene, che Aristotele non isvolse la Logica sotto tutti gli aspetti, ma come organo del pensare Οὗ τὸ λογικόν, οὐχ ὁλομερῶς, ἀλλ' ὡς ὄργανον προσηκρίβω μόνον. V, 5, 28. Altri nondimeno pretesero che all' Organo originalmente non appartenessero, che gli Analitici. V. l'Organo pubblicato da Th. Waitz, Lipsia 1846 I. II, p. 293 segg.
(9) Ad Diog. Laert. V, 35.
(10) Plat. de ideis etc., pag. 10 not., dove anche si fa osservare che Alessandro Afrodisio, quasi coetaneo di Laerzio, scrisse de' commentari sui XII libri De prima philosophia, che sono i nostri primi XII metafisici.
(11) Anche alcuni credono che i due primi libri Della filosofia (il XIII e XIV della Metafisica) fossero intitolati περὶ ἰδεῶν. V. Ch. L. Michelet, Examen critique de l'ouvrage d' Aristote intitulé Metaphysique Paris 1836, pag. 66 e segg.
30.
Per quanto poi spetta alla terza operazione, cioè al raziocinio, la sua forma esplicita più semplice è quella del sillogismo. Ora un celebre scoliaste dice, che Aristotele distinse cinque maniere di sillogismi, l'apodittico, il dialettico, il sofistico, il rettorico e il poetico, secondo la qualità delle premesse, poichè queste, dice, o sono del tutto vere e fanno l'apodittico, a del tutto false e fanno il poetico, il favoloso, o per un lato vere, per un lato false, e questo in tre modi; stante che o si sta più nel vero e meno nel falso, e si fa il sillogismo dialettico, o il falso soverchia il vero e si fa il sofistico, ovvero ha un'egual ragione il vero col falso, e si fa il rettorico (1). Ora del sillogismo apodittico sono i quattro Analitici, del dialettico i Topici, del sofistico gli Elenchi, del rettorico e del poetico i libri della Rettorica e della Poetica.
Tale è l'Organo d'Aristotile, se pur non si vuole recidere da esso queste ultime due opere. Ma se si considera quello che dice Alessandro, che Aristotele usò la parola Dialettica in un senso più ampio che non avea fatto Platone (2), si vedrà che se queste due opere non appartengono alla Dialettica, certo ad essa si continuano. Poichè in Grecia la Dialettica fu sempre mescolata coll'Eloquenza, di cui formava il nerbo. Sottoponendo ora dunque questo gran lavoro alla critica noi crediamo di poter osservare intorno al medesimo quanto segue.
(2) «A noi sta bene di conoscere innanzi tratto, che il nome di Dialettica nol recano al medesimo significato tutti i filosofi: ma quelli della Stoa nel definire la Dialettica, la dicono una scienza di ben dire. — Platone, invece vantando il metodo divisivo, e dichiarandolo fastigio della filosofia, e avendo posto che sia sua opera il poter fare l'uno molti e i molti raccogliere in uno, — chiama cotesto stesso metodo appunto Dialettica. Aristotele e chi lo segue non avvisano così intorno alla Dialettica: ed ammettono bensì, che essa sia un metodo sillogistico, ma, reputano che i sillogismi, in quanto sillogismi, non differiscano punto l'uno dall'altro; ma che però ci sia tra di loro differenza nella specie delle proposizioni, e ne' modi e nelle figure e nella materia intorno a cui sono. E la terza differenza, quella nella materia, li fa altri apodittici, altri dialettici: — e quello che da' veri e da' propri al subietto e da' primi e da' noti più evidenti dimostra e raccoglie il subietto, si chiama dagli uomini sillogismo apodittico, dove quello che sillogizza da probabili dialettico, e dialettica la sillogistica che ne usa, e quello che da' probabili apparenti sofistico, e sofistica quella che gli adopera. — Ed a ragione un siffatto metodo si chiama dialettico; chè la dialettica è da διαλέγεσθαι, e il διαλέγεσθαι, che è conversare, consiste in domanda e risposta, e chi dimanda, dimanda intorno a qualunque cosa si metta avanti da chi risponde: affine che, per via della dimanda, pigli da lui comesisia materia da sillogizzare: in quanto però il sillogismo si sforza di concludere circa a ogni cosa proposta, non sarà da' veri: chè nè ogni cosa proposta è vera — per il che coloro che la trasferiscono ad altro significato non usano propriamente del nome della dialettica. E poichè ella è tale, a ragione Aristotele la dice (Rhet. § I.) essere corrispondente alla rettorica, chè anche cotesta è intorno al persuasivo, il quale per essere probabile, è appunto tale». Alex. Aphrod. Ad Top. proef. ed. Bekker p. 251, a, 15 seg.
VII: Critica dell'organo d'Aristotele
31.
Primieramente vedesi, che la maniera del concepire aristotelico è al sommo formale. Lo dimostra l'aver egli riposto tra i generi del sillogismo il sofistico, e come pretende lo Scoliaste citato, anche il rettorico e il poetico. Non vogliamo interamente biasimare questa classificazione, chè per fermo non si dee confondere il sofisma col paralogismo, potendo esser in quello giusta la forma altrettanto che nel sillogismo dimostrativo, quando il paralogismo peccando nella forma non può annoverarsi tra' sillogismi, onde non a torto distinse Aristotele tra il sillogismo che è sano di forma e di cui trattò negli Analitici priori, e il sillogismo che è sano di forma e di materia, di cui trattò negti Analitici posteriori. Significando dunque il vocabolo sillogismo la forma del ragionare, non manca al sofisma l'essenza del sillogismo, la qual manca al paralogismo. Ma nello stesso tempo da per tutto apparisce, che la mente del filosofo si mostra tanto intensa e fissa a considerare la forma del ragionamento, che la teoria di questa si presenta come la principale ne' suoi libri, e però rimane la materia negletta e tapina. Colla quale osservazione noi non neghiamo, che anche la sola forma del pensare inveschi colla sua purità e lucentezza la mente dell'uomo speculativo a tale, che, per amor d'essa, egli si compiace d'avvolgersi per tutti que' giri e meandri della Dialettica, e trattenervisi quasi come disse un antico, appresso gli scogli delle sirene (1). Ma in fine, poichè la verità del sillogismo risulta ad un tempo dalla materia e dalla forma, l'Organo aristotelico fu accagionato, non senza ragione, d'esser più idoneo a formare de' disputatori e degli avvocati, che degli amatori, cercatori, e propugnatori del solo vero. Nel che si vantaggia immensamente sopra l'indole della scienza aristotelica, lo spirito di quella del suo maestro. Chè Platone non divide mai la forma dalla materia, ma fa servire quella a questa, e la sola verità e realità delle cose è il termine fisso del suo pensiero. E in parte per questo, io credo che la Logica d'Aristotele dominasse nelle scuole fino a tanto che gli uomini, spogliati delle scienze e dell'arti dalla barbarie, sentirono il bisogno di difendere gli ultimi resti dell'antico sapere e il deposito della verità religiosa; ma quando poterono respirare, e videro venuto il tempo di rifornirsi di nova scienza, allora trovarono inefficace lo stromento aristotelico, e invece di perfezionarlo e arricchirlo, sdegnosamente lo spezzarono. Dal che noi ammaestrati, dobbiamo intendere in questa nostra Logica d'unire più accuratamente alla considerazione della forma quella della materia, e d'insegnare con diligenza la maniera di far servire quella a questa, precludendo, per quanto ci sarà possibile, l'abuso della nuda forma. Pigliammo dunque e inserimmo a suo luogo molte di quelle regole medie (Teod. 14) del pensiero a cui si abbatterono ne' moderni tempi gl'investigatori delle cose naturali e sociali, e distinguemmo le forme del raziocinio anche secondo le diverse materie. Così non limitandoci a dare solo regole universali, ma aggiungendovi le più speciali e prossime, ci parve d'assicurar meglio e d'agevolare l'uso di quelle a favore del vero. E non è già che anche le regole medie di cui parliamo, non sieno formali, considerate relativamente, ma sono forme più determinate, e però più vicine agli individui e di più facile e pronta applicazione a' reali; e queste determinazioni stesse si possono dire in qualche modo materia (noi la diremo materia logica) rispetto alla forma pura e universalissima.
32.
In secondo luogo, Aristotele non considera bastevolmente il pensiero schietto e senza involucri, ma persegue assiduamente e con somma diligenza il pensiero vestito de' vocaboli, e l'analisi da lui usata è quella stessa che già si trova fatta nel linguaggio comune. Nel che di novo si diparte da Platone. Ancora, in tutte le sue opere logiche mira, come scopo principale, a insegnare l'arte di dialettizzare sia ne' privati discorsi, ne' quali gli uomini difendono le proprie opinioni e cercano di persuaderle, sia ne' pubblici parlamenti, dove i partiti politici combattono coll'arme della parola. Ora quantunque il pensiero interiore proceda quasi indivisibile da' segni del linguaggio se non profferiti, almeno immaginati, tuttavia noi crediamo che la teoria logica conviene che s'innalzi al di sopra di questi fini ed usi speciali, e che distingua accuratamente queste tre cose:
1º La verità fuori delle forme soggettive;
2º Le varie forme soggettive del pensiero di che si riveste la stessa verità, e ne moltiplica gli aspetti all'uomo;
3º Le espressioni o segni, principalmente il linguaggio, che s'accomoda alle forme speciali con cui la verità si presenta alla mente del comune degli uomini.
E appunto perchè queste tre cose non ci sembrano nè sufficientemente, nè perpetuamente distinte nelle opere d'Aristotele, ci pare che riescano oscure, difficili, e di varia interpretazione (1).
33.
Da questo studio poi che pose Aristotele nella lingua, derivò alla sua dottrina un vantaggio ed uno scapito. Il vantaggio si è che essendo la lingua fissa e composta di segni sensibili, giova mirabilmente a legare le idee e a ridurre i precetti dialettici ad una specie d'Algebra. Lo scapito poi è, che l'analisi del ragionare che si trae dal linguaggio riesce ristretta, e quasi si può dire, grammaticale. Certo, essa conduce la mente a cercare le regole, secondo le quali si distingua dialetticamente il significato de' vocaboli, e quelle che insegnano ad accozzare parole a parole e proposizioni a proposizioni a modo d'argomento più o meno dimostrativo. Ma non aiuta la mente a investigare e rinvenire quelle altre regole che presiedono ad un ragionamento più esteso, all'incatenamento di più sillogismi, e in somma non dà un filo, col quale l'umana intelligenza possa fornir sicura un lungo viaggio, scoprendo verità, inventando, ordinando e perfezionando le scienze. I quali principi più elevati, coll'aiuto dei quali la mente misura d'uno sguardo un campo così vasto e in cui disegna nuove vie, sono quasi irreperibili nell'Organo di Aristotele.
34.
Per supplire al qual difetto noi abbiamo derivati non pochi di tali principî dalla dialettica di Platone e dagli esperimenti de' moderni, esponendoli nelle trattazioni del metodo dimostrativo, inventivo e didattico.
35.
In quarto luogo dobbiamo aggiungere, che l'Organo di Aristotele contiene bensì tutte l'armi necessarie per quella palestra, nella quale s'esercita il comune pensare degli uomini; ma difetta di quelle che sono dimandate da una tattica più elevata. E lo stesso andare d'Aristotele sempre rasente il linguaggio, non gli permetteva d'allontanarsi dall'analisi de' discorsi che il comune degli uomini suol fare, che ne' visceri stessi del volgare linguaggio sono quasi direi segnalati.
VIII: Sviluppo della logica corrispondente allo sviluppo del pensare umano
36.
Ora riguardo a questo scopo più elevato della Logica è da notarsi che si distinguono tre maniere di pensare, di cui parleremo, piacendo a Dio, diffusamente nella Teosofia; le quali si possono chiamare il pensare comune, il dialettico e l'assoluto. Di che procede che si distinguano tre parti della Logica, le quali acconciamente si direbbero Logica del pensare comune, Logica del pensare dialettico, e Logica del pensare assoluto. Delle quali la sola prima si rinviene pressochè compiuta nell'Organo aristotelico.
37.
Il pensar comune è quello, che usano comunemente gli uomini, anche scienziati, fino a tanto che non s'accorgono che la parte soggettiva che trovasi ravvolta in esso, e la sua limitazione, conduce alle antinomie;
Il pensare dialettico, che anche si può dir critico, incomincia quando l'uomo discopre queste antinomie, e dura fin a tanto che combattendo seco stesso, ne va tentando la conciliazione;
Il pensare assoluto finalmente è quello che concilia tutte le antinomie per modo, che non ne possano più nascere altre.
38.
Il pensare comune giunge certamente alla verità, ma ad una verità parziale, perchè o riguarda le cose finite o le concepisce in un modo finito e unilaterale. Questa verità è sufficiente ai fini che si propongono comunemente gli uomini. Quando il pensiero umano non è ancora uscito da questa sfera, egli produce de' sistemi filosofici che si possono dire immediatamente dogmatici.
39.
Ma poichè le cose in tal modo non sono riguardate dalla mente che da uno o più lati, e non da tutti, accade che le conseguenze, che scaturiscono un po' alla volta da tali imperfette conoscenze, vengano a collidersi tra di loro e sembrino altrettante contraddizioni.
La scoperta di questo fatto inaspettato, che da prima sgomenta colui che credea di possedere la verità in un modo pieno e assoluto, è dovuta a una riflessione superiore, e a questa noi diamo la denominazione speciale di pensar dialettico e critico. Quando la mente umana ci è arrivata, allora si manifesta una filosofia critica, cioè una filosofia che impugna il pensar comune. La critica poi del pensar comune produce al mondo de' sistemi d'indole diversa secondo le disposizioni in cui si trova lo spirito umano. Se la società è corrotta, sconcertato l'ordine pubblico, gli spiriti sogliono essere sfiduciati e rimangono sguerniti di forti persuasioni: allora la riflessione critica partorisce inevitabilmente lo scetticismo in tutte le sue forme e in tutte le sue gradazioni. In questi ultimi tempi Emmanuele Kant diede la denominazione di Critica alla sua Filosofia, e pretese che ella potesse tenere il luogo di mezzo, tra il dogmatismo e lo scetticismo. Ma se si considera che non può esserci nulla tra il conoscere la verità (non si tratta di conoscerne più o meno, ma semplicemente di conoscerne qualche cosa) e il non conoscerla, si vedrà che la pretesa del Kant di tenersi in un giusto mezzo è vana del tutto (Prelimin. all'opp. ideoll. 2-4). Questo filosofo negò alle forme logiche ogni valore per conchiudere qualche cosa dell'oggetto, con che toglieva ogni valore alla Logica antica: lasciò nondimeno sussistere nella sua ragione pratica il bisogno della verità (ed è quanto dire della verità oggettiva, perchè non ce n'ha alcun'altra), e pretese, che si potesse argomentare dal poter essere all'essere, pel bisogno che n'hanno le supreme tendenze dell'uomo. E noi non neghiamo che tale illazione, a certe condizioni, abbia valore, ma la prima condizione, alla quale può aver valore un'illazione qualunque, si è che l'illazione logica in universale e però tutte le illazioni abbian valore; ciò che appunto nega il filosofo di Koenigsberga. Poichè distruggere universalmente il valore dell'illazione e dell'argomentazione logica nella sfera della ragione teoretica, e poi ricorrere ad essa, come fa il Kant, nella sfera della ragione pratica, non vediamo come si possa salvare da manifesta contraddizione. Ed è del pari difficile purgare l'autore del Criticismo da un'altra contraddizione ancora; poichè nella Critica del giudizio (1) parlando de' giudizi nostri circa il bello, egli ricorre ad un intelletto archetipo, in cui noi li vediamo. Discreditate dunque in tal modo le forme logiche, restava una cosa oscura e veramente incognita, la materia corporea, che cade sotto l'esperienza e che di quelle forme si veste, onde questo filosofo conchiuse che della realità esterna nulla si poteva affermare, nè che fosse, nè che non fosse.
40.
Lo spirito umano a questo termine si trova così disagiato che non può in alcun modo fermarvisi. E impossibile che si riposi tra i due guanciali dell'apparenza e dell'ignoranza, dove l'avea messo il Kant a dormire. Sorsero dunque altri ingegni potenti, e tentarono di rimovere limiti così angustiosi. Il primo fu il Fichte, che pretese di togliere quel fuor d'opera della materia, di cui il Kant avea proibito alla filosofia di pronunciare. Se lo spirito umano produce di sé le forme logiche, disse, perchè non produrrà anche il mondo materiale? Il mondo che io affermo sarà a miglior condizione del mondo formale che io stesso intuisco? Se questo è mia produzione, perchè l'intuisco, non sarà mia produzione ad un titolo del tutto simile quello che affermo? La conseguenza era indeclinabile, posta la premessa: così fu consumato il sistema dell'idealismo soggettivo, e l'universo e Dio stesso divenne un complesso di fatture nate all'improvviso, non si sa quando, nè come, da un gran sogno dell'uomo.
Pure se la Filosofia critica non appagava l'intendimento, lasciando l'incognito della materia, come un fuor d'opera; molto meno ella poteva appagarlo sentenziando, che le forme logiche erano del tutto soggettive, e non avevano valore alcuno a provare alcuna esistenza al di là del soggetto umano, e nè pure l'esistenza di questo. Sopravvenne dunque lo Schelling e il suo discepolo Giorgio Hegel, promettendo di restituire la vera oggettività alla cognizione, e di ritornare così a un pensare assoluto. Ma di qual'indole fu mai questo tentativo? S'andò per esso più avanti nella stessa via; non si pensò menomamente che bisognava retrocedere, mancò il coraggio ed il valore d'inventare un sistema radicalmente diverso. Questi quattro filosofi hanno veramente in radice un sistema solo, di cui formola comune è, «spiegare tutto, attribuendo una facoltà produttiva di tutto allo spirito umano».
Il Kant si mette all'opera e comanda allo spirito umano di produrre le forme logiche, ma s'arresta davanti alla realità materiale: non vuol commettere l'indiscrezione di fargliela produrre. Il Fichte grida: avanti, e gli ordina anche la produzione della materia. Sopravviene lo Schelling, ed osservando che il produttore rimanea tuttavia distinto dal prodotto e quindi rimanea improdotto, volle far marciare ancora più avanti la rivoluzione filosofica, con un decreto, che lo spirito umano, mediante un'intuizione, identifichi le sue produzioni con se stesso, denominando questo suo decreto: «sistema dell'identità assoluta». In tal guisa lo spirito che, dopo aver prodotto di sè tutte le cose, intuisce l'identità di esse con se stesso, ha unificato il soggetto coll'oggetto, e così, secondo lo Schelling, ha trovato l'assoluto.
41.
Ma l'Hegel viene al potere, e trova questa filosofia ancor troppo lenta, e non avanzata: la fecondità dello spirito umano, secondo lui non è esausta, non portata all'ultimo concepibile; c'è quell'intuizione di mezzo, che lascia sussistere una distinzione tra l'intuente e l'intuito, e però il soggetto non è ancora del tutto identificato coll'oggetto. Immagina dunque nell'alta fantasia,
(« E se le fantasie nostre son basse
(«A tanta altezza, non è maraviglia » (1)),
che lo spirito umano, produttore di tutto, a forza di cacciar fuori da sè, caccia fuori se stesso, esaurendosi finalmente e annullandosi nel suo prodotto, quasi come la rimboccatura del sacco che facendosi sempre maggiore diviene il sacco arrovesciato: ecco ora trovata «l'idea assoluta». Non mancarono d'acquistarsi tali filosofi, specialmente l'ultimo, celebrità di gran dialettica; noi dubitiamo della durata di tali celebrità.
Non è questo il luogo dove tali sistemi nel loro complesso e ne' loro fondamenti possano essere esaminati. Diremo solo, che ci sembra indubitato questo, che quegl'ingegni invano fecero tutti gli sforzi per uscire dalla rete del pensar dialettico, e arrivare all'assoluto: non ottennero che d'involgersi sempre più nella forte ragna tesa all'ingegno germanico dal primo di essi, il Kant, e col dibattervisi potentemente, meglio e meglio vi s'insaccarono. E in fatti, sentendo pur il bisogno d'evitare quel soggettivismo, nel quale era incappato il Kant, non pervennero mai a intendere l'oggettività di quelle sue forme logiche; ma si persuasero in quella vece, che continuandosi coll'immaginativa filosofica a soggettivizzare più e più ogni cosa fino ad esaurire il soggetto, questo cesserebbe finalmente d'essere egli stesso soggetto, convertendosi in altro chè d'assoluto, nè soggetto nè oggetto, ma amendue, tutt'insieme: come il ladro che entrato per una porta in casa altrui, e scoperto, invece di fuggire dando volta per la medesima, νa coraggiosamente avanti, nella fiducia di trovarne un'altra all'opposto estremo della casa, per la quale svignarsela e salvarsi.
42.
Da' quali cenni sufficientemente si può vedere che il periodo del pensar dialettico si esplica in tre generi di filosofia:
1º Nelle filosofie che professano apertamente lo scetticismo ;
2º In quelle che dichiarano di non professare nè il dogmatismo nè lo scetticismo, pretendendo che ci sia un sistema medio, come fa il Kant;
3º In quelle finalmente che ritornano al dogmatismo, credendo, benchè erroneamente, d'avere raggiunto il pensare assoluto, come fanno i tre successori del Kant, il Fichte, lo Schelling e l'Hegel.
IX: Difesa della logica contro l' Hegel
43.
Queste sono le loro pretensioni e le magnifiche promesse. Nondimeno solo lo Scettico almeno s'esprime con sincerità. Nel fatto, tutti e tre questi generi di filosofia appartengono al pensar dialettico, da cui non escono mai: sono tre fasi, tre risultati della filosofia critica. Il primo ha per suo carattere la disperazione di conoscere il vero. Il secondo cerca riparare a questo inconveniente colla fede nella ragione pratica campata in aria, senza alcun fondamento teoretico. Il terzo ha per suo carattere l'orgoglio filosofico, che sentendosi perire ogni cosa in mano, invita l'umanità allo spettacolo che sta per dare, nel quale promette di cavare sugli occhi del suo pubblico, eccitato a stare ben attento, il tutto dal nulla, come appunto i lesti giocatori fanno, che di sotto al bussolotto, ove non c'era nulla, vi traggono una gran palla variopinta, della quale nè pure un quarto ci cape.
44.
Questi dunque sono tutti filosofi critici, benchè i discepoli abbiano rinnegato il nome dato alla loro comune filosofia dal maestro. E che lo stesso Hegel non sia altro che critico, facilmente si scorge, se altri, invece di badare a ciò che promette e tenta di fare, osserva a quello che pretende distruggere. In una sua Prefazione alla Logica (1) ci dà come cosa certa, che quello che esisteva avanti al Kant sotto nome di Metafisica non appartiene più al novero delle scienze: l'antica Ontologia, la Psicologia, la Cosmologia e la Teologia naturale sono divenute cose di cui non si fa più cenno da niuno: le ricerche sull'immortalità dell'anima, le prove dell'esistenza di Dio e somiglianti, hanno perduto ogni importanza. La Logica è rimasta sì, ma senza progresso e con discredito: e chi mai crederebbe oggidì ch'ella insegnasse a pensare? lo spirito pratico del secolo la minaccia della stessa sorte della Metafisica, il suo spirito è già cangiato: invano altri vorrebbero conservare le forme del passato, foglie appassite cadono per far luogo ad un novo sviluppo: e il momento di trasformare la Logica è giunto: d'ora in poi, essa dovrà costituire la Metafisica, la Filosofia speculativa pura. Così l'Hegel. Non è difficile scorgere quanto gli abbia imposto la superficialità baldanzosa del secolo nel quale visse, e quanto il suo spirito si mostrasse debole ai pregiudizi più volgari del tempo. Ci vuole ben altra tempra, per poter essere un filosofo.
45.
Ma esaminiamo questa trasformazione della Logica, che ci promette a fidanza quell'uomo, che accetta così alla grossa per buone le opinioni declamate dagli spiriti frivoli e illogici.
La trasformazione di cui egli parla, involge in primo luogo una piena distruzione della Logica antica! (1)
La Logica secondo l'Hegel è la scienza dell'idea in sè, dell'idea pura: ella ha per oggetto, «la forma assoluta della verità, e la stessa verità pura (2)»:
Per intendere quella nuova definizione, conviene considerare, che il suo punto di partenza è «il pensiero come oggetto del pensiero».
Quest'oggetto che è il pensiero stesso come oggetto, si move, e movendosi compie tre lavori.
Col primo produce l'idea assoluta come tale, elevandosi dall'ultima astrazione fino all'idea concreta, come la chiama, che racchiude in potenzà tutte le esistenze.
Il secondo lavoro si continua al primo, ed è l'idea concreta, che si svolge: e uscendo di se stessa e ponendosi come un altro, diventa natura.
Divenuta natura quest'idea, incomincia il terzo lavoro, poichè ella ritorna a sè, e ci ritorna con un'intera coscienza di ciò che è in sé, e allora ella si riconosce come spirito.
Al quale triplice svolgimento si riduce tutta la filosofia hegeliana. Il primo è l'oggetto della Logica: il secondo, della scienza della natura: il terzo quello della scienza dello spirito: le tre parti appunto della filosofia (3).
E qui si vede qual posto tenga la Logica nell'Enciclopedia filosofica dell'Hegel.
Ella è il movimento, che il pensiero come oggetto del pensiero stesso, fa, e pel quale perviene a costituirsi come concetto o idea assoluta.
(2) Encyclop. § 19-25.
(3) Encyclop. § 15-18.
46.
Ma anche questo primo movimento ha tre parti; chè c'è un movimento o processo nella sfera dell'essere, un movimento o processo nella sfera dell'essenza, e un movimento o processo nella sfera del concetto.
Il movimento nella sfera dell'essere ha la forma di passaggio in un altro. Il movimento nella sfera dell'essenza, ha la forma di riflessione o di manifestazione in un altro; il movimento nella sfera del concetto è uno sviluppo, pel quale solo si pone ciò ch'è già in sè, ossia in potenza, come una pianta che si svolge dal germe, nel quale è contenuta (1).
Questo triplice movimento o processo ritorna eternamente a sè, ricomincia a ogni istante e in ogni istante si compie.
La descrizione di questo continuo movimento è quella Logica che l'Hegel intende di sostituire alla volgare, come egli la chiama, e di cui parla sempre con dispetto.
47.
Ora in questa nuova Logica, che cosa è la verità? L'accordo dell'obbietto col concetto dice (1). Quest'accordo si trova nell'idea assoluta che è l'ultimo termine a cui pervenne nel suo sviluppo il concetto medesimo. Indi procede questa singolare conseguenza, che «l'errore coesiste eternamente colla verità», poichè ammettendo il nostro filosofo, che quel triplice progresso sia in un continuo ed eterno circolo, e che la verità non istia se non nell'ultima punto, nel quale il circolo si compie, che è quando il concetto è divenuto idea assoluta, consegue che tutti gli altri punti del circolo rimangano nella deficienza dell'errore, e che un solo momento del circolo appartenga alla verità, e tutti gli altri all'errore, facendo così all'errore una parte assai più ampia è ricca, che alla verità. E poichè quel triplice processo circolare ed eterno è necessario, rimane che la vicenda perpetua tra il regno della verità che sta in un punto, e quello dell'errore che sta in tutto il corso del circolo, sia pure necessario; onde questo filosofo volendo essere al sommo unitario, precipita senz'avvedersi nel sistema manicheo dei due principi.
Insincera acies duo per divortia semper
Spargitur, in geminis visum frustrata figuris (2).
(2) Prudent. Hamartigenia, vs. 4. 5.
48.
L'intento dunque di questa nova Logica è, a dir vero, molto più sublime dell'antica; chè l'antica insegnava all'uomo ad assicurarsi del vero, questa si ride di tanta semplicità, e vuole che l'uomo si rassegni a considerare la verità e l'errore, come momenti necessari dell'intendimento, che s'avvicendano con perpetuo moto senza alcuna possibilità che la verità prevalga in fine sul suo contrario. Almeno alcuni tra i Manichei, e tra i sapienti persiani si lasciavano quest'ultima speranza, che dopo uno smisurato corso di secoli il buon principio avrebbe vinto e soggiogato il principio malvagio!
49.
È questa una scempiaggine del nostro filosofo. Egli si felicita in un altro luogo d'avere trovata così la conciliazione della verità coll'errore, facendoli vivere insieme in buona pace; e lo stesso è da dire del male e del bene. Nel che pure il filosofo nostro s'innalza non poco al di sopra de' Manichei, che ammessi i due principi contrari del male e del bene, non sapeano concepirli in altra attitudine, che in quella di continua lotta e inimicizia tra loro.
La nova filosofia v'accerta d'avere il maraviglioso potere di legare insieme così il bene e il male, come il vero e il falso, e di far uscire da quelli due contrari una terza entità, e sapete voi che entità sia quella? Il bene assoluto! «Il bene, dice Hegel, il bene assoluto si compie eternamente nel mondo: è compiuto ogni istante senza il nostro concorso. Noi viviamo in un'illusione, che ci persuade, che il bene rimanga ancora a realizzarsi, e questo è il principio attivo, sul quale riposa l'interesse del mondo. L'IDEA nel suo movimento fa illusione a se stessa, si oppone un altro, e la sua azione consiste a risolvere incessantemente quest'illusione. Dal qual errore unicamente procede la verità, e sta qui la conciliazione coll'errore e col mondo finito. L'errore che è essere un altro, in quanto è distrutto, è egli stesso un momento necessario della verità che in tanto è, in quanto si produce come proprio di lui risultato (1)».
Tale è il frutto singolare della nova Logica! tali le sue promesse. Ella insegna all'uomo a rimovere da sé l'illusione di fare il bene o d'aspettarlo in un'altra vita, quasi che il bene assoluto fosse ancora da farsi, e non si facesse di continuo nel mondo senza nostro concorso! Ella insegna che è ugualmente vano il cercare la verità pura dall'errore, quando l'errore è anzi l'opera della verità che si trasforma in un altro, e la verità è l'opera dell'errore che si trasforma anch'egli nel suo altro, cioè nella verità! Quando fosse fatta così la natura delle cose, converrebbe chiudere gli occhi della mente per evitare l'orrore di vederla: quando la scienza assoluta fosse la contemplazione e la produzione insieme di questo tristo spettacolo, di questa rivoluzione continua e fatale del pensiero, converrebbe riputar felice colui che non la possiede, e chi la possiede dovrebbe studiarsi di disimpararla.
50.
L'idea è l'assoluto, la più alta definizione di Dio, dice l'Hegel (1). Ma questo Dio dell'Hegel è un Dio che fa a se stesso una continua illusione, e la sua attività è occupata a risolvere costantemente l'illusione che egli fa a se medesimo. Da questa illusione poi, da quest'errore del Dio dell' Hegel procede la verità!
51.
Una Logica che vi confessa ingenuamente avere di tali risultamenti, non sembrerebbe bisognare di un esame ulteriore, chè quand' anche fosse vera, non potrebbe esser buona nè desiderata, e non potendo esser buona non può esser vera. Tuttavia non vogliamo ommettere d'accennare alcuno de' principali errori intrinseci che guasta nelle sue radici il ragionamento Hegeliano.
1º L'Hegel parte da una supposizione del tutto gratuita e ad un tempo evidentemente falsa, ed è che «le idee si movino da se stesse», si mutino, si sviluppino come il germe d'un fiore che si svolge nella pianta. Egli assicura i suoi discepoli, per lo più incantati, che tutte le sue asserzioni (e il suo sistema non è che una serie d'asserzioni), sono necessariamente connesse tra loro, la susseguente colla precedente; ma nessun filosofo menò mai un canto più bugiardo di questo. E nel vero l'asserzione che le idee si movano non è dedotta da alcun principio, nè corredata della menoma prova: l'osservazione interna poi a cui solo il nostro filosofo potrebbe appellarsi, depone il contrario, depone che evidentemente l'idee sono immutabili, l'uomo le intuisce o non le intuisce, ci riflette, o non ci riflette, ci pensa in un modo o in un altro, passa dalla considerazione d'una alla considerazione di un'altra; tutto ciò senza che l'idea soffra il menomo cangiamento. Dunque la nova Logica incomincia col darci una prova d'ignorare interamente la natura delle idee, parte da una proposizione non solo arbitraria, ma erronea manifestamente. E pure tale è il principio di un sì famigerato sistema!
2º Nella Logica l'Hegel si mette all'opera di narrare tutto questo movimento dialettico. Ma affidandosi alla sua potente immaginazione filosofica i passi ch'egli fa fare al pensiero, lungi d'apparire necessari, vanno ad arbitro e a salti. Apriamo la Scienza della Logica.
Il punto di partenza che stabilisce, come abbiam detto, è «il pensiero, come oggetto del pensiero»: questo deve svilupparsi: la Logica è quella che narra e fa questo sviluppo. Ed ecco che la Logica dell'Hegel, tutt'improvviso, e senza che si accenni menomamente il perchè, si divide in tre parti, che sono la teoria dell'essere, la teoria dell'essenza e la teoria del concetto e dell'idea. Essa dunque incomincia tosto col descrivere il movimento dell'essere. Ma l'assunto primo non era egli quello di narrare lo sviluppo del pensiero come oggetto del pensiero? In che modo si è così di subito, senza darne un preavviso al lettore, sostituito al pensiero, come oggetto del pensiero, l'essere? Non si vede qui il filosofo che trattiene i suoi discepoli con agili giochi di mano? Con questo scambietto, ei fa toro trangugiare la proposizione sott'intesa, che «il pensiero come oggetto del pensiero e l'essere sieno cose identiche», e come identiche si possano scambiare, l'una coll'altra a piacimento, e senza pur bisogno di giustificare quella loro supposta identità. Così la famosa Scienza della Logica, incomincia dal mettere d'un tratto l'essere nel luogo del pensare: il filosofo va per vie di fatto: e violentemente introduce l'intero, sistema che dovrebbe dimostrare, fino dalle prime linee. Ponendosi dunque per certo già da principio il sistema, facendone passare il principio e il germe per conceduto, si dà già un primo e solenne esempio della nova Arte di ragionare, opposta per vero dire del tutto all'antica.
3º Ma almeno le illazioni che si soggiungono, saranno dotate di quella necessità dialettica che tanto ostenta, e a cui s'appella come unica prova del sistema. Pensate! Dopo averci fin da principio scambiato in mano il pensare coll'essere, l'Hegel comincia dal dirci che «l'essere è il concetto l'indeterminato (1)». Anche qui, senza favorirci d'una qualche prova, ei domanda, o piuttosto c'impone di credere così alla cieca, che l'essere sia il concetto, e il processo dialettico rigoroso, che ci avea promesso è ridotto ad una sostituzione di vocaboli, a una metamorfosi arbitraria ed assurda. Chi mai, se non ha perduta la testa, gli accorderà che l'essere, così in generale, sia il concetto? Anzi gli dirà tutto il mondo che col concetto si conosce l'essere e che quello per ciò appunto non è questo. Che se pure volesse parlare dell'essere ideale, sarebbe stato necessario il dirlo; chè per certo l'essere ideale in quanto è intuito dalla mente, benchè non sia propriamente un concetto, è pero l'idea; ma l'essere senza distinzione di forma, non è nè un'idea, nè un concetto. Soggiunge: «l'indeterminato». Ma l'indeterminato è egli lo stesso che l'essere? No per certo; come l'indeterminato non è tampoco lo stesso che il concetto. E se voi l'asserite, asserite cosa che niuno vi accorderà. Anzi l'essere è essenzialmente determinato, e quando si rimane indeterminato è meno essere di prima: l'indeterminato in somma non significa, chè una privazione, a cui soggiace l'essere ideale.
4º Che se volete parlare non dell'essere semplicemente, ma dell'essere indeterminato, di novo perchè non dirlo? perchè dissimularlo alla guisa de' sofisti, che lavorano su equivoci di parole? In tal caso però avreste dovuto ġiustificare l'idea dell'essere indeterminato, dandone la sua origine, e, investigandone l'origine, non avreste più incominciato la Logica così di salto dall'essere indeterminato, ma da qualunque altra cosa che vi avesse potuto condurre alla spiegazione dell'idea dell'essere indeterminato. Secondo noi, non l'indeterminato semplicemente, ma l'essere indeterminato è il lume della ragione, la forma dell'intelligenza: solo dopo che l'abbiamo rigorosamente dimostrato, abbiam detto a buon diritto, che qui sta il punto di partenza dello spirito umano, distinguendo questo dal punto di partenza dell'uomo nel suo primo sviluppo, e da quello dell'uomo che incomincia a filosofare e da quello della filosofia come scienza (Ideol. 1468-1472).
5° L'essere, dice l'Hegel, ha tre forme, la qualità, la quantità, e la misura o la qualità quantitativa. E anche di ciò niuna prova, nè prova ci potea essere d'un errore così patente. Egli parlava dell'essere indeterminato e ci viene a dire che egli ha qualità, quantità, e misura? Qual salto! l'essere indeterminato non ha certamente nulla di tutto ciò: che queste sono determinazioni, e quando l'essere le ha, non è più indeterminato, onde anche qui si muta di soppiatto, secondo il solito vezzo, il subietto del discorso.
6º Ma vediamo che cosa egli dica della qualità. «L'essere puro, cosi egli, è il cominciamento, perchè è ad un tempo e puro pensiero, e l'immediato semplice, e l'indeterminato». Quante cose in una volta! quante asserzioni in poche parole! Parlava dell'essere, ed ora entra in campo con un non leggero cambiamento, essere puro. Di novo poi s'identificano l'essere puro e il pensiero, senza dire un perchè. E pure gli uomini tutti distinguono e distingueranno il pensiero, che è l'atto del soggetto intelligente, dall'essere che n'è l'oggetto, e per niuna guisa confonderanno insieme cose tanto diverse, ed opposte tra loro. Dice ancora, che quest'essere puro è l'immediato: ma l'immediato è un addiettivo, a cui manca il sostantivo, e l'indovini chi può. Ma via, su quali prove dice, che l'essere puro è l'immediato? Credere ciecamente alla sua parola, ecco il solito intimo che ci fa il nostro filosofo. Tosto soggiunge, che «l'essere puro, come pensiero puro, è un'astrazione, è l'indeterminato puro senza alcuna realità (2)». Ma se l'essere puro è un'astrazione, come dunque è l'immediato? Sarebbe piuttosto immediata l'astrazione, e l'essere puro, avendosi mediante questa, sarebbe mediato. E una tale astrazione su che si fa? Ciò da cui si astrae è anch'esso anteriore all'astrazione, e però più immediato di questa, e dell'astratto che essa produce.
7° Ma attenti qui ad un'altra poetica metamorfosi! l'essere puro che si dice un'astrazione, tosto dopo è un'astrazione pura, che si fa sinonimo di negativo assoluto. E operata questa sostituzione di parole, incontanente si asserisce senz'altre cerimonie, che il negativo assoluto, preso in sè, è il niente, che si definisce astrazione e negazione assoluta. Questi repentini passaggi poi si pretendono al sommo dialettici d'una necessità rigorosa! Ma lasciando da parte le ciarle, gli uomini non si persuaderanno. così agevolmente, che l'essere indeterminato sia il niente, stantechè l'essere indeterminato per vero dire è anch'egli un oggetto del pensiero: nè pure troveranno che chiamare il niente astrazione e negazione assoluta, sia un parlare proprio, poichè l'astrazione e la negazione sono operazioni del pensiero, e il nulla è bensì il risultato della negazione totale, che rimove ogni oggetto dal pensiero, ma non è la negazione stessa. Ma perchè l'essere indeterminato sarà il nulla? Il nostro filosofo non si obbliga mai a dire alcun perchè, ma un perchè si può raccogliere da quello che ci ha detto, cioè che non ha in sè alcuna realità. Gli uomini però di buon senso troveranno illogica e antidialettica un'induzione di questa sorte, che l'essere indeterminato è pur qualche cosa, benchè privo della forma reale e privo di determinazione, appunto perchè è l'essere: egli è l'essere ideale e formale, egli è l'essere che virtualmente ha in seno tutte le determinazioni: egli è l'intelligibilità di tutti gli enti determinati, e però non mai si potrà identificare col nulla. Anche questo anzi che un passo dialetticamente necessario, è un salto da disperato, chè l'essere è sempre ciò che contraddice direttamente al nulla.
8° Dopo dunque, che l'Hegel, col solito metodo di sostituire parole a parole, vi definì l'essere in questo modo, cioè chiamandolo il nulla, dà degli altri passi niente affatto più dialettici de' precedenti, ma solo verbali, in questo modo: «Il niente come negazione assoluta è identico coll'essere puro o indeterminato. La verità dell'essere come quella del nulla è per conseguente l'unità dei due. Questa unità è il DIVENIRE, das werden (3)». Ed ecco il principio, e la caratteristica di tutta la filosofia hegeliana: in essa tutto e sempre diviene, essendo l'idea, secondo l'Hegel, essenzialmente movimento (4): pure, è impossibile concepire nell' idea alcun movimento, ripugnando il movimento e il cangiamento alla natura eterna e immutabile dell'idea. Ed è sufficiente anche questa osservazione sola a crollare tutto intero l'immaginario edifizio. Ma esaminiamo l'ultime parole citate. Dopo aver detto, che l'essere indeterminato è il nulla, pretende che ne venga questa conseguenza, che «la verità dell'essere, come pure quella del nulla è la unità dei due». Ma ci dica chiaro e senza equivoci, se l'essere e il nulla sono due o sono uno, poichè se sono due non c'è più identità perfetta tra loro, e se sono uno non c'è bisogno d'unirli. Il vero si è, che nè sono uno, non potendosi fare giammai che l'essere sia il nulla, o viceversa, nè sono due, se non per rispetto alla mente nostra, la quale, con due diverse operazioni, pone o rimove l'essere; nè queste due cose possono unirsi in una, non potendo la mente nello stesso tempo e sotto lo stesso rispetto, pronunciare e negare l'essere. E però quella che l'Hegel chiama Logica volgare ha piena ragione quando ammette il principio di contraddizione; e il novo dialettico ha tutto il torto quando lo impugna per godere il singolar privilegio di contraddirsi.
L'unione dunque ossia l'identificazione dell'essere col nulla non è che un assurdo, il quale non può esser concepito da niuna intelligenza, e un assurdo non può essere alcuna cosa, nè pure il diventare.
9º D'altra parte nè l'essere nè il nulla diventa, perchè l'essere è, e quello che è non diviene, e il nulla non diventa, perchè è nulla, e il nulla nè fa nè patisce nulla, il concetto del divenire dunque non è, e non può essere nè nell'essere, nè nel nulla, nè nella loro unione o identificazione. Convien dunque analizzarlo questo concetto e non gettarlo là in mezzo sodo ed intero senza alcuna spiegazione e senza pur dire che cosa sia: a questo modo il diventare sarebbe una mera parola, e questa non definita e però non chiara, nè conveniente al dialettico, ma solo al sofista. E infatti, prima di tutto sotto la parola diventare ci può stare un semplice concetto, e ci può stare anche una realità. Che cosa c'intende dunque l'Hegel il diventare reale, o il concetto del diventare? Egli si guarda bene dal dichiararlo, chè ha un indispensabile bisogno di poter prendere quella parola ora in un senso e ora nell'altro, quando per l'atto reale, e quando pel concetto di quest'atto; e solo con queste ambiguità spera di farvi inghiottire, questo suo paradosso, che il concetto e la realità sieno tutt'uno, e che nell'ideale si comprenda anche il reale: a sì stupenda sentenza non si potea venire per altra via che gettando in mezzo un vocabolo atto a significare l'uno e l'altro, per farvi poi passare dall'identità della parola all'identità della cosa.
10º Del resto, il preteso passaggio dialettico dall'essere indeterminato al diventare non c'è; che nell'essere indeterminato non si può trovar cosa che diventi o faccia diventare, anzi non c'è attività di sorta, ma pura intelligibilità; onde manca del tutto fino la possibilità del passaggio; in vece dunque di passare, deducendo cosa da cosa, tutto si riduce ad un arbitrario aggiungere di cosa a cosa. Ora come voi aggiungete a vostro comodo il diventare all'essere indeterminato, così io del pari posso aggiungergli qual altra determinazione mi piaccia, senza però accorgermi d'aver fatto con si poca spesa, un sistema filosofico, ma un semplice e volgarissimo esercizio del pensiero.
Dico dunque che voi introducete exabrupto il diventare non per un passaggio necessario di concetti, ma come s'accosta una parola ad un'altra senza nesso. Per vero, il diventare suppone l'essere che diventa un altro, e però l'essere precede il diventare; se precede, il diventare stesso non può esser l'essere, ma cosa che sussegue all'essere. Aggiungete quello che abbiam detto, che l'essere ideale non diventa mai, e che l'essere indeterminato non è altro che ideale; perchè tutti i reali sono determinati. Pure il diventare suppone una forza, e una forza che determina un subietto a mutarsi, e a mutarsi in un dato modo, onde la virtù del diventare, o attiva, o passiva, o intransitiva, prendetela come volete, dee sempre essere un determinato. E quand'anche col pensiero vi formaste un concetto astratto del diventare, e così non voleste determinare il modo del diventare, anche questo concetto, quantunque astratto, comincierebbe già a rendere l'essere meno indeterminato, sicchè coll'aggiungere il diventare all'essere, voi non fate perciò che l'essere indeterminato si mova, il quale rimane necessariamente davanti alla mente quello di prima ma dal concetto dell'essere pienamente indeterminato, la vostra mente passa a considerare un altro concetto meno indeterminato e nulla più.
11° E in fine questa determinazione del diventare non la potete prendere che dal mondo reale, come dicevamo, perchè altrove non c'è. Come siete dunque saltato dal mondo ideale in cui eravate, nel reale? Come giustificate un sì gran salto? Mentre ragionavate dell'essere indeterminato che non può essere che oggetto della mente, in che modo avete voi tratto in campo il diventare che non si trova, se non tra le realità e neppure tra tutte queste, ma solo tra le realità finite? Ed eccoci qua un altro mortalissimo, antilogico e antidialettico salto dall'essere indeterminato all'essere finito. Il concetto dell'essere pienamente indeterminato è illimitato, infinito: appunto perchè non è determinato, non ha confine di sorta: il diventare all'incontro (qualunque cosa sia questo diventare, e noi lo vedremo poi) è una passione dell'ente puramente finito, di cui voi non avete ancora parlato, e che pure vi fate lecito d'introdurre di contrabbando come un sottinteso della vostra filosofia, dove a gran voce asserite che non può entrare alcun personaggio novo senza il passaporto della necessità dialettica. Sono dunque parole le vostre, alle quali vanno contrari i fatti. Vedete qua tre salti smisurati, per riassumere: siete saltato 1° dall'essere ad una passione dell'essere qual'è il diventare; 2° dall'essere ideale, qual'è l'essere indeterminato, all'essere reale, chè nel solo reale si scorge la passione del diventare: 3º dall'essere infinito, l'indeterminato, all'ente finito, che questo solo si può dire in qualche modo che diventi, se pure questa parola ha un senso.
Quanto dunque il nostro filosofo va più conciso e rapido nelle sue asserzioni (e l'asserire così è necessario per far volare le menti de' suoi giovani uditori) tanto più fitti s'aggruppano gli errori, come certe piccole pallottole, che racchiudono un maraviglioso numero d'uova di certe generazioni d'insetti.
12º Ma l'Hegel vi dice oltracciò, che il diventare è proprio l'identificazione del nulla coll'essere, perchè esprime quel punto in cui un ente cessa e l'altro non è ancora. Quando fosse vero che esprimesse questo punto, non sarebbe vero perciò, nè che l'essere indeterminato fosse l'identificazione dell'essere col nulla, nè che questa identificazione fosse il diventare. Che l'essere indeterminato non abbia la realità, quest'è vero; ma egli ha l'idealità, e l'idealità non è nulla. Nè il nulla si può unire coll'essere, propriamente parlando, perchè non sono due cose. Ha bensì l'essere del mondo deʼ limiti; ma la parola nulla non indica questi limiti: il nulla è un concetto semplice, indicante rimozione totale dell'essere; i limiti poi sono diversi, e hanno concetti diversi, poichè sono relazioni d'enti diversamente limitati.
Pure s'ammetta che per un parlar figurato (il quale per altro dee escludersi dalle deduzioni rigorosamente scientifiche) si possa dire, che l'essere indeterminato sia l'unione dell'essere col nulla, perchè c'è ad un tempo l'essere ideale e il nulla della realità. S'ammetta di più, ancora per un altro parlar figurato, che il diventare sia l'unione dell'essere col nulla, perchè nell'atto del divenire si concepisce la cessazione di un ente e l'incominciamento d'un altro. Dopo che si fosse accordato tutto questo, non ne verrebbe ancora menomamente, che l'essere indeterminato fosse il diventare, quantunque tanto l'uno quanto l'altro si fosse definito l'unione col nulla e coll'essere; poichè questa definizione non significherebbe una cosa sola; ma quello che esso significherebbe quando s'applicasse all'essere indeterminato, sarebbe altro da quello che significherebbe quando s'applicasse al diventare. L'unione dell'essere col nulla rispetto all'essere indeterminato, sarebbe d'un modo affatto diverso dall'unione dell'essere col nulla rispetto al diventare. Nell'essere indeterminato mancano intieramente i concetti d'annullazione e di produzione: non c'è che essere (ideale) e non essere (reale). Nel divenire poi non c'è semplicemente essere e non essere, ma annullazione e produzione. Altro è il nulla e altro è l'annullazione; il nulla non suppone nulla, l'annullazione suppone un agente che annulla e un'entità che s'annulla: altro è essere, e altro è produzione di essere; essere esprime l'atto compiuto e quieto, la produzione esprime l'atto non compiuto e inquieto. Convien dunque ad ogni modo riformare quelle definizioni, rimanendo ancora figurate, e dire che l'essere indeterminato è l'unione dell'essere (ideale) col nulla (del reale): il divenire all'incontro è l'unione, non l'identificazione dell'annullazione colla produzione. Ridotte così le due definizioni, hanno perduta la loro identità; il sofisma hegeliano dunque viene dall'avere abbandonata la Logica antica, la quale, se il nostro filosofo l'avesse studiata, gli avrebbe insegnato a principiare i suoi discorsi da rigorose definizioni, e da sagaci analisi, per mezzo delle quali, quasi con un segno di croce, sarebbe svanito l'incantesimo, a cui soggiacque pur troppo la mente del professore di Berlino.
13º E per vero tanti errori in così poche parole hanno per cagione non solo l'omissione delle definizioni, ma soprattutto delle analisi. L'Hegel, così spregiatore della dottrina de' secoli, che i begli spiriti dichiaravano ormai troppo volgare, ha portato nella filosofia il suo concetto del diventare togliendolo tutto intero dal volgo. Non s'è dato il menomo pensiero di rettificarlo e d'appurarlo, ma così rozzo, e sodo, e confuso, l'ha posto a pietra fondamentale del suo edificio. Se v'avesse applicata un po' d'analisi filosofica, avrebbe conosciuto, che il diventare, come il volgo lo concepisce, non esiste in natura, se non fenomenalmente. Ma il nostro filosofo, nello stesso tempo che s'immaginava innalzarsi com'aquila, è gabbato da' pregiudizi più comunali, contentandosi d'avvolgerli in un oscuro linguaggio. Il diventare dunque non esiste, noi diciamo, nel senso che ci sia un punto, nel quale un ente si annulli e un ente incominci; ma qualunque sia l'istante che si voglia assegnare, l'ente è, o non è, e di quello che è, non si può dire che ancora non sia. Così nella creazione, che l'Hegel dice d'ammettere (5), tra l'esserci il mondo, e il non esserci, nulla ci fu mai di mezzo; nè la creazione è un cominciare, ma un esser posto l'ente bel e fatto. Nella creazione non c'è dunque qualche cosa che diventa, nel mondo creato poi il diventare appartiene ai modi dell'essere reale che si rimutano, non all'essere stesso, e anche ciascun di questi in qualunque istante o è o non è. Ma ad ogni modo è un altro abbaglio anche questo, d'applicare all'essere sostanziale quello che può, in qualche senso, dirsi solo de' modi e delle determinazioni di esso. Perchè l'Hegel applica talmente il diventare all'essere, che non contento che l'essere stesso diventi, e diventi tutto ciò che piace, vuole di più, che l'essere sia lo stesso diventare.
Ma nè pure rispetto ai modi e alle determinazioni dell'essere, come dicevamo, si può asserire darsi una vera continuità di passaggio, se non fenomenale; chè uno stato succede all'altro immediatamente. Certo si dà una continuità; ma questo altro non significa, se non che gli stati prossimi, ne' quali si trova un ente che si sviluppa, per esempio una pianta, sono così poco differenti tra loro, che l'osservazione nostra non arriva a distinguerli, e però c'immaginiamo una continuità. Come già dimostrammo altrove, il concetto di continuità nel moto è un concetto confuso, che nasconde un assurdo (Ideol. 814-815). L'Hegel dunque prende a fondamento del suo sistema e della sua nova Logica, un concetto volgarissimo, d'origine fenomenale, confuso e che porta nel seno un assurdo.
(2) Encyclop. § 86.
(3) Encyclop. § 87.
(4) Ivi § 215.
(5) Encyclop. § 128. Agg.
52.
Ed egli è chiaro da sè, che allorquando un filosofo incomincia da proposizioni così equivoche, arbitrarie, confuse, erronee, assurde, può benissimo, specialmente se dotato d'una grande forza d'astrazione quale si vede generalmente negl'ingegni tedeschi, cavarne le più strane conseguenze, e creare una specie d'universo fantastico, da sorprendere i giovani inesercitati e confidenti, e così formare una certa scuola, come vediamo aver fatto il filosofo di Stutgarda; ma colui, che ha un senso virilmente educato, e che non si lascia prevenire da un cieco, benchè talvolta generoso, entusiasmo, pesa le ragioni ed entra nel fondo d'ogni nova dottrina, e così non incappa in tali reti. La celebrità di quest'uomo si spiega: è una di quelle tante celebrità che uscivano dalle aule universitarie: sono corone intrecciate dalle mani della candida gioventù.
53.
E questo piccol saggio della maniera di ragionare di cotesto novo logico superiore alla Logica, basta pare a noi ad intendere, che l'Organo antico non ha nulla a temere dalle sue contumelie. Egli rifiuta l'antico modo di dimostrare: il sillogismo è tutt'altro, che quello conosciuto fin qui: c'è una sola dimostrazione, consistente nel complessivo sviluppo del pensiero: fino da principio egli confonde questo pensiero col suo oggetto. E questo oggetto del pensiero, come Proteo, si trasforma nelle
sue mani fin che diventa, per gran fortuna, idea assoluta, e in questa cessa ogni individualità e personalità: tuttavia quest'idea poi è Dio stesso, cioè il Dio dell' Hegel, eternamente mutabile, anzi
essenziale mutazione che non si può coglier mai, nè conoscere in un certo stato, che contiene tutto nel suo seno, e n'esce tutto senza posa, ed in fine esce egli stesso, ed uscendo di sè, arriva, mirabil vicenda! ad annullarsi: è un Dio che s'illude, ma poi rientra in sè, e facendo giudizio, distrugge la sua illusione, che non cessaper questo d'esser perpetua, perchè la sua essenza è pur
sempre lo stesso diventare, lo stesso mutarsi, lo stesso illudersi! Quando poi l'uomo è pervenuto ad essere quest'idea, avendo così cessato d'esser quello che è, allora la dimostrazione è compiuta. È ovvio il domandare: di che sia questa dimostrazione? Vi si risponde, che la dimostrazione dimostra se stessa, perchè non c'è altro da dimostrare che la dimostrazione stessa: e così poi è dimostrato il tutto, già s'intende, errore e verità, vizio e virtù, sistemi e fatti: ogn'altra Logica dopo di ciò è inutile,
ogn'altra dimostrazione è una puerilità: sono tutti anelli necessari della stessa catena, e nell'unico tutto, tutti valgono il medesimo. Ed appunto perchè la forza d'una dimostrazione così singolare, si asserisce consistere nella necessità dialettica, dal saggio presone più sopra, giudicherà il lettore, con qual rigore dialettico proceda il pensiero hegeliano. Un gran fatto dunque (per isventura supposto e creato dall'immaginazione) rimane sostituito ad ogni ragione: cessa per vero ogni questione, quando tutte le questioni sono contenute nella catena che conduce fatalmente all'unica idea, e anche tutte le possibili soluzioni, benchè contrarie tra loro: non è più nessuno che abbia ragione o che abbia torto, quando ciascuno ha ragione e torto ad un tempo, ragione in quanto s'avvicina ad annullarsi nell'idea, torto in quanto non s'èancor annullato in essa. Questa mirabile Dialettica, muore dunque nella sua Apoteosi, e la pace della filosofia è completa nell'annullamento. E qui apparisce ragione perchè, secondo l'Hegel, non si possa più parlare di prove dell'esistenza
di Dio, dell'immortalità dell'anima, o di scienze metafisiche, o dell'antica Logica che cessando si trasforma in un'altra tutta nova, la quale divora se stessa, e divorata, sempre si rivomita. Ripetiamolo, se tutti questi deliri potessero essere verità, converrebbe rinunziare alla filosofia, alla scienza, alla speculazione, chè la verità sarebbe divenuta da questo momento le tenebre, o, come formulava una simile dottrina il Prudhon: «Iddio è il male» .
E dunque evidente che la filosofia in Germania dal Kant all'Hegel non potè uscire da quel periodo che abbiamo chiamato del pensare dialettico, nel quale si succedono i tre generi di sistemi sopra indicati.
X: Intendimento e limiti del presente Trattato
54.
Nel presente trattato non possiamo diffonderci a dare quei precetti logici speciali che può esigere la natura del pensare dialettico e dell'assoluto: ma solamente i precetti universali, e gli speciali del pensar comune, sia volgare, sia scientifico. Le due altre maniere più speculative di pensare non si possono pur descrivere chiaramente, senza addentrarsi nella dottrina universale dell'essere e dell'ente e nell'intime relazioni tra l'essere e l'intelligenza umana che lo contempla, cercando raggiungerlo nella sua compiutezza maggiore. I precetti logici dunque che le regolano non sono divisibili dalla materia a cui s'applicano, e perciò entrano a formar parte delle scienze metafisiche.
E quest'è uno di que' casi in cui apparisce, che la divisione delle scienze che si fa per cagione di metodo, non può mai riuscire così recisa, che l'una con qualche sua parte non entri e si
radichi nell'altra, perchè lo scibile, come l'ente, è fatto per sua propria natura, a circolo.
55.
Qui ancora si presenta la questione, se la Logica convenga dividersi in una parte materiale e in una parte formale, e se la dottrina degli universali appartenga alla Logica, il che fu negato già da molto tempo (1) senza che una tale osservazione sia stata molto valutata dagli scrittori posteriori. Circa
le quali quistioni noi crediamo:
1º Che non si possa dare una Logica , in qualche modo perfetta, se chi la scrive impone a se stesso la condizione d'escludere da essa ogni materia, e d'attenersi alla parte puramente formale, la quale dal solo studio della materia cioè dell'oggetto in gran parte si raccoglie;
2º Che per la stessa ragione non si può recidere così precisamente la forma dalla materia della Logica da formarne due parti esattamente separate , benchè si possa e si deva far conoscere al lettore che cosa sia materia ovvero oggetto, e che cosa forma, acciocchè egli sappia distinguere l'una dall'altra;
3º Che della materia o dell'oggetto si deve nella Logica prender tanto e non più , quant'è necessario a dare la dottrina compiuta della forma logica, che è il proprio scopo di questa scienza;
4º Di conseguente che la dottrina degli universali non appartiene alla Logica, se non in quanto è necessaria alla teoria del diritto pensare, e il resto spetta all'Ideologia, ed all'Ontologia;
5º E per la stessa ragione, che quelle ulteriori dottrine, che riguardano propriamente il pensare critico e l'assoluto e che sono indivisibili dalla dottrina più riposta dell'essere e dell'ente, devono escludersi dalla Logica e rimandarsi alla Metafisica, identificandosi in esse l'oggetto e la forma del pensare: onde la dottrina dell'oggetto, essere ed ente, è anche la dottrina della forma in cui esso è pensato. Il perchè, ommettendo noi queste nel presente trattato, le esporremo in quella parte della
Teosofia, a cui abbiamo dato per titolo: L'idea.
56.
Dal che apparisce , che v' ha una Logica universale che ha sempre e per ogni maniera di pensare valore, e questa parte della Logica comune a tutte tre le maniere di pensare che abbiamo distinte più sopra, forma la porzione maggiore del presente trattato. Laonde le dottrine da noi raccolte si possono distinguere in due parti; quella ch'è universale, e quella che fa l'applicazione di tali dottrine universali col pensare comune volgare o scientifico. Come poi gli stessi principi universali si applichino efficacemente e sicuramente al pensar dialettico e al pensar assoluto, questo l'abbiamo ommesso per la detta necessità, e basta all'intento nostró avvertire, che anco rispetto a questi modi di pensare, que' principi conservano tutta la loro efficacia.
XI: Diversi modi di partire la logica
57.
La Logica si può ripartire in diverse maniere, e però da diversi scrittori furono adoperate diverse partizioni. Ma molti non concepirono la Logica nella sua interezza, e le partizioni da loro usate riuscirono imperfette, come fu imperfetto il concetto stesso della scienza. Così gli Stoici riduceano la Logica a solo l'arte di giudicare. I Peripatetici la dividevano nelle due arti del giudicare e dell'inventare, ed anche secondo le tre operazioni dello spirito da essi considerate, l'intuizione, il giudizio e il raziocinio, dimenticando l'assenso (1). I Platonici le attribuivano cinque parti la definizione, la divisione, la risoluzione, l'induzione, e il raziocinio (2). Alcuni deʼmoderni , come il Karpe, ne fecero due, trattando nell'una della materia, e nell'altra della forma del ragionare, divisione in apparenza più completa, ma che ha gl'incomodi di sopra accennati. Tutti poi omisero una trattazione speciale sommamente importante, quella dell'assenso.
tractavere. Nihil enim de inventione laborantes, in sola tantum judicatione consistunt; de eoque præcepta multipliciter dantes, Dialecticam nuncupaverunt. Boet. in Top . Cic.
(2) Alcinoo. De Doct. Plat . c. V.
58.
Volendo noi dunque indagare quali partizioni convenir possano ad una Logica nella sua interezza, ce ne si presentano quattro, e sono:
59.
Prima maniera di dividere la Logica. — Secondo le tre maniere di pensare, delle quali la Logica si fa guida, ed è la triplice divisione accennata del pensar comune dialettico ed assoluto: ma in tal modo la Logica assorbirebbe in sè l'Ontologia.
60.
Seconda maniera di dividere la Logica. — Secondo gli oggetti a cui si può applicare il pensare, la suprema divisione si prenderebbe dalla suprema divisione degli oggetti, che è la categorica. Di qui tre parti, la prima delle quali occupata in dar le regole del pensare intorno agli enti ideali; la seconda, intorno agli enti reali; la terza, intorno agli enti morali. Ma questa partizione incontrerebbe l'inconveniente di doversi ripetere molte cose comuni al pensare intorno a ciascuno di questi oggetti, e ad ogni modo si dovrebbe aggiungere una quarta parte circa il pensare intorno all'essere identico in quelle tre forme .
61.
Terza maniera di dividere la Logica. — Secondo le forme che prende la verità nella mente umana: onde una divisione ancora di tre membri, cioè della verità in se stessa, delle forme che prende la verità nella mente, ossia de' modi di concepirla, e delle espressioni, ossia de' segni esterni della verità. L'incomodo che trae seco questa partizione consiste nella difficoltà di dividere sempre ed accuratamente quelle tre cose, il che molte volte non si potrebbe senza mettersi in sottilissime questioni per giustificare la divisione stessa, e nella impossibilità che s'incontrerebbe talora di trattare dell'una cosa separata interamente dall'altra.
62.
Quarta maniera di dividere la Logica. — Secondo le operazioni speciali che fa lo spirito umano nel ragionamento e in occasione di questo. E noi ci siamo appigliati a quest'ultima sembrandci che una tale partizione ci segnali una via più spedita e più piana, senza ricusare del tutto l'altre che le possono essere subordinate.
II: Introduzione
I: 1. Definizione della logica
63.
La Logica è la scienza dell'arte di pensare.
64.
Che cosa è pensare? — Sotto questa parola si sogliono comprendere tutti gli atti delle facoltà intellettive. Ma non tutti soggiaciono all'arte, chè non pochi di essi sfuggono al libero maneggio della volontà umana, come quelli, che son posti e determinati dalla stessa natura. A fine dunque di conoscere e accertare qual sia l'oggetto proprio della Logica, conviene, separando gli atti necessari del pensiero, definire e ritenere quegli altri, che possono essere oggetto dell'arte.
Ora le facoltà intellettive si riducono a due principali, l'Intelletto e la Ragione. Gli atti dell'Intelletto appartengono alla sola natura, quelli a cui presiede l'arte non si possono rinvenire che tra gli atti della Ragione. Dichiariamo meglio questo concetto.
65.
L'intuizione dell'essere è ciò che costituisce l'Intelletto (Ideol. 481-484).
L'Intelletto è atto, abito, e potenza sotto diversi aspetti.
È atto, perchè c'è un'intuizione primitiva e naturale dell'essere indeterminato (Ideol. 413-472), che mai non cessa nell'anima intellettiva, e la rende tale. È abito in quanto che l'essere sta presente all'anima senza confondersi con esso lei, e perciò egli non è l'anima, ma è avuto dall'anima. È potenza finalmente in quanto che dall'atto essenziale e immanente, pel quale l'anima guarda l'essere indeterminato, ne nascono degli altri, co' quali ella intuisce l'essere fornito di più o meno determinazioni, così l'Intelletto si può definire: «la potenza d'intuire le idee».
È chiaro che l'atto primitivo dell'intelletto è dato dalla natura e non soggetto all'arte.
66.
Del pari, tutti gli atti intellettivi susseguenti, in quanto al modo con cui sono emessi, sono necessari come il primo, e nel primo virtualmente si contengono.
E però neppur questi, per emettersi in un modo piuttosto che in un altro, richieggono abilità acquisita, nè sono oggetto d'alcun'arte, perchè il modo dell'intuire è semplice e determinato dalla natura (1).
67.
La potenza generale d'applicare l'essere chiamasi Ragione.
68.
Questa non è un atto, ma una pura potenza che consegue all'atto della primitiva intuizione, perchè con essa l'uomo applica l'essere (Ideol. 338, 481).
Sotto quest'espressione «applicare l'essere» comprendiamo qualunque uso dell'intelligenza, dopo la prima intuizione.
Ragionare significa quest'uso, e ragionamento il complesso delle operazioni della ragione concatenate a qualche suo scopo (1).
69.
Il ragionare, o far uso della ragione richiede egli un'abilità acquisita dell'uomo, e questa, può esser maggiore o minore? In altre parole, il ragionare può essere oggetto d'un'arte?
Si distinguano le due principali funzioni della Ragione.
La Ragione in quanto applica l'idea dell'essere al sentimento, esercita quella funzione che dicesi Percezione.
La Ragione in quanto applica l'idea dell'essere ad oggetti già pensati, esercita quella funzione che dicesi Riflessione.
La prima di queste due funzioni, cioè la percezione, per se stessa è necessaria e non può essere oggetto d'arte, benchè possa dipendere dall'arte ciò che la precede come sua preparazione e condizione. Onde può benissimo dipendere dall'industria, dall'abilità, dall'arte dell'uomo l'acquistare queste piuttosto che quelle percezioni e il renderle a se stesso più vive e perfette coll'applicazione migliore degli organi sensori o di strumenti.
Ma riguardo alla seconda funzione, cioè alla riflessione, questa è quella che più dipende dalla volontà e dall'abilità dell'uomo, perchè la riflessione si può dalla volontà guidare in diversissime maniere e a diversissimi risultati. E però il buon uso di questa è il proprio oggetto dell'arte di pensare.
Dico «il proprio oggetto» perchè è bensì vero, che quello che precede e prepara le percezioni e le intuizioni determinate, può dipendere dall'attività volontaria e dall'abilità dell'uomo, ma questo stesso rientra sotto il dominio della riflessione, chè solo per l'uso di questa l'uomo può volontariamente preparare se stesso e la sua attenzione, com'anco preparare le cose esterne, per le quali preparazioni egli s'abbia piuttosto queste percezioni e queste intuizioni, che quelle.
70.
Colle quali osservazioni noi possiamo perfezionare la definizione dell'Arte logica.
Poichè così rimangono fissati i confini entro i quali il pensare può essere oggetto d'arte. È dunque l'arte logica: «l'Arte di riflettere».
71.
Se, le norme, secondo le quali quest'arte, procede si raccolgano, si formulino e distribuiscano in un ordine opportuno, si ha la scienza di quest'arte, che è la Logica.
La Logica dunque «è la scienza dell'arte di riflettere» (Def.2) ossia: «La Logica è la scienza dell'arte di dirigere la riflessione » (Def. 3).
II: II.Confini della logica.
72.
Da questa definizione si scorge che di frequente vennero confuse colla Logica delle scienze ad essa affini. Alcuni ingannati dall'etimologia della parola (1), credettero che nella Logica si dovesse trattare della Ragione sotto tutti gli aspetti. Ma la dottrina circa la natura della Ragione in senso subiettivo, cioè come a principio e potenza di ragionare » appartiene alla Psicologia, che è la prima parte della Metafisica; la dottrina circa la natura della Ragione in senso obbiettivo, cioè come «oggetto in cui terminano gli atti della potenza», appartiene all'Ideologia ed alla Teosofia, che è la seconda parte della Metafisica. La Logica dunque dee restringersi a considerare « l'esercizio della Ragione », e propriamente « l'Arte di questo esercizio», per la quale si conducono nel modo migliore, e al miglior fine razionale, i ragionamenti.
III: III. Origine della logica
73.
Or come pervennero gl'ingegni umani a scoprire e comporre la Logica, come scienza?
La ragione passa a' suoi atti in modo spontaneo, quando n'ha la materia, e qualche stimolo che ad essi la mova
E però c'è un'attitudine di ragionare naturale, e di ragionare rettamente; chè tutto ciò che non è retto, è contrario alla natura.
Quest' attitudine istintiva fu chiamata Logica naturale.
Ma in questa denominazione la parola logica non indica ancora nè un'arte, nè una scienza, ma una semplice disposizione.
74.
La ragione è ugualmente in tutti gli uomini; perchè la razionalità è dell'essenza dell'uomo. Ma l'attitudine a ragionare potentemente e rettamente non è data dalla natura in ugual misura a tutti, ma a chi più e a chi meno; e di qui la diversità degl'ingegni riguardo all'abilità ragionativa.
Essendo dunque quest'attitudine distribuita dalla natura agli uomini in diverse misure, essa non si può nè insegnare, nè apprendere. Ma ogni uomo incomincia la sua cultura da quella misura, che ha ricevuto d'attitudine ragionativa.
75.
L'attitudine ragionativa poi si può coltivare ed aumentare coll'esercizio del ragionare, e colla scienza logica.
E coll'esercizio del ragionare s'acquista l'abito d'usare della propria ragione con prontezza, con facilità, con diletto, e con sicurezza; il quale costituisce l'Arte del ragionare.
76.
L'arte appartiene all'azione, chè qui si tratta d'un abito attivo, la scienza appartiene alla speculazione. Quand'anco un uomo conoscesse speculativamente tutti i precetti della pittura e così n'avesse la scienza, non saprebbe per questo esercitare l'Arte del pittore, non n'avrebbe l'arte. All'incontro si può posseder l'arte e non la scienza. Il ballarino di corda possiede quell'arte, senza che gli bisogni conoscere i muscoli ch'egli move ballando, o le leggi del movimento e dell'equilibrio.
77.
Formatasi coll'esercizio l'Arte del ragionare, in che modo se ne ritrasse la scienza?
Mediante la riflessione sull'arte.
Suppongasi l'arte del ragionare giunta in un uomo alla sua perfezione: s'avrebbe in costui l'ideale del ragionatore.
Riflettendo sulla maniera colla quale questi ragionerebbe, e analizzando i diversi ragionamenti ch'egli farebbe, si troverebbero mantenute in essi costantemente certe norme e certe forme. Raccogliere tutte queste norme, ridurle in brevi proposizioni, ordinarle a metodo scientifico e dimostrarne la necessità, sarebbe lo stesso che comporre la Scienza dell'arte di ragionare.
Ma poichè il perfetto ragionatore che abbiamo immaginato, tra gli uomini non si trova, conviene che il filosofo raccolga le dette norme coll'osservare e analizzare i ragionamenti di molti e diversi ragionatori tra quelli che più s'accostano alla perfezione, riscontrandole tutte all'evidenza del primo principio, e così deducendole a priori.
Poichè si presenta incontanente la dimanda: come si conosce che un uomo è un giusto ragionatore? come, che un discorso proceda dirittamente? Questo non si può desumere dall'osservazione; che è anzi un giudizio critico sui ragionamenti osservati. Conviene dunque trarre tutto ciò dalla naturale intelligenza, cioè colle due potenze dell'intelletto e della ragione, nelle quali l'Intelligenza umana si riassume.
Vedemmo che l'intelletto porge il lume, che contiene virtualmente ogni cosa conoscibile e fa distinguere il vero ed il falso, e che la ragione lo applica a ciò che cade nel senso e nel pensiero. Se dunque si vuol conoscere se un ragionamento (che è cosa che cade nel pensiero) è diritto, conviene rilevare se esso è una retta applicazione dell'essere. Ora l'uomo sa che quest'applicazione è retta, se tutto ciò che contiene il ragionamento è contenuto virtualmente nello stesso essere che è la luce evidente e non rifiutabile. La possibilità di rilevare tutto questo sta nella ragione medesima, cioè nella virtù d'applicare l'essere, che è un dedurre in atto ciò che nell'essere indeterminato si contiene in potenza. La ragione dunque dà all'uomo la facoltà di conoscere, se ciò che gli viene proposto come una notizia dedotta dall'essere, sia veramente tale: e se è tale, dichiara il ragionamento retto, se non è tale, non retto, ma errante.
La Logica dunque come scienza si trova, dopo che esiste la logica come arte, parte coll'osservazione, parte coll'uso immediato della naturale intelligenza.
IV: IV. La scienza perfeziona l'abitudine e l'arte di ragionare
78.
Spiegato in che modo si formi la Logica mediante la riflessione e la meditazione filosofica, vediamo come la scienza perfezioni l'attitudine e l'Arte del ragionare.
La volontà è una potenza atta a movere e dirigere l'altre potenze dell'uomo e tra queste anche quella di riflettere. Ma essa prende dall'intelligenza le norme e i fini, secondo le quali move e dirige l'altre potenze. Qualora dunque l'intelligenza conosca le norme, secondo le quali procede un retto ragionamento, di questa scienza si serve la volontà a movere e dirigere la ragione. Quindi l'attitudine e l'arte stessa di ragionare si perfeziona negli uomini che hanno appresa la scienza logica.
V: V. Ed entro quali limiti
79.
La Logica dunque come scienza,
1° non dà all'uomo il lume dell'Intelletto;
2° non gli dà la Ragione, o potenza di ragionare;
3° non gli dà l'istinto e l'attitudine di ragionare;
4º non gli dà la quantità primitiva di quest'attitudine. Queste quattro cose sono doni della natura;
5° non gli dà quell'aumento e perfezionamento d'attitudine che s'acquista coll'esercizio, e che produce l'Arte di ragionare.
Ma la Logica come scienza aggiunge un novo perfezionamento a quest'attitudine naturale e abituale, e n'assicura l'esercizio, in quanto questo dipende dall'attività e dalla direzione della volontà umana.
80.
E quindi la definizione della Logica maggiormente si esplica. Chè da quanto dicevamo, risulta che «essa è quella scienza che raccoglie e dispone ordinatamente le norme, secondo le quali la riflessione procedendo, in qualunque specie di ragionamento, raggiunge la verità ed evita l'errore (Def.4).
VI: VI. Uffizi speciali e ripartizione della logica
81.
Gli atti della ragione, che dipendono dalla volontà e dall'abilità dell'uomo, sono ordinati a due scopi generali, secondo i quali gli atti stessi si possono distribuire in due generi:
1° alcuni di essi hanno per iscopo di presentare alla considerazione della mente le verità;
2° alcuni consistono negli assensi che l'uomo dà o nega alle verità che gli sono presentate.
82.
Quindi la Logica ha due uffici speciali:
1° quello di porgere all'uomo le norme secondo le quali la ragione possa presentare all'uomo le verità;
2° quello di porgere le norme secondo le quali l'uomo deve dare l'assenso alle verità.
83.
A queste due parti della Logica, conviene aggiungerne una terza, che insegna a giudicare, se ciò che si presenta davanti al pensiero sia la verità o non sia. Per fare questo giudizio convien ricorrere all'idea dell'essere, che è la verità primitiva, e sede dell'evidenza.
Quindi la divisione già prima accennata, secondo la quale la Logica abbraccia
I. la teoria di giudicare del vero e del falso, ossia del Criterio;
II. la teoria del ragionare;
III. la teoria degli assensi.
Raccoglieremo queste tre teorie in tre libri, invertendone l'ordine, acciocchè l'esposizione proceda dal facile al difficile; il libro primo dunque sarà degli Assensi e delle norme secondo le quali si devono dare o rifiutare; il libro secondo, del Ragionamento e delle norme secondo le quali si deve condurre; il libro terzo, della prima verità o del Criterio, col quale si fa saggio del ragionamento e delle sue conclusioni.