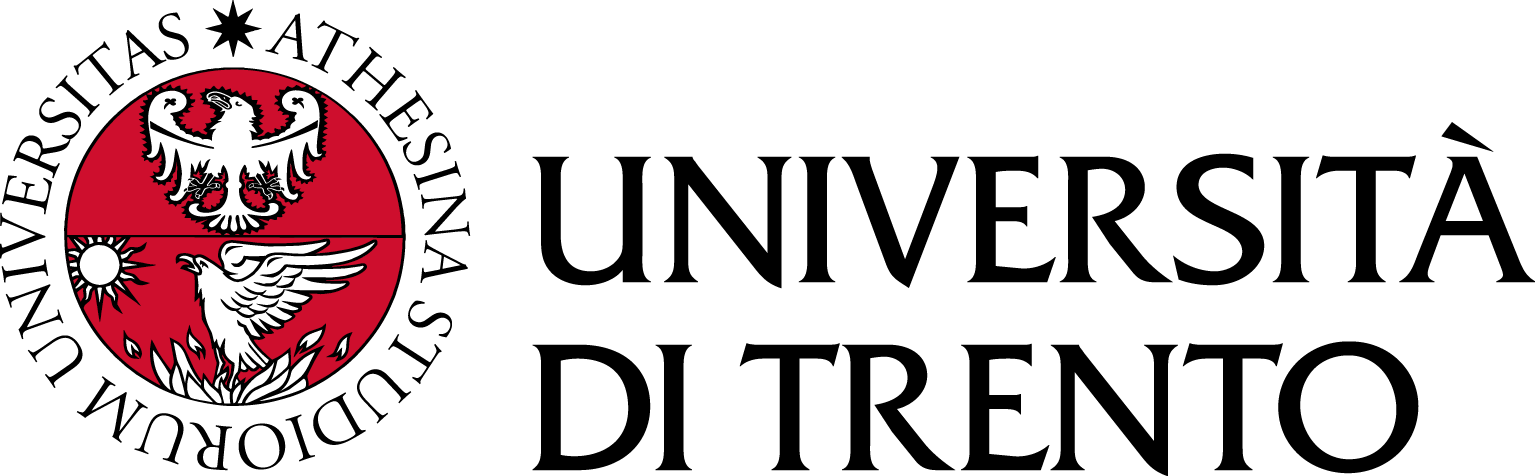I: Alcune parole preliminari necessarie a leggersi
1.
Trovandomi in una villa del Padovano, io posi mano a scrivere questo libro, a sfogo dell’animo mio addolorato; e fors’anco a conforto altrui.
Esitai prima di farlo; perciocchè meco medesimo mi proponea la questione: «Sta egli bene, che un uomo senza giurisdizione componga un trattato sui mali della santa Chiesa? O non ha egli forse alcuna cosa di te- merario a pur occuparne il pensiero, non che a scriverne, quando ogni sollecitudine della Chiesa di Dio appartiene di diritto a’ Pastori della medesima? E il rilevarne le piaghe non è forse un mancare di rispetto agli stessi Pastori, quasichè essi o non conoscessero tali piaghe o non ponessero loro rimedio?»
A questa questione io mi rispondevo, che il meditare sui mali della Chiesa anche a un laico non potea essere riprovevole, ove a ciò fare sia mosso dal vivo zelo del bene di essa, e della gloria di Dio; e parevami, esaminando me stesso, per quanto uomo si può assicurare di sè, che non d'altro fonte procedessero tutte le mie meditazioni. Rispondevami ancora, che se nulla v'avea di buono in esse meditazioni, non era cagion di celarlo; e se qualche cosa v'avea di non buono, ciò sarebbe stato rigettato da' Pastori della Chiesa: che io non pronunciavo con intenzione di decidere cosa alcuna, ma che intendevo anzi, esponendo i miei pensieri, di sottometterli ai Pastori stessi, e principalmente al Sommo Pontefice, i cui venerati oracoli mi saranno sempre norma diritta e sicura, alla quale ragguagliare e correggere ogni mia opinione: che i Pastori della Chiesa, da molti negozii occupati e aggravati, non hanno sempre tutto il comodo di dedicarsi a tranquille meditazioni; e che essi stessi sogliono desiderare, che altri venga lor proponendo e suggerendo quelle riflessioni, che potessero giovar loro nel governo delle loro Chiese particolari e della universale: e finalmente mi si presentavano innanzi agli occhi gli esempii di tanti santi uomini che in ogni secolo fiorirono nella Chiesa, i quali, senza esser Vescovi, come un san Girolamo, un san Bernardo, una santa Caterina ed altri, parlarono però e scrissero con mirabile libertà e schiettezza de' mali che affliggevano la Chiesa ne' loro tempi, e della necessità e del modo di ristorarnela. Non già che io mi paragonassi pur da lontano a queʼ grandi, ma io pensai, che il loro esempio dimostrava non essere per sè riprovevole l'investigare, e il chiamar l'attenzione de' Superiori della Chiesa sopra ciò che travaglia e affatica la Sposa di Gesù Cristo.
2.
Rassicuratomi sufficientemente con queste considerazioni, che io potea senza temerità dar luogo a' pensieri, che mi si affollavano nell'animo, sullo stato e condizione presente della Chiesa, e che non era riprensibile cosa nè anco il versarli in carta e altrui comunicarli, mi nasceva un altro dubbio risguardante la prudenza, anzichè l'onestà della cosa. Consideravo, che tutti quelli, i quali hanno scritto di somiglianti materie ne' tempi nostri, e che si sono proposto e hanno dichiarato di voler tenere una strada media fra i due estremi, in luogo di piacere alle due potestà, della Chiesa e dello Stato, sono dispiaciuti egualmente all'una ed all'altra: il che mi provava la somma difficoltà che hanno tali materie ad esser trattate con soddisfazione universale; e quindi predicevo a me stesso, che, in luogo di giovare, non avrei forse, in iscrivendo le dette mie meditazioni, se non urtato ed offeso contro a tutte e due le potestà.
Ma a questo, io di nuovo mi replicavo, che io ragionavo in coscienza, e che perciò nessuno aveva ragione di prendersela contro di me quando anche io errassi: che io non cercavo punto il favore degli uomini, nè alcun vantaggio temporale; e perciò, che se gli uomini delle due parti l'avessero presa contro di me, io sarei stato compensato dal testimonio della mia coscienza, e dall'aspettazione del giudizio inappellabile.
3.
D'altra parte, facevo meco stesso ragione, quali potessero esser queste cose di cui si dovessero poter offendere gli uomini delle due parti.
Dalla parte dello Stato, io consideravo, che una cosa sola poteva dispiacere ad alcuni, cioè il non saper io approvare la nomina de' Vescovi lasciata in mano alla potestà secolare. Ma se io disapprovo un sì fatto privilegio, consideravo, io sono altresì persuaso intimamente, che egli non è meno funesto alla Chiesa, che allo Stato; e che un grave errore politico è quello di credere il contrario; e le ragioni che io ho alle mani di questo apparente paradosso, ed ho esposte nel presente libro, sono tali, che io mi posso appellare a qualsiasi uomo di Stato, il quale sappia approfondire una questione e vincere per forza di mente i comuni pregiudizii, che sappia vedere le conseguenze lontane di un principio politico, che sappia calcolare e accordare insieme tutte le cause concomitanti, dalle quali sole si può predire e misurare l'effetto totale di una qualsiasi massima di Stato. Ciò posto, io penso di dimostrare non minor premura pel bene dello Stato, che pel bene della Chiesa, in sostenendo una sì fatta opinione; e perciò i Sovrani non potranno ragionevolmente avere a male ciò che io dico, ma anzi ben riceverlo. Tutto al più, chi è di contrario avviso, mi opporrà, che io ne so poco di politica; ma questo mio poco sapere sarà mai giusta ragione di farmi la guerra? Perocchè anche in politica, diceva un tale, la va bene spesso come la s'intende.
4.
Dalla parte della Chiesa, io non trovavo cosa che potesse altrui dispiacere nella materia di questo libro, se non forse ciò che accenno intorno all'eccesso delle riserve pontificie nelle elezioni. Ma d'altra parte, questo abuso non appartiene più al tempo presente, ma alla storia. E tutti gli uomini di buon senso converranno meco che, ove il filo del discorso l'esiga, non è punto da temersi ii confessare ingenuamente così palesi abusi; perocchè in così facendo, si manifesta che noi non parteggiamo in favore degli uomini e delle loro opere, ma che la sola verità e la causa di Dio ci sta sul cuore. Per altra parte, pareami che non mi dovesse trattenere dallo scrivere, la noja ch'io potessi recare a persone piuttosto di buone intenzioni, che di ampie vedute, avendo ragion ferma di credere che non fosse per dispiacere il mio scritto alla Santa Sede, al cui giudizio intendo sempre di sottomettere ogni cosa mia; giacchè il pensare della Santa Sede io l'ho sempre conosciuto per nobile, dignitoso, e sommamente consentaneo alla verità ed alla giustizia. Ora io non chiamavo un abuso se non ciò che i sommi Pontefici hanno riconosciuto per tale, e come tale corretto. Ricorrevami alla mente, fra l'altre cose, quella insigne Congregazione di Cardinali, Vescovi e Religiosi, a cui Paolo III, l'anno 1538, commise, sotto giuramento, di dover cercare, e manifestare liberamente a Sua Santità tutti gli abusi e deviazioni dalla retta via, introdottisi nella stessa corte romana. Non potevano darsi persone più rispettabili di quelle che la componevano: perocchè entravano in essa quattro de' più insigni Cardinali, cioè il Contarini, il Caraffa, il Sadoleto e il Polo; tre de' più dotti Vescovi, cioè Federico Fregoso di Salerno, Girolamo Alessandro di Brindisi, Giovammatteo Giberti di Verona; con questi si accompagnavano il Cortesi abate di S. Giorgio di Venezia, e il Badia maestro del sacro Palazzo, che furono poscia ambedue Cardinali. Ora questi uomini sommi, per dottrina, per prudenza e per integrità, i cui nomi valgono più di qualsivoglia elogio, adempirono fedelmente la commissione dal Pontefice ricevuta, e non ommisero punto di segnalare al santo Padre in fra i sommi abusi quello delle grazie espettative e delle riserve, e tutto ciò che ci cadea di difettoso nella collazione de' benefizii. Non ommisero nè anco di scoprire cuore. Per altra parte, pareami che non mi dovesse trattenere dallo scrivere, la noja ch'io potessi recare a persone piuttosto di buone intenzioni, che di ampie vedute, avendo ragion ferma di credere che non fosse per dispiacere il mio scritto alla Santa Sede, al cui giudizio intendo sempre di sottomettere ogni cosa mia; giacchè il pensare della Santa Sede io l'ho sempre conosciuto per nobile, dignitoso, e sommamente consentaneo alla verità ed alla giustizia. Ora io non chiamavo un abuso se non ciò che i sommi Pontefici hanno riconosciuto per tale, e come tale corretto. Ricorrevami alla mente, fra l'altre cose, quella insigne Congregazione di Cardinali, Vescovi e Religiosi, a cui Paolo III, l'anno 1538, commise, sotto giuramento, di dover cercare, e manifestare liberamente a Sua Santità tutti gli abusi e deviazioni dalla retta via, introdottisi nella stessa corte romana. Non potevano darsi persone più rispettabili di quelle che la componevano: perocchè entravano in essa quattro de'più insigni Cardinali, cioè il Contarini, il Caraffa, il Sadoleto e il Polo; tre de' più dotti Vescovi, cioè Federico Fregoso di Salerno, Girolamo Alessandro di Brindisi, Giovammatteo Giberti di Verona; con questi si accompagnavano il Cortesi abate di S. Giorgio di Venezia, e il Badia maestro del sacro Palazzo, che furono poscia ambedue Cardinali. Ora questi uomini sommi, per dottrina, per prudenza e per integrità, i cui nomi valgono più di qualsivoglia elogio, adempirono fedelmente la commissione dal Pontefice ricevuta, e non ommisero punto di segnalare al santo Padre in fra i sommi abusi quello delle grazie espettative e delle riserve, e tutto ciò che ci cadea di difettoso nella collazione de' benefizii. Non ommisero nè anco di scoprire con acuto sguardo e additare la profonda radice di tali abusi; e indicarono quella appunto che suol trarre dalla diritta via nell'uso del loro potere, sì lo Stato, che i ministri della Chiesa, e che anch'io sono per tale venuto indicando, cioè «l'adulazione raffinata degli uomini di legge». E le parole che usarono su questo argomento sapientissimi Consultori, nella relazione che sottoposero al Pontefice, non possono essere certamente più franche ed efficaci; perciocchè esse dicono così: «Tua Santità ammaestrata dallo Spirito divino, che, come dice Agostino, parla ne' cuori senza strepito alcuno di parole, ben conosce quale sia stato il principio di questi mali, cioè come alcuni Pontefici tuoi predecessori si ragunassero di que' maestri secondo i lor desiderii, che sogliono stropicciar gli orecchi, come dice l'Apostolo; non per doverne imparare ciò che far dovessero, ma per trovar ragione nello studio e nella scaltrezza di quelli, da far lecito ciò che piaceva: di che avvenne (senza contare che l'adulazione tien dietro ad ogni principato come ombra al corpo, e che fu sempre oltre modo malagevole udire la verità agli orecchi de' Principi) che incontanente uscissero de' dottori, i quali insegnassero essere il Papa padrone di tutti i beneficii, e perciò (potendo vendere il padrone quello che è suo, senza ingiustizia) seguirne, che nel Pontefice non cada simonia: perciò ancora, la volontà del Pontefice, quale si voglia, esser regola secondo la quale dirigere egli potesse le sue operazioni ed azioni. Laonde ciò che era libito, facevasi licito in tal legge. Sicchè di questo fonte, o santo Padre, quasi dal caval trojano, sboccarono nella Chiesa di Dio tanti abusi e tanti gravissimi morbi, de' quali or noi la veggiamo aggravata, e quasi sfidata, e n'andò la fama di tali vergogne (il creda la Santità tua a chi lo sa) fino agl'infedeli, che per questa cagione appunto mettono la cristiana religione in deriso, di modo che per noi è che il nome di Cristo si bestemmia fra le nazioni».
Dopo le quali considerazioni, io acquetai dentro di me ogni dubbiezza, e con sicuro animo e libera mano tolsi a scrivere questo piccol trattato, che prego Iddio d'indirizzare egli alla sua gloria, e a vantaggio della sua Chiesa.
Correzzola, 18 novembre MDCCCXXXII.
I: Della piaga della mano sinistra della santa Chiesa, che è la divisione del popolo dal Clero nel pubblico culto (1).
5.
L'Autore del Vangelo è l'Autore dell'uomo. Gesù Cristo venne a salvare tutto l'uomo (1), essere misto di corpo e di spirito. La legge della grazia e dell'amore dovea dunque entrare e impossessarsi, per cosi dire, sì della parte spirituale, come della parte corporea della natura umana; dovea perciò presentarsi al mondo cotale, che ottener potesse questo fine, e, per così dire, dovea esser mista anch'essa, parte componendosi d'idee, parte di azioni, e colla sua parola imperante a un tempo e vivificatrice rivolgendosi alla intelligenza non meno che al sentimento; acciocchè tutto quanto v’avea d'umano, e le ossa aride stesse potessero sentire la volontà del loro Creatore, ed esserne vivificate.
6.
Nè bastava ancora che il Vangelo penetrasse tutto l'uomo come individuo. Essendo la buona novella indirizzata a salvare l'umanità intera, non pure dovea agire sugli elementi della natura umana, ma dovea accompagnare colla sua azione divina questa natura senza mai abbandonarla in tutti i suoi sviluppamenti, e sorreggerla in tutti quegli stati suoi successivi, pe' quali sarebbe passata, acciocchè il suo peso o gravitazione verso il male non la precipitasse alla distruzione, ma presiedesse al suo moto una legge benefica di progressivo perfezionamento; dovea in somma la buona novella mescolarsi e svolgersi di pari passo cogli umani individui, e con questi passare nelle associazioni ch'essi formano; dovea allora rigenerare e salvare ogni società di uomini, la famiglia, la nazione, l'intero umano consorzio dopo aver salvato l'uomo; dovea impor leggi salutifere a tutte queste aggregazioni, e dominarle in nome del Dio pacifico; perocchè le società sono l'opera dell'uomo; e quella legge divina che domina e signoreggia l'uomo, è natural signora e dominatrice altresì delle opere sue.
7.
Gli Apostoli, mandati a istruire e battezzare tutte le genti dal divino Maestro, e ammaestrati dalla sua voce e dal suo esempio, si presentarono alla terra come gl'incaricati della grand'opera, e si mostrarono investiti di quella pienezza di spirito che corrisponder dovea a tanta missione.
Essi non tolsero già a fondare una scuola filosofica. Invitati a questo solo, gli uomini non sarebbero concorsi all'apostolica predicazione, che in piccol numero, eziandiochè quella scuola non insegnasse che verità. Così era avvenuto di tutte le sette filosofiche della Grecia, alle quali il concorso non fu già maggiore in ragione della parte di verità che insegnavano, o della minor quantità di menzogna che contenevano. Conciossiachè tutte le lingue insieme non avrebbero che date delle idee sotto varie espressioni; ma sempre idee; quando l'umana natura voleva di più, delle reali operazioni. E gli Apostoli non versarono sull'uman genere sole parole, come avean fatto i filosofi, ma delle opere: nè pure il parlare tutte le lingue sarebbe stato sufficiente all'esito felice di loro intrapresa. Al tempo stesso adunque, che alla parte passiva dell'umano intendimento rivelarono delle luminose verità e dei profondi misterii, e somministrarono ad imitare degli eroici esempii nella loro vita, alla parte attiva poterono dare un potente impulso, e una nuova direzione, e una nuova vita. Si noti bene: quando io parlo delle opere onde i banditori evangelici accompagnarono e completarono l'efficacia di lor parole, io non intendo solo di alludere ai portenti che operarono sulla natura esteriore, e co' quali provarono la divinità di loro missione. La potenza di cui si mostravan forniti, e per la quale piegavano le leggi della natura in ossequio e in testimonio delle verità che annunziavano, tutto al più avea per effetto di convincere gli uomini, che la dottrina loro era vera. Ma la verità della dottrina potea provarsi anche in altri modi; e potean gli uomini esserne convinti, senz’esserne soddisfatti; perocché, siccome dicevo, se la natura umana aspira di trovare la verità nell’ordine delle idee, e non può quietarsi fino che non l’abbia rinvenuta; essa però ha un’altra esigenza, non meno possente ed essenziale di quella, per la quale aspira continuamente a trovare la felicità nell’ordine delle cose reali, e verso di questa gravita per legge di sua natura.
8.
Erano adunque queste opere, colle quali gli Apostoli rinforzarono le alte parole ch'essi rivolsero al genere umano, le virtù da essi esercitate?
Certo, che un bisogno essenziale all'uomo è la virtù; perocchè senza la dignità morale, l'uomo è spregevole a se stesso; e chi è a se stesso spregevole, non è felice. E gli Apostoli mostrarono agli occhi degli uomini corrotti un nuovo spettacolo in se medesimi, tutte quelle virtù, che essi stessi aveano vedute nel loro divino Maestro, e da lui imitate.
Ma che poteva ciò fare? Il bisogno naturale di virtù era oppresso, soffocato nell'uomo della idolatria, dal bisogno fattizio d'iniquità; e le virtù dell'apostolato non furono già quelle che trassero dal fondo della umana natura un accento di approvazione, perocchè questo fondo era divenuto un abisso, di cui custodiva l'adito, come cerbero feroce, l'umana perversità, acciocchè ivi dentro luce non penetrasse; ma furono anzi quelle che attizzarono contro gli Apostoli del Signore la ferocia e la crudeltà de' figliuoli degli uomini, che si sbramarono e compiacquero del loro sangue. La fisonomia stessa della virtù già era dimentica agli uomini, o restava nota solo al loro odio; e dove anco alcuni di miglior volontà avessero ravvisata qualche traccia di sua bellezza, e fossero rimasti tocchi da qualche raggio di sue divine attrattive, la perfezione inarrivabile però, nella quale i Mandati del Cristo la praticavano, non poteva se non accrescere in essi, senza forze morali, la disperazione di conseguirla, e gittarli nell'avvilimento che è figlio alla disperazione, e padre a quella quiete di morte, in che l'uomo rifinito dalla depravazione spegne tutta la propria attività e si riposa nel vizio conosciuto. Tanto più, che nella vita di que' nuovi inviati appariva un ordine di virtù straniero all'umanità, perchè soprannaturale: e le virtù soprannaturali, non che conoscere, ma nè pure si potevano giustificare, se non mediante una sapienza che cominciava dal dichiarare insania quanto il senno umano credea fino allora di possedere di più incontrastabile, di più vantaggioso, e di cui più applaudiva a se stesso.
9.
Le dottrine evangeliche adunque non poteano esser rese possenti ed efficaci fino a dover penetrare e signoreggiare l'umanità ne’ suoi principii e nel suo sviluppamento, nè da' miracoli stupendi, nè dagli esempii virtuosi di che venivano accompagnate; imperocchè quelli non avevano virtù che di mostrare la verità delle praticate teorie, per se stesse sterili e inefficaci, e il pregio di questi non si poteva estimare, nè si voleva, da uomini sommersi nel vizio, o al più al più s'ammirava dai pochi, vanamente ed in parte, siccome prodigi di esseri straordinarii, non possibili ad imitarsi dal comune de' mortali. Ond'era dunque quella secreta virtù dalla quale avveniva che le parole apostoliche fossero più che mere parole, e perciò tanto si allontanassero da quelle de' maestri dell'umana sapienza? Onde derivava quella forza salvificatrice, che assaliva l'uomo fino dentro al recinto ultimo dell'anima, e ivi trionfava di lui? Quali opere singolari aggiungevan gli Apostoli per salvar tutto l'uomo, la parte intellettiva e la parte effettiva, e sommettere tutto il mondo ad una Croce?
Per conoscere queste opere, di cui ebbero comandamento di accompagnare il suono della loro voce i Mandati dal Cristo, conviene richiamare il testo della missione che ricevettero. Che disse loro Gesù Cristo? «Andando, ammaestrate tutte le genti, battezzandole nel nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo (1)». Nessun savio umano avea parlato giammai in questa maniera a’ suoi discepoli. In somigliante precetto è determinato ciò che gli Apostoli dovevano fare sì relativamente alla parte passiva dell’uomo, come relativamente all'attività di cui egli è fornito. Poiché rispetto all’intelligenza, che è passiva in quanto ha per ufficio di ricevere la verità, veniva detto «ammaestrate tutte le genti,» e contemporaneamente era comandato di rigenerare la volontà, in cui tutta l’attività umana, anzi tutto l’uomo si contiene, dicendosi «battezzandole nel nome del Padre, e del Figliuolo, e dello Spirito Santo»; instituendo così un Sacramento, che è la porta di tutti gli altri, nel quale una occulta virtù ricreatrice del Dio uno e trino dovea operare il rinnovellamento della terra, il risuscitamento della già estinta nel peccato ed eternamente perduta umanità.
10.
Furono adunque i Sacramenti, e fra essi il massimo, cioè il Sacramento che nasce dal sacrificio dell'Agnello, il quale avea detto prima di morire in cibandoli delle proprie carni: «Fate questo in mia commemorazione (1)» queʼ riti misteriosi, quelle opere potenti, onde gli Apostoli riformarono il mondo intero. Erano anch'essi questi Sacramenti altrettante parole, cioè segni, ma di quelle parole che non avevano avuto le scuole de' savii di Grecia: erano parole, ma di quelle che non ferivano solo gli orecchi materiali, nè solo erudivano l'intelligenza, ma che rivelavano al cuore riavvivato dell'uomo la immortale bellezza della verità, i reali premii della virtù, e che svelavano Dio al sentimento, il Dio nascostosi per non essere contaminato dal tocco della impura umanità: eran parole finalmente e segni, ma parole e segni di Dio, parole che creavano un'anima nuova dentro l'antica, una nuova vita, de' nuovi cieli ed una nuova terra. In somma, ciò che gli Apostoli aggiunsero alla loro predicazione fu il culto cattolico, che nel Sacrificio, ne' Sacramenti e nelle preghiere annesse principalmente consiste.
11.
Le dottrine che colla predicazione si diffondevano, erano altrettante teorie; ma la forza pratica, la forza di operare, nasceva dal culto, onde l'uomo attinger doveva la grazia dell'Onnipossente. Si fu solito di confondere queste due parole morale e pratica, e di dar loro un significato comune, dicendosi egualmente filosofia morale, e filosofia pratica. Così avvenne, che quando il filosofo insegnò i precetti della morale, si persuase con questo solo di essere uomo virtuoso; e che i suoi discepoli col pur udire a insegnare la definizione del vizio e della virtù, si persuasero pure di possedere già in sè la virtù, e di andarsene mondi dai vizii. Infelice umano orgoglio! diabolica superbia della mente, che crede di aver ogni bene compito in sè sola, e che ignora come il conoscere non è altro che un principio tenue ed elementare del bene, e come il bene vero e compito appartenga all'azione reale, alla volontà effettiva, e non al semplice intendimento! E pure quest'arroganza dell'intelligenza è la perpetua seduzione dell'umanità, che si continua tuttodì, dopo aver cominciato quel giorno, che fu detto all'uomo: «I vostri occhi si apriranno, e voi sarete simili a Dio (1)».
12.
Intanto, quando l'autore dell'uomo tolse a riformarlo, non si appagò di annunziare all'intelligenza i precetti morali; ma diede ancora alla sua volontà la forza pratica di eseguirli. E se questa forza la congiunse a de' riti esteriori, ciò fu per mostrare che egli la donava gratis all'uomo, e poteva aggiungere quelle condizioni che a lui ben piacessero; e se questi riti volle che fossero altrettanti Sacramenti, cioè segni, egli era perchè riuscissero accomodati alla natura dell'essere, per cui salute venivano istituiti; al quale, essendo intelligente, convenia che per mezzo appunto di segni e di parole si comunicasse la vita e la salute.
13.
La grazia, la quale rende forte la volontà, si comunica mediante l'intelligenza; ed è un cotal senso intellettivo quello col quale il cristiano sente il suo Dio, e di questo sentimento vive, ed è possente nell'opera. E gli Apostoli, e i loro successori, che a' pochi Sacramenti istituiti da Cristo aggiunsero gli ornamenti di sante preghiere, di cerimonie, di esteriori significazioni e riti nobilissimi, acciocchè il pubblico culto del Redentore degli uomini riuscisse più conveniente per decoro all'Uomo-Dio, ed all'assemblea di quelli che credevano nella sua parola; seguirono in far ciò l'esempio dato loro dal Maestro divino; cioè non introdussero cosa alcuna nel tempio priva di significazione: e tutto parlare, tutto significar doveva alte e divine verità; poichè niente potea essere muto e privo della luce del vero quanto si faceva nelle sacre ragunanze, dove convenivano ad adorare e pregare l'Essere che irraggia le intelligenze delle creature intellettive; e dove la Intelligenza suprema che riceveva l'ossequio ragionevole, segnava di sè, e di sè penetrava e vitalmente accendeva quelle nature. E queste cerimonie, questi sacramentali che la Chiesa, secondo la potestà ricevuta, aggiunge alla porzione di culto da Cristo istituita e che di tutto il culto cattolico è fondamento, non solo hanno loro proprie significazioni come i Sacramenti, ma partecipano altresì della forza vivificante di questi onde dai sacri veri significati alla mente, discende al cuore una virtù confortatrice, che riassume e rianima in esso la volontà del bene.
14.
Ma facciasi un'altra osservazione sul culto cristiano, introdotto ad un tempo colla cristiana predicazione. Questo culto, al quale Iddio aveva annessa la sua grazia, che dovea rendere gli uomini atti a praticare le dottrine morali che venivano loro insegnate, non fu solamente uno spettacolo presentato agli occhi del popolo, dove il popolo non intervenisse che per vedere ciò che si faceva, e non entrasse egli stesso parte e attore in questa religiosa scena di culto. Poteva certamente il popolo de' credenti nel Cristo essere ammaestrato col solo vedere ciò che facevasi nella Chiesa, come semplice spettatore di sacra rappresentazione, e Iddio, padrone assoluto de' suoi doni, poteva, se avesse voluto, aggiungere alla sola vista delle funzioni del culto esercitate da' sacerdoti, l'influenza vivifica della sua grazia. Ma per accomodar tutto all'uomo nel modo il più conveniente, non volle farlo: ed anzi volle che il popolo stesso nel tempio fosse gran parte del culto: e ora sopra il popolo si esercitassero delle azioni, come avviene quando si applicano a lui i Sacramenti e le benedizioni ecclesiastiche; ora lo stesso popolo unito d'intelligenza non meno che di volontà e di azione col Clero, operasse con esso il Clero, siccome in tutte le preghiere dove il popolo stesso prega, dove risponde ai saluti o agl'inviti de' sacerdoti, dove rende la pace ricevuta, dove offerisce, e dove interviene fino qual ministro di Sacramento, come nel Matrimonio. In somma nella Chiesa cattolica il Clero talora rappresenta Iddio, e parla ed opera sopra il popolo a nome di Dio; e talora anch'esso il Clero col popolo si mescola, e come appartenente al Capo dell'umanità col corpo congiunto, parla a Dio, e da lui attende la operazione misteriosa che il risani moralmente, e rinvigorisca. Sicchè il sublime culto della santa Chiesa è un solo, e risulta dal Clero e dal popolo, che con ordinata concordia e secondo ragione fanno insieme accordati una sola e medesima operazione.
15.
Nella Chiesa tutti i fedeli, Clero e popolo, rappresentano e formano quella unità bellissima, di cui ha parlato Cristo quando disse: «Dove due o tre saranno congregati in mio nome consenzienti fra loro in tutte le cose che dimanderanno, ivi io sarò in mezzo di loro (1)»; e altrove, parlando al Padre: «Ed io ho a loro dato quella chiarezza che tu hai data a me: acciocchè sieno una cosa sola, siccome anche noi siamo una cosa sola (2)». Si consideri che questa unità ineffabile di spirito, di cui parla Cristo con sì sublimi parole, e che tanto ripete, trova il suo fondamento nella «chiarezza di luce intellettiva» che diede appunto Cristo alla sua Chiesa, acciocchè i fedeli fossero una cosa sola con lui, aderenti ad una stessa verità, o più tosto a lui che è la verità: e che ad essere perfettamente consenzienti in quelle cose che domandano a Dio coloro che si ragunano a supplicarlo di ciò che abbisognano, è necessario che tutti intendano quello che dicono nelle preci, le quali innalzano in comune al trono dell'Altissimo. Quell'unanimità perfetta di sentimenti e di affetti è dunque quasi condizione che mette Cristo al culto che rendono a lui i cristiani, acciocchè esso culto gli sia accettevole, ed egli si trovi nel mezzo di loro; ed è degno di osservazione, con quanta efficacia Cristo esprima questa condizione o legge che contraddistinguer dee la vera preghiera cristiana, e separarla dall'ebraica, che in un culto materiale e in una fede implicita consisteva; perocchè non si contenta col dire che i suoi fedeli preghino insieme uniti, e che preghino con consenso di volontà; ma espressamente dice, che li vuole uniti «in tutte le cose che a lui addimandano». Tanto è sollecito Cristo dell'unità de' suoi! unità non di corpi, ma di mente e di cuore, per la quale unità la plebe cristiana di ogni condizione, raccolta a' piè degli altari del Salvatore, non forma più che una persona, ed è quell'Israello che, secondo la frase delle divine carte, pugna e s'innoltra come «un sol uomo». Ed ora quando mai più s'avvera, che tutta la plebe cristiana è consenziente in tutte le cose, e perfettamente una, se non allora che i cristiani adunati nel tempio eseguiscono concordi le sacre funzioni, tutti sapendo ciò che ivi fanno, ciò che vi si fa; tutti trattando gli stessi comuni interessi; tutti in somma entrando nel divino culto non solo materialmente, ma con perfetto intendimento de' sacri misteri, delle orazioni e simboli e riti onde il divino culto si compone? Egli è dunque necessario che il popolo possa intendere le voci della Chiesa nel culto pubblico, che sia istruito di ciò che si dice e si fa nel santo sacrificio, nell'amministrazione de' Sacramenti, e in tutte le ecclesiastiche funzioni: e però l'essere stato il popolo pressochè diviso e separato d'intelligenza dalla Chiesa nel culto, è la prima delle piaghe aperte e sparte che grondano vivo sangue nel mistico corpo di Gesù Cristo.
(2) Jo. XVII, 22.
16.
Più cagioni v'ebbero d'una sì dolorosa e infausta divisione; ma due sembrano essere state le principali.
Ne' simboli istituiti da Cristo, e ne' riti aggiunti dalla Chiesa, viene espressa e quasi effigiata tutta la dottrina, sia appartenente al dogma o alla morale del Vangelo, in una lingua comune a tutte le nazioni, cioè nella lingua de' segni, che mettono sott'occhio le verità in rappresentazioni visibili. Ma questa quasi lingua naturale e universale ha bisogno, per essere a pieno intesa, che quegli a cui è diretta abbia prima in se medesimo la cognizione delle verità, la cui ricordanza si vuole con essa suscitare nell'animo suo. E però il popolo cristiano tanto meno intende e prende degli alti sensi che esprime il culto cristiano, quanto è meno instruito coll'evangelica predicazione. Di che Cristo volle che precedesse alle azioni del culto, l'insegnamento della verità; e prima di dire «battezzate le nazioni», disse agli Apostoli suoi «ammaestratele». La scarsezza adunque di una vitale e piena istruzione data alla plebe cristiana (alla quale nuoce il pregiudizio gentilesco messosi in molti, che giovi tenerla in una mezza ignoranza, o che non sia atta alle più sublimi verità della cristiana Fede), è la prima cagione di quel muro di divisione che s'innalza fra lui e i ministri della Chiesa.
17.
Dico di piena e di vitale istruzione; perocchè, in quanto all'istruzione materiale, abbonda forse più in questi che in altri tempi. I catechismi sono nelle memorie di tutti: i catechismi contengono le formole dogmatiche, quelle ultime espressioni, più semplici, più esatte, alle quali i lavori uniti insieme di tutti i Dottori che fiorirono in tanti secoli, con ammirabile sottigliezza d'intendimento, e soprattutto assistiti dallo Spirito Santo presente ne' Concilii e sempre parlante nella Chiesa dispersa, ridussero tutta la dottrina del Cristianesimo. Tanta concisione, tanta esattezza nelle formole dottrinali è certamente un progresso; la parola è resa tutta e sola verità; una via sicura è tracciata, per la quale gl'istitutori possono far risuonare, senza molto studio lor proprio, agli orecchi de' fedeli che istituiscono, i dogmi più reconditi e più sublimi. Ma egli è poi egualmente un vantaggio che i maestri delle cristiane verità possano essere dispensati da un loro proprio e intimo studio delle medesime? Se è reso loro facile il fare udire agli orecchi de' fedeli che istituiscono, delle formole esatte; è egualmente reso facile il far entrare queste formole anche nelle loro menti? farle discendere ne' loro cuori, dove non giungono se non per la via della mente? L'essere la dottrina abbreviata; l'essere le espressioni, di cui essa si è vestita, condotte a perfezione e all'ultima esattezza dogmatica, e soprattutto l'essere immobilmente fisse e rese per così dire uniche; ha egli forse cagionato che sieno rese alla comune intelligenza anche più accessibili? Non è forse da dubitarsi per lo contrario, che una certa moltiplicità e varietà di espressioni fosse un mezzo acconcio di introdurre negli animi della moltitudine la cognizione del vero, giacchè una espressione chiarisce l'altra, e quella maniera o forma che non si acconcia ad un uditore, è mirabilmente accomodata ad un altro; in somma col chiamare in aiuto tutta per così dire la dovizia moltiplice della divina lingua, non si tentano tutte le vie, non si premono tutti gli aditi pe' quali la parola arriva negli spiriti degli ascoltatori? Non è vero che una sola ed immobile espressione è priva come di moto così di vita, e lascia pure immobile la mente e il cuore di chi l'ascolta? Non è vero che un istitutore che recita ciò ch'egli medesimo non intende, per quanto scrupoloso sia a ripetere verbalmente quanto ebbe altronde ricevuto, fa sentire d'avere il gelo sulle labbra, e sparge brine anzichè caldi raggi tra' suoi uditori? E le parole e le sentenze, più perfette e piene che sono, e più richieggono altresì d'intelligenza a toccarne il fondo, e più dimandano di sapienti dichiarazioni; perciocchè alla moltitudine riescono come pane sostanzioso allo stomaco del fanciullo, che nol digerisce fino che non gli si dia rammollato e tritato; e quelle formole, se si vuole, imperfette, che in altri tempi si usavano insegnando i dogmi cristiani, aveano forse nella loro stessa imperfezione questo vantaggio, che non comunicavano all'uman genere la verità tutta intera e soda, ma quasi direbbesi rotta in parti, e il disteso discorso emendava poi il difetto, se ve ne avea, delle espressioni, raccozzava ed univa quelle parti di verità solo nella parola esteriore smembrate: che anzi la verità stessa si raccozzava, per così dire, e si univa da sè medesima nelle menti e negli animi di quelli dove era entrata, e da sè ivi edificava se medesima e si completava. Certo la verità non può operare negli spiriti, se in luogo di lei, ci contentiamo del suo morto simulacro, di parole che la esprimono bensì esattissimamente, ma la cui esattezza poco giova più che a muovere la sensazione dell'udito, giacchè quelle parole incespano, e muoiono negli orecchi. Vero è che trattandosi ora di ammettere a' maggiori Sacramenti della Chiesa un fanciullo, si dimanda con sollecitudine s'egli sappia i principali misteri. Egli ne recita le formole: e questo è prova ch'egli li sa. Pure è ancora a dubitarsi assai, se il fanciullo il quale pronuncia a memoria le parole del catechismo, conosca di que' misteri un tantino più dell'altro che mai non le ha udite. Ma che? L'introduzione dunque moderna de' catechismi è stata più di danno che di vantaggio alla santa Chiesa? Strano sarebbe, se ciò fosse, l'effetto arrecato da una istituzione che tanto prometteva considerata in se medesima. Ma è da dirsi di que' compendii ammirabili del cristiano insegnamento, quello che l'Apostolo diceva della legge di Mosè; «ch'essi sono certamente e santi e giusti e buoni; ch'essi sono utili in mano di chi legittimamente li usa (1)». È dunque il difetto nell'uomo, e non nella cosa. Il catechismo all'uso moderno è invenzione ed ottima in se medesima, e che dovea nascere nella Chiesa per la legge di progressione a cui sono soggette tutte le umane cose dal Cristianesimo sorrette. Il Clero ci pensi: a lui sarà dimandato conto del bene o del male che avrà prodotto così questa, come tutte le altre mirabili istituzioni di cui lo Spirito Santo arricchisce continuamente la Chiesa del Verbo, e che, morte da se sole, aspettano la loro vita dalla sapienza del Clero.
(1) Rom. VII, 12 — 1 Timoth. I, 8.
18.
Ma non soli i riti parlano a' cristiani. Alla lingua di azione, ai segni dell'occhio, Cristo nell'istituzione del culto, e la Chiesa aggiunsero i segni dell'udito, cioè la parola vocale, e questa necessariamente dovette variare secondo la diversità delle nazioni. Contro questo impedimento ad una pronta comunicazione, la Providenza ebbe apparecchiato l'impero romano, che formando di innumerevoli nazioni una sola comunanza, aveva portata la lingua latina quasi fino alle estremità della terra; e i popoli chiamati al Vangelo si trovarono possedere una loquela comune, per la quale intendevano quelle parole, che accompagnano i Sacramenti ed i riti, gli spiegano, ed ancora più gl'informano. Conciossiachè per questo appunto le parole sono la forma de' Sacramenti; perchè Cristo con segni più determinati voleva parlare in modo al tutto chiaro all'intelligenza, e parlando ad essa, misticamente operare. E perciò conveniva che la virtù del Sacramento non fosse affissa alla materia che in essi si usa, e che per sè sola è mutola, e niente esprime di determinato; ma bensì alla parola, che dichiara all'intendimento l'uso di quella materia, e il fine al quale ella si adopera. E l'intendimento così ricevea luce pel significato delle cose manifestategli, e forza per la grazia che in quel sacro rito viene ministrata. Ma le guerre e i rimescolamenti de' popoli mutarono le favelle. La lingua della Chiesa cessò in tal modo, è già gran tempo, dall'essere la lingua de' popoli, e il popolo si trovò per una sì grande mutazione nella oscurità, diviso per intelligenza da quella Chiesa che seguitò a parlare a lui, e di lul, e con lui; a cui egli non può risponder meglio che possa un peregrino esule in terra straniera, ove non ode che de' suoni per lui disusati e privi al tutto di significazione.
19.
Queste due calamità, l'istruzione vitale diminuita, e la lingua latina cessata, piombarono sul popolo cristiano contemporaneamente, e per la stessa cagione, cioè per l'invasione che i barbari del settentrione fecero in tutte le contrade del mezzogiorno. Il paganesimo ed il suo spirito era inviscerato nella società; la cristiana dottrina non avea dominato fino a quel tempo che gl'individui. La conversione stessa de' Cesari non era che un acquisto d'individui; possenti sì, ma individui; e ne’ destini del Cristianesimo a’ quali tutto ubbidisce, era scritto, che la parola del Cristo penetrasse nella società, ch'ella giudicasse le scienze e le arti dopo aver giudicati gli uomini, e che ogni coltura, ogni fiore d'umanità, ogni vincolo sociale sbucciasse di nuovo da lei sola. La Providenza condannò dunque alla distruzione la società antica, e la schiantò fino dalle sue fondamenta. A condurre ad effetto tanto anatema, le orde de' barbari, guidate dagli Angeli del Signore, succedendosi e raddossandosi le une sopra le altre, non solo rovinarono l'impero romano, ma ne spazzarono fino anco le rovine; e così fu preparato il suolo ignudo al grande edifizio della società novella de' credenti. Di vero, nel corso dell'umanità, l'età di mezzo è un abisso che separa il mondo antico dal nuovo, i quali non hanno fra di sè comunione più che due continenti divisi da un oceano interminabile. Nelle bilancie della divina sapienza, le due calamità, dell'ignoranza e della perdita della lingua della Chiesa, che si rovesciarono in quelle circostanze addosso ai fedeli si trovarono pesar meno che non sia il bene inteso da lei nella distruzione radicale delle sociali istituzioni e consuetudini della idolatria: e per un giudizio così terribile, l'Eterno affrettò l'avveninento in sulla terra di una società battezzata anch'essa di sangue, per così dire, e nella parola del Dio vivo rigenerata.
20.
Ma se per queste due calamità Iddio permise che la Chiesa sua fosse vulnerata di sì larga piaga, quale è la divisione nelle funzioni del Culto della plebe cristiana dal sacerdozio, sarà ella insanabile una tal piaga? Sarà vero che quella plebe, che nel tempio del Signore per la primitiva istituzione non è solo spettatrice ma attrice in gran parte, non debba conservare appena se non una presenza materiale? Dico appena; imperocchè si fa troppo duro a un popolo d'intelligenza già dirozzata, intervenire stupidamente a dei riti a' quali egli più non appartiene, e che nè pure egli intende (1); e questa sua ripugnanza a frequentare le chiese cristiane, diventa poi un'ingiusta cagione, per la quale l'indiscretezza umana si fa a tirare sovente ad un senso così strano, e così lontano dal vero, quel compelle intrare del Redentore.
Ah se le nazioni sono fatte sanabili, molto più sanabili sono i mali della Chiesa; e ingiurioso al suo divino Autore mi parrebbe il pensare, che quegli che pregò l'Eterno Padre di rendere «tutti i discepoli suoi una cosa, come egli e il Padre erano una cosa sola (2)» permettesse poi che per sempre fra la plebe ed il Clero durasse un tanto muro di separazione, e che tutto ciò che si dice e si fa nella celebrazione de' divini misteri, riuscisse pieno di finzioni; permettesse che il popolo, a cui è nata la luce del Verbo, e ch'egli stesso è rinato al culto del Verbo, assistesse ai massimi atti di questo culto, quasi volea dire, come vi assistono le statue e le colonne del tempio, sordo alle voci che la sua madre la Chiesa gli volge ne' momenti più solenni, quando ella gli parla ed opera in persona e atto di Chiesa; e che il sacerdozio, segregato dal popolo ad un'altezza ambiziosa perchè inaccessibile, e ingiuriosa perchè ambiziosa, degenerasse in un patriziato, in una peculiare società, voglio dire divisa dalla società intera, con interessi proprii, con linguaggio proprio, con sue proprie leggi e costumi: conciossiachè tali sono necessariamente le deplorabili conseguenze di una cagione piccola in apparenza, le conseguenze a cui andrebbe soggetto indeclinabilmente quel sacerdozio che non istesse più in presenza del popolo, se non forse materialmente, e in realtà fosse assente dalla grande, cioè dalla popolare comunanza de’ fedeli.
(2) Io. XVII, 11.
21.
Ma se la piaga è sanabile, chi applicherà alla medesima il farmaco salutare?
Il Clero. Il solo Clero cattolico è quello che può prima prepararne, e poi ottenerne la guarigione. Sulle sue labbra sta la parola di vita; e Cristo ve l'ha posta a salvamento della umanità; esso è il sale, esso la luce, esso la medicina universale.
Che impedisce adunque che la medicina non si appresti, non si applichi?
Nasce ciò da un'altra piaga della Chiesa, che non manda men vivo sangue della prima, cioè dalla insufficiente istruzione dello stesso Clero.
II: Della piaga della mano diritta della santa Chiesa che è la insufficiente educazione del Clero.
22.
La predicazione e la liturgia erano ne' più bei tempi della Chiesa le due grandi scuole del popolo cristiano. La prima ammaestrava i fedeli colle parole; la seconda colle parole insieme e co' riti; e fra questi, principalmente con quelli a cui il loro divino Institutore aggiunse particolari effetti sopra natura, cioè a dire il Sacrificio ed i Sacramenti. Sì l'uno che l'altro di questi ammaestramenti era pieno: non si volgeva solo ad una parte dell'uomo, ma a tutto l'uomo, e il penetrava, come dicemmo, lo conquistava. Non erano delle voci che si facessero intendere alla sola mente, o de' simboli che non avessero altra potenza che sui sensi; ma sia per la via della mente, sia per quella de' sensi, le une e gli altri ungevano il cuore, e infondevano nel cristiano un sentimento alto su tutto il creato, misterioso e divino; il qual sentimento era operativo, onnipossente come la grazia che lo costituiva: perocchè le parole dell'evangelica predicazione uscivan da santi che travasavano su' loro uditori quell'abbondanza di spirito di cui essi riboccavano; ed i riti per sè efficaci, erano resi via più tali dalla buona ed ottima disposizione de' fedeli preparati a riceverne i salutari effetti dalla parola de' Pastori, e dalla chiara intelligenza di tutto ciò che si faceva, e che facevano essi stessi nella Chiesa. Da tali fedeli si cavavano i Sacerdoti; essi portavano alla Chiesa, che gli eleggeva all'alto onore di suoi ministri, una dottrina preparatoria, grande come la loro fede, che avevano attinta insieme col comune de' fedeli, coll'atto stesso della preghiera, nello stesso tempo della visitazione divina, cioè della grazia; e che faceva loro conoscere e intimamente sentire in tutta la sua ampiezza la religione sublime elie professavano. Certo, dalla conoscenza di quel popolo dal quale escono, si può predire de' ministri del Santuario: e ove conoscessimo soli i fedeli de' primi tempi e le sante loro assemblee, già n'avremmo abbastanza per intendere quali dovevano essere i loro Sacerdoti. Quindi si spiegano que' passaggi che sembrano agli occhi nostri altrettanti inesplicabili portenti, pe' quali talora un semplice laico dimandato dalle grida della moltitudine per suo pastore, e ricusante invano, trasformavasi in pochi giorni in un Vescovo consumato; cosa non punto rara nell'antichità, che ne ricorda tanti esempj, come di S. Ambrogio, di S. Alessandro, di S. Martino, di S. Pier Crisologo, e di altri tali sollevati d'un tratto dall'umiltà dello stato di semplici fedeli, dalla vita nascosta od occupata in governi profani, all'episcopato; i quali incontanente ch'erano messi in sul candelabro, raggiavano a tutta la Chiesa un maraviglioso chiarore.
23.
Per la medesima legge, anche i cherici nostri sono tali, quali sono i nostri fedeli. Perocchè, comunemente parlando, non possono essere altrimenti, uscendo da cristiani i quali nelle sacre cerimonie non hanno forse mai inteso cosa alcuna, e vi sono intervenuti siccome stranieri spettatori presenti ad una scena, su cui non sanno ben chiaro che si tratti da' Sacerdoti. Essi non ebbero forse mai un sentimento della propria dignità di membri della Chiesa; non mai concepita, sperimentata quell'unione in un sol corpo e in un solo spirito, nella quale e Clero e popolo si prostra innanzi all'Onnipotente e tratta con lui, ed egli con esso. E molti hanno fors'anco considerato sempre il Clero come una parte privilegiata e invidiabile, perchè vive de' proventi dell'altare, come un ceto di superiori non diversi da ogni altra superiorità laicale, un tutto a sè, e non la porzione più nobile del corpo della Chiesa ond'essi laici, sono pur membra minori di questo corpo che ha una sola operazione a meritare, una sola voce a pregare, un solo sacrificio a offerire, una sola grazia a derivare dal ciclo. Indi quel detto sì comune, che le cose di chiesa sono cose da preti. Deh onde si comincierà ad instruire e a formare in un vero e grande pensare sacerdotale, degli alunni che s'accostano alla scuola della Chiesa sì sparecchiati! Ignudi de' primi rudimenti, che dovrebbero supporsi in essi, e di cui l'educazione ecclesiastica non dovrebb'essere che un progressivo sviluppamento, essi non recano nè pur seco l'idea di ciò che vuol dire scienza del Sacerdote, non sanno che cosa vogliano volendo essere Sacerdoti, e che vadano a imprendere entrando alla scuola del santuario.
24.
Ed egli è più deplorabile, che non paja a prima giunta, un tale mancamento di acconcia preparazione in coloro che si ascrivono al Clero per ricevervi l'educazione di sacerdoti. Perocchè non si può edificare dove non vi ha terren sodo, massime trattandosi di una dottrina come quella del prete cattolico, che suppone necessariamente il cristiano; giacchè il cristiano non è che il primo grado del sacerdozio. Questo è cagione che gli alunni del santuario portano seco in esso una nullità di pensare ecclesiastico, se non anzi le idee di questo secolo assai bene da essi apprese, appunto perchè non ebbero altra vera scuola in contrario, e colle idee lo spirito secolaresco, il quale spirito si appiatta per alcun tempo anche sotto a un mantello nero, e in compagnia di costumi non rotti; ciò che illude i superiori, i quali non s'accorgono che ciò non basta alla Chiesa del Cristo, venuto a empire di sè tutte le cose, e molto più le menti de' Sacerdoti destinati a conoscere e far conoscere altrui tutto il grande di quella Religione chie dee conquistare e salvare l'umanità intera; quando all'opposto la povertà e la miseria d'idee e di sentimenti che forma l'apparecchio ed il seme della ecclesiastica istituzione moderna, non frutta che Sacerdoti ignari di ciò che è laicato cristiano, e di ciò che è cristiano sacerdozio, e del vincolo sacro di questo con quello. Tali ministri di petto angustiato, di mente ingrettita, sono poi quelli che, fatti adulti, Sacerdoti e capi alle chiese, educano degli altri Sacerdoti che riescono anco più fiacchi e più meschini di essi: e questi si fanno padri e istitutori ad altri decrescenti necessariamente di età in età, perocchè «il discepolo non è più del maestro (1)» fino a che lddio medesimo non mandi ajuto, prendendogli della diletta sua Chiesa compassionevole misericordia.
25.
Certo, solo de' grandi uomini possono formare degli altri grandi uomini: e questo è appunto un altro pregio dell'educazione antica de' Sacerdoti, che venia condotta dalle mani de' maggiori uomini che la Chiesa si avesse. All'opposto quindi hassi a ripetere la seconda cagione dell'insufficiente educazione de' sacerdoti moderni.
Ne' primi secoli, la casa del Vescovo era il Seminario dei Preti e de' Diaconi; la presenza e la santa conversazione del loro Prelato era un'infocata lezione, continua, sublime, ove la teoria nelle dotte parole di lui, la pratica alle assidue sue pastorali occupazioni congiuntamente apprendevansi. E in tal modo a canto degli Alessandri si vedevano allora crescere bellamente i giovani Atanasj; a canto de' Sisti i Lorenzi. Quasi ogni gran Vescovo preparava nella sua famiglia a se medesimo un degno di essergli successore, un erede de' suoi meriti, del suo zelo, della sua sapienza; e a questa maniera d'istituzione si debbono tutti que' sommi Pastori che resero così ammirabili, così felici i primi sei secoli della Chiesa: maniera ampla e compiuta d'istituzione onde passava per una tradizione famigliare di bocca in bocca fedelmente il sacro deposito delle divine e apostoliche dottrine: e che era pur essa apostolica, perciocchè gl'Irenei, i Panteni, gli Ermi, e tant'altri, avevano attinta la loro sapienza dai discepoli degli Apostoli, a quel modo stesso come gli Evodj, i Clementi, i Timotei, i Titi, gl' Ignazj, i Policarpi a' piedi degli Apostoli, per usare una frase della Scrittura, erano stati istituiti. Credevasi allora alla grazia, credevasi ehe le parole del Pastore istituito da Cristo a maestro e governatore della Chiesa, ritraessero dal divino Fondatore una particolare ed unica efficacia; e in questa fede prendeva nerbo e vita soprannaturale la comunicata dottrina, che si scolpiva indelebilmente negli animi: dove tutto consigliava a renderla operativa; la dolcezza dell'eloquio, la santità della vita, la composizione e gravità delle maniere, la persuasione profonda del grand'uomo che amministrava.
«lo mi sovvengo» dice Ireneo, parlando della sua prima e preparatoria istituzione sotto il grande Policarpo «io mi sovvengo di quanto è avvenuto allora, meglio che di tutto ciò che è accaduto di poi; imperocchè le cose che si sono apprese nell'infanzia, nutricandosi per così dire e crescendo nello spirito coll'età, non si dimenticano più mai; di guisa che io potrei indicare ancora il luogo ove stava seduto il Beato Policarpo quando predicava la parola di Dio. Io ho ancora vivo e presente nel mio spirito con che gravità egli entrava ed usciva da per tutto ove che egli se ne andasse; quale era la sua santità in tutta la condotta della sua vita; quale la maestà che egli splendeva nel volto e in tutta la composizione esteriore del suo corpo; quali erano le tante esortazioni onde paseeva il suo popolo. E' parmi di udirlo ancora raccontare in che egli aveva conversato con S. Giovanni, e con più altri che avevano veduto Gesù Cristo, le parole ch'egli aveva raccolte dalle loro bocche, e i particolari che gli erano stati narrati del divino Salvatore, sia circa i suoi miracoli, sia circa la sua dottrina: e tutto ciò che egli ne diceva era pienamente conforme alle divine scritture, siccome cose che venivano riferite da tali che erano stati testimonj oculari del Verbo, e della parola della vita Vero è che per la misericordia di Dio io ascoltavo tutte queste cose con istudio e con ardore, e che le scolpivo non sulle tavolette; ma sì nel più profondo del mio cuore; e Dio m'ha fatto sempre grazia di ricordarmele, e di riandarle a nell'animo mio (1)».
26.
Tale era la maniera di educazione del Clero, efficace e sapiente, per la quale i grandi Vescovi s'allevavano da se stessi il proprio Clero; il quale riusciva in tal modo un assembramento di grandi uomini, cioè grandemente consapevoli del proprio carattere, e pieni, per così esprimermi, del sacerdozio. Non è a dire quanto ella metteva di unione fra il supremo Pastore e il resto degli ecclesiastici suoi discepoli, suoi figliuoli! Le espressioni di alto e basso Clero erano allora inaudite; non furono pronunciate che assai più tardi. E questa unicità di scienza, questa comunicazione di santità, questa consuetudine di vita, questa scambievolezza di amore, per la quale il Vescovo antico trasfondeva nel suo giovane Clero e rinnovava se stesso maestro, pastore, padre, non è a dire che ordine armonioso, ammirabile cagionasse nel governo della Chiesa, qual dignità aggiungesse al sacerdozio, a questo corpo così uno e compatto, e qual forza salutare sopra i popoli. Scelto ed educato così, anche un Clero scarso suppliva ampiamente a' bisogni delle chiese; e il grado di semplice Sacerdote rendevasi tanto venerabile ed alto, che non v'avea alcuno, per quanto grande fosse nel secolo, a cui non paresse d'essere altamente onorato, venendovisi ascritto; ed era oggetto di attenzione ai popoli ed alle chiese colui che al presbiterato venisse dal proprio Vescovo destinato (1): la quale veneranda dignità del presbiterato faceval poi risplendere maggiormente quella dell'Episcopato, che sopra una sì ampia base erigevasi; e il Sacerdote al Vescovo, trovavasi per tal modo intieramente, di pieno affetto, e quasi direi per natura soggetto (2).
(2) Nelle lettere di S. Ignazio a diverse chiese si vede commendata singolarmente questa unità e sommessione del popolo e Clero al loro Vescovo. In quella a' Tralliani, lòdali della sommessione perfetta a Polibio loro Vescovo, di cui fa l'elogio: dice di lui che «è specchlo di quella carità che regna ne' suoi discepoli; il suo solo esteriore essere una grande istruzione: la sua somma dolcezza a essere la sua forza, di guisa che era difficile agli empj stessi il non rispettarlo». Scrivendo poi alla Chiesa di Magnesia, dà a que' preti una special lode per essere tanto sommessi al loro Vescovo Damaso, sebbene in età assai giovane». Nella lettera agli Efesiul, dopo levato a cielo quel santo Vescovo Onesimo, li commenda altamente, perchè «tutti erano strettamente uniti a lui, e massime il presbiterio (~ętrßurtsjov 000), cioè il clero, e perchè la grazia li faceva concorrere in Gesù Cristo con perfetto accordo a' preti ed al Vescovo, rompendo insieme uno stesso pane, che qual rimedio salutare ci dà l'immortalità e el preserva dalla morte».
27.
Nè fa maraviglia se que' santissimi Vescovi riserbassero gelosamente a se stessi l'ammaestramento de' cherici; quando anche quello del popolo con somma difficultà, e di rado assai, di confidar s'inducevano ad altre mani (1): conscii che Cristo avea commesso loro tutto il gregge, cioè Clero e popolo insieme; che sulle loro labbra avea messa la parola, e al loro carattere principalmente legata la missione e la grazia.
28.
Con questi sentimenti e con questi costumi del Clero, la Religione del Crocifisso avea trionfato de' tiranni e degli eretici, e l'invisibile suo Capo le destinava un'altra vittoria non meno bella sulla irruente barbarie. Come sopra toccai, coll'inviare i barbari del settentrione a distruggere la vecchia società de' suoi fondamenti, avea tolto in mira la superna Providenza di mostrare al mondo la forza della parola del Cristo, che sopravvive alla distruzione degli imperj e di tutte le opere degli uomini, e che vale a rifonder la vita anche nel carcame e nella polvere, a ricreare la società annientata, e in una forma degna di essa Providenza. E vuol notarsi, che quando gli uomini essenzialmente sociali, rotti tutti i vincoli che li legano insieme, avviliti, sparsi, senza ripieghi, senza speranze, naufragano, per così dire, nell'immensità di un oceano di sventure; allora essi ricorrono per un cotale impulso di natura, quasi ad ultima e sola tavola, all'ajuto di potenze soprannaturali, allora si volgono, e si concentrano nella Religione, idea oltremodo dolce a tutti gli sventurati, a' cui occhi ella fa nuovamente risplendere una speranza, e questa tutto promette nella perdita del tutto, perchè ella è grande come la stessa Divinità. Quindi la Religione, il cui sentimento precede lo sviluppo di ogni mezzo e istituzione sociale, e alla distruzione di ogni mezzo e istituzione sopravvive, si vide sempre alla testa, per così dire, de' popoli nascenti, o che risuscitano dal loro annientamento: e questa disposizione salutare, che al principio delle nazioni rese figlia della Religione ogni coltura, ogni sociale avvincolamento, dovea prepararsi al tempo dalla Providenza destinato, che fu il medio evo, anche pel Cristianesimo; acciocchè la Religione sola e tutta vera, non fosse ne' suoi effetti inferiore alle false o imperfette; e acciocchè, se queste, per contenere qualche particella di verità, aveano pur giovato mirabilmente le sociali unioni, e i sociali progressi de' popoli, apparisse tanto più giovevole quella, che in sè racchiudeva una verità intera, una pura e piena rivelazione, una grazia redentrice.
I popoli adunque, scossi e oppressi dalle sciagure temporali, ricorsero nelle braccia soccorrenti di quella Religione in cui avevano già conosciuta tanta dignità nell'ordine delle cose spirituali e divine; ed allora per la prima volta chiesero ad essa anche un umano sovvenimento. E le tenere viscere della madre universale de' fedeli, con quella carità ch'era nata con esse, si commossero a' bisogni de' popoli sbattuti, sgomitolati, per così dire, e fu loro conforto, scudo, e reggimento.
Allora il Clero, senza saper come, si vide alla testa delle nazioni; e mentre egli avea ceduto all'invito irresistibile della carità che lo pressava ed urgeva perchè soccorresse alla società traboccata, videsi, per un conseguente improvviso, padre delle città orfane, e reggitore de' pubblici affari abbandonati, e allora fu che la Chiesa si trovò incontanente piena a ribocco degli onori e delle ricchezze del secolo, le quali sdruscirono in essa quasi direbbesi pel proprio peso, a quel modo che entrano le acque del mare in un seno nuovo apertosi in fra terra dove siasi ritirato il continente.
29.
Questa nuova occupazione, che cominciò al Clero col secolo VI, era gravosa infinitamente e molesta a que' Prelati santissimi, che vedevano ad un tempo e gravarsi la Chiesa della soma de' beni terreni, perdendo essa quella povertà preziosa che gli antichi Padri avevano tanto commendata (1); e venir eglino oppressi dalla mole delle cure secolaresche, che toglieva i loro animi alla contemplazione delle divine cose, e rubava il loro tempo prezioso e le lor forze alla dispensazione della parola di Cristo a' fedeli, all'educazione del Clero, e all'assiduità delle pubbliche e private preghiere.
San Gregorio magno, che governava la Chiesa appunto in quel secolo, era inconsolabile de' pericoli che vedeva accompagnarsi necessariamente con questa nuova carriera che si apriva alla Chiesa: e non rifiniva nelle sue lettere di lamentarsi, e di piangere delle dure circostanze de' tempi suoi, in cui egli dee, anzi che il Vescovo, fare l'arcario o sia il tesoriere dell'Imperatore, «e sotto il colore dell'ecclesiastico reggimento, esser convolto da' flutti di questo secolo, che di frequente il sommergono (2)». Ripete questa frase più volte, e fra le altre in una lettera che scrive a Tcotista, che era sorella dell'Imperatore Maurizio, nella quale, per mostrarle la sua presente infelicità, toglie a descriverle la pace che, prima di essere innalzato al pontificato, godevasi nell'umile sua vita di monaco: «Sotto colore dell' episcopato, così egli, sono ritornato al secolo: giacchè in questa moderna condizione del pastorale offizio (3), debbo servire a tante cure terrene, che non mi ricorda d'aver mai servito a tante nella vita laicale. Ho perduto gli alti piaceri della mia quiete; e cadendo internamente, sembra al di fuori che io sia salito. Laonde piango me stesso, cacciato lungi dalla faccia del mio Creatore. Perciocchè ogni giorno io mi sforzavo di uscire del mondo, e di uscir dalla carne, di rimuovere tutti i fantasmi corporei dagli occhi della mia mente, e di vedere incorporeamente i gaudii superni; e non solo colle voci, ma colle midolle del cuore a Dio anelando gridavo: «A te ha detto il cuor mio: ho creato il tuo volto: il tuo volto, o Signore, io cercherò» (Ps. XXVI). E niente di questo mondo desiderando, niente temendo, parevami di stare in una cotale sommità delle cose tutte; sicchè per poco io credevo compiuto in me ciò che avea appreso della promessa del Signore fatta pel suo profeta: «io ti solleverò sopra le altezze della terra» (Is. LVIII). Conciossiachè sopra le altezze della terra è levato colui che col dispetto interior della mente calca anche quelle cose che sembrano nel secol presente alte e gloriose». Così dopo d'aver egli nobilmente descritto la dolcezza della vita privata data alla contemplazione, soggiunge, alludendo al carico vescovile che gli era stato imposto: «Ma di repente dalla sommità delle cose sospinto fra il turbine di questa tentazione, caddi ai timori ed agli angori: poichè anche non temendo nulla per me, tuttavia per quelli che a me sono commessi molto impaurisco. Ondechessia mi trovo sbattuto da' fiotti delle cause, e sommerso dalla fortuna, sicchè giustamente dico: Venni in alto mare, e la burrasca hammi ingojato» (Ps. LXVIII). Desidero tornare al cuore a dopo gli affari, ma sono escluso da lui pe' vani tumulti de' pensieri, e non posso tornarvi. Quindi è divenuto a me lontano quello che è dentro da me, a tale che non posso più ubbidire alla profetica voce che grida: «Tornatevi, o prevaricatori, al cuore (Ps. XXXVIII)» — E di questa guisa seguita lungamente il santo Papa a dolersi perchè «fra le cure terrene non può nè anco riandar colla mente, non che predicar colla voce, i miracoli del Signore, «ed» oppresso in quella dignità dal tumulto de' secolareschi affari, è divenuto un di quelli, di cui è scritto: gli hai rovesciati al basso in quella che si elevavano (Psal. LXXII) (4)».
(2) Epistol. Lib. XI ep. 1. Nos enim sub colore ecclesiastici regiminis, mundi hujus fluctibus volvimur, qui frequenter nos obruunt.
(3) Questa frase, ex hac moderna pastoralis officii continentia, mostra come quest'imbarazzo de' secolareschi affari fosse un peso nuovo, a cui l'episcopato non era fino allora soggiaciuto.
(4) Epist. Lib. 1, ep. V. Si possono vedere gli stessi lamenti, che fa il santo Pontefice, in tutte le lettere del Lib. 1, nella lett. 121 del L. IX, e nella 1 del Lib. XI.
30.
Ma così la divina Providenza, a cui mai non mentisce l'evento, ottenne ciò che volle, di far entrare la Religione del Cristo nella società, o più tosto di creare una società nuova, cristiana. La Religione del Cristo penetrò tutte le parti della società in que' secoli di mezzo, e per esse si sparse come olio balsamico sopra delle piaghe incancrenite; ella rifuse un nuovo coraggio, una nuova vita nell'uman genere sbalordito, abbattuto, prostrato sotto secoli di sciagure; ella il ricolse in sua tutela materna, ed ei, già vecchio, si vide, per un mirabile giro di prove lunghe e crudeli, ritornato nella età della prima infanzia: ella educò questo suo pupillo, questo nato della divina sua carità: e allora un nuovo seme fu gittato sopra la terra, il qual fruttò tutte le moderne civili istituzioni, voglio dire il seme di una pubblica giustizia, cosa inaudita al mondo antico, cristiana per essenza, cui tutte le umane passioni attentano infaticabilmente di ottenebrare, ma che pure splenderà sempre; imperocchè è impegnata la providenza del Re supremo a conservare l'opera sua, quella providenza che, tutto disponendo a suo libito, ha un fine. solo, la massima gloria del Diletto dell' Eterno, i destini gloriosissimi del regno eroicamente da lui conquistato. Indi venne quello che era ben da aspettarsi, che i capi delle nuove nazioni figlie del Vangelo mostrassero di sentire in sè stessi tutta la forza di quella Religione, che costituiva i loro nuovi Stati, e conscerava le loro nuove corone, e quindi dessero a vedere in sè stessi degli esempj inauditi di cristiana virtù: e questo spiega il perchè nel medio evo fosse un tempo in cui regnavano quasi altrettanti santi illustri, quanti crano i sovrani sui troni d'Europa, agli occhi de' quali l'esser figlio, l'esser tributario alla Chiesa, era la gloria più bella: e il come sapere e poter temperare la potenza per sè feroce colla mansuetudine del Vangelo raccolto avidamente dalla bocca de' Vescovi, onde attingevano altresì l'equità delle leggi e la pietà splendida delle loro regali operazioni, era un assiduo studio, un'occupazione dell'intera vita. Ma questo mostra altresì ragione perchè, mentre i regi erano sulla via della santità, il Clero per l'opposto era su quella della corruzione, dove in fine miserabilmente fu rovesciato.
31.
Il Clero, che aveva cominciato con dolore e con lagrime a ravvolgersi fra gli affari temporali, e a vedersi intorniato delle spoglie del secolo che venia meno; cominciò ben presto, come è la condizione della umana natura, ad affezionarsi ad esse e nelle occupazioni sopravvenutegli, alle quali era nuovo e non ancora scaltrito, per così dire, a sapersi guardar daʼ pericoli che menavano seco, egli dimenticò poco a poco i mansueti e spirituali costumi proprii del governo pastorale; e apparò, ahi troppo bene! la ferocia e la materialità de' profani reggimenti: si piacque di ravvolgersi co' nobili, e ne prese ed emulò i modi: e da quell'ora dispiacque a lui la mescolanza di sè col pusillo gregge di Cristo; da quell'ora ebbe a sue occupazioni più care le politiche ed economiche amministrazioni, ed essendo a lui più chiare, non penò a persuadersi cogli argomenti sofistici, che non mancano mai alle passioni, che quelle erano anche le più importanti per la Chiesa. Allora i Vescovi si disaggravarono sopra il Clero inferiore dell'istruzione del popolo e delle cure pastorali, divenute un fardello molesto, o certo incumbenze di second'ordine, e indi nacque l'istituzione delle parocchie, che nel secolo X si cominciarono a introdurre anche nelle città sotto gli occhi del Vescovo: indi le abitazioni vescovili cessando d'essere accademie floride di sapienza ecclesiastica e di santità per giovani alunni crescenti alle speranze della Chiesa, si convertirono in altrettante corti principesche rigurgitanti di militari e di cortigiani: e non più lo zelo ardente ed apostolico, e la meditazione profonda o l'esposizione degli eloquii divini formò il decoro di quelle case; ma loro somma lode fu il vedervi un qualche freno dato alla militare baldanza, ed una mediocre scostumatezza. E la cura postorale de' popoli fu così insensibilmente abbandonata quasi del tutto al basso Clero a tale, che un po' alla volta i Parrochi negli occhi de' popoli divennero i pastori, e si dimenticò che fosse pastore il Vescovo (1), quegli che veramente per istituzione di Cristo è il solo Pastore. I basso Clero poi, ed i Vescovi venendo ad avere in tal modo occupazioni di genere diverso e presso che contrarie fra loro, si divisero sempre più insieme: cessò la consuetudine della vita comune, gl'intertenimenti scambievoli divennero rari, e i più brevi possibili, perchè molesti a tutte e due le parti; che molesta è la conservazione di due ceti fra loro troppo disparati: e la venerazione e l'amor filiale de' preti si cangiò in una timida soggezione; come l'autorità tenera e paterna de' Vescovi prese l'aria di una superiorità mista ora di scherzevole disprezzo, ed ora di compassione: il Clero inferiore scapitò in tal modo nella opinione de' popoli, nel mentre che il Clero superiore acquistava un cotale splendore più apparente che reale (2). Nel ceto de' Sacerdoti così degradati, farà egli maraviglia che trovasse allora aperta la porta ogni ribaldaglia? e che il carattere sacerdotale fosse ignobile a sè medesimo, dopo esser tale divenuto all'occhio de' popoli? Vero è che le occupazioni della predicazione e della cura d'anime, abbandonate, come dicevo, quasi per intero al Clero Inferiore, sante essenzialmente, potevano giovare a sostenerlo dall'abisso; ma dall'istante che il più alto grado del sacerdozio risplendeva innanzi agli occhi di lui non d'altro fregiato che di opulenza e di potere; a questi beni dirigeva naturalmente anche il sacerdote semplice le sue mire, invidiando il suo Vescovo: e quindi la parola di Dio, il Sacrificio, i Sacramenti servirono a un tristo mercato in cui rinnovavasi ogni giorno mille fiate la vendita che avea fatto del divino Maestro il discepolo traditore. Per la stessa ragione i sacri riti, le divozioni, le preci, gli stessi dogmi furono apprezzati, predicati e ministrati al popolo in ragione di ciò che rendevano ai Sacerdoti: e così il popolo rimasto ignorante in tante altre parti della cristiana sapienza, seppe però sempre perfettamente le speciali dottrine dei suffragi, delle benedizioni, de' precetti della Chiesa, delle indulgenze, che avevano annesso un provento pe' ministri dell'altare; e seppe anco più cose a questo riguardo, di quelle che nella dottrina cristiana si contenesscro. Per questi passi, i preti divennero in tale avvilimento, che non fu riputato più degno che il Vescovo si abbassasse a pensare ad essi, e infastidirsi intorno alle cure moleste d'una educazione che non era più loro necessaria. I vizj traboccarono; si pensò di ripararvi colle leggi e colle pene, cioè con de' mezzi legali, proprii anch'essi più de' reggimenti temporali che dell'ecclesiastico, i quali mezzi, senza togliere la morale radice de' mali, li tengono per qualche tempo nel proprio alveo a tutta forza acciocchè non dirompano in una universale inondazione: ma finalmente sfiancati gli argini, ne fu allagata tutta la Chiesa; e fu minacciato da quelle onde rigonfie, vi fu atterrato e convolto anche il suo fasto profano, la sua temporale grandezza medesima. La madre de' credenti allora fu disconosciuta da' figliuoli suoi, e popoli interi rifuggirono dalla sua faccia che era come nascosta ai loro deboli occhi. L'Episcopato vide se stesso punito dalla Providenza in un modo a Iui inaspettato, improvviso; perocchè s'era avvezzo di persuadersi che i suoi interessi andavano innanzi allorchè gli riusciva di rasparsi un qualche palmo più di terra, o un qualche grado maggior di potere nel regno che viene da questo mondo: e intanto, assorto ne' piccoli suoi calcoli, non s'avvedeva che le nazioni da lui si ritiravano, e che le persone, la cura delle quali egli aveva abbandonato per quella delle cose materiali, abbandonavano scambievolmente lui, e riprendevano seco le cose che alle persone sempre vanno congiunte. L'Episcopato rifiutato, rinnegato, annullato d'improvviso, e quasi a un cotal cenno invisibile in centinaja di diocesi, l'Episcopato che discendeva da se stesso dal trono perchè venuto in odio a se stesso (e furono i vescovi di Germania, di Francia e d'Inghilterra che strapparono dalle proprie fronti le bende del regale loro sacerdozio), l'Episcopato, dico, che può esser punito, non però perire intieramente, perchè la parola di Cristo l'ha costituito acciocchè duri sino alla fine de' secoli, si scosse dal suo letargo, rabbrividi al proprio pericolo, e l'educazione trasandata de'sacerdoti fu una delle prime cagioni del disordine, che gli si presentarono: allora, al fine di provvedervi, fu pensato finalmente all'istituzione de' Seminarj.
(2) In tutto quello che qui diciamo, abbiam detto, e diremo, noi parliamo in generale: vi hanno le sue eccezioni, perocchè in ogni tempo v'ebbero santissimi Vescovi nella Chiesa. E vogliamo averlo avvertito una volta per sempre.
32.
Furono inventati i Seminarj per provvedere alla nulla educazione del Clero, come furono inventati i catechismi per provvedere alla nulla istruzione del popolo. Non si ebbe coraggio (e non era sperabile che lo si avesse) di ritornare allo stile antico, che il Vescovo personalmente formasse il suo popolo ed il suo Clero: si ritenne la massima di lasciare questi travagli al Clero inferiore: pure ne' Vescovi si destò la vigilanza, la disciplina ne guadagnò immensamente, furono riformati i costumi, si vide risplendere uno zelo proprio di quella sfera limitata e in gran parte materiale di attività, dove il Clero inferiore da qualche secolo è circoscritto; ma non si trovò più l'arte di dare alla Chiesa de' grandi uomini, de' sacerdoti che conoscessero la vastità della loro missione, che riguardassero la Chiesa nella sublime sua università e grandezza, e che apparissero interiormente posseduti, dominati da quel sentimento del Verbo che formava il carattere de' sacerdoti primitivi; da quel sentimento, che assorbendo tutta l'anima, la toglie al mondo transitorio, la fa vivere nell'eterno, e dalle magioni eterne appunto le insegna a rapire un fuoco che è atto di ardere la terra tutta. Solo i grandi uomini, lo ripeto, valgono a formare uomini grandi; e per giudicare qual differenza v'abbia fra' discepoli, basta paragonare insieme i maestri. Ahimè! da una parte stanno gli antichi vescovi, o certo uomini i più insigni della Chiesa, e dall'altra i giovani maestri de' nostri Seminarj! qual confronto!
33.
Considerisi con quanta cautela e difficoltà si toglieva ne' bei tempi a istituire una scuola pel popolo (1), non che pel Clero, che fosse diversa da quella del Vescovo, il quale non vi si risolveva se non mosso dalla straordinaria sapienza e santità degli uomini, a cui ne affidava il carico; come appare nella istituzione dell'accennata scuola d'Alessandria, che fu certamente la prima di questo genere, perchè istituita sotto S. Marco (2); e considerisi dall'altro canto quanto si abbondi, o almeno si creda di abbondare oggidì di maestri idonei ad insegnare al Clero la dottrina e la religione di Cristo! Non solo ogni diocesi ha il suo seminario, e in ogni seminario molti maestri; ma per la somma abbondanza, in che ne sono i tempi nostri, per la somma facilità, che ha oggidì il Vescovo di trovare de' preti che possano essere istitutori del suo giovane Clero, si rimutano i maestri dopo pochi anni d'insegnamento, promovendoli a un qualche meno magro benefizio, e sostituendovene degli altri tutti nuovi, i quali sebbene non abbiano ancora acquistata alcuna sperienza delle cose umane, nè finito d'imparare dalla sociale consuetudine i principj del senso comune; tuttavia hanno pur ora assoluto il gran corso delle scuole seminariali, questo non plus ultra del moderno sapere ecclesiastico; dopo il quale i teneri ministri dell'altare sono senza indugio applicati agl'impieghi, e così dallo studio onoratamente dispensati. Intanto la scienza della religione, che que' giovinetti maestri ebbero ricevuta nel Seminario, spezzata in parti, o più veramente ristretta a quelle parti che parvero le più necessarie a poter disbrigare tosto e materialmente gli ufficj ecclesiastici che il popolo ed il governo esige da' preti per ragion di giustizia; questa grande scienza, dico, non ha acquistato nell'animo del giovane prete nè radice, nè unità; non è penetrata nè punto nè poco fino all'animo suo; privo egli del sentimento della scienza; privo della vera intelligenza di lei; egli la porta attaccata, e per così dire pendente alla giovanile memoria, ed è per questa memoria appunto ch'egli si crede più atto di un savio provetto all'ufficio di precettore. Ma che? Uomini di memoria, si vogliono? tali riusciranno gli allievi. Ben altro che un parlare alle memorie, era quel modo d'instruire, che riferisce Clemente di Alessandria usato dal suo maestro, cui egli chiama «un'ape siciliana, che suggeva i fiori de' profetici ed apostolici prati, al fine di fabbricare dentro agli animi di coloro che lo udivano, il miele di una sincera ed incorrotta. cognizione (3)». Finalmente, in tempi, ne' quali la grossezza della pensione annessa agli ufficj è assai sicuro indizio da giudicare dell'abilità degli uomini che vi sono applicati; non hassi fortemente a dubitare del gran sapere de' maestri de' nostri seminarj, al cui incarico è annesso sì scarso provento, che molte volte lor pare di toccare il ciclo col dito quel dì che uscendo di Seminario giungono sopra un benefizio parocchiale, al quale, anzichè alla cattedra, ebbero, come a termine fisso de' loro voti, sempre l'animo inteso (4)?
(2) L'attesta S. Girolamo, de Vir. ill. c. 36.
(3) Strom. L. 1. Secondo l'opinione di Eusebio (Hist. L. V, c. 11), il maestro, di cui qui parla Clemente, è S. Panteno, che presiedette alla celebre scuola di Alessandria.
(4) Il bisogno de' nostri tempi esige, che gli stipendj de' maestri seminarlali equivalgano almeno al provento delle più pingui parocchie; e che i maestri non si rimovano dalla cattedra se non promovendoli a qualche canonicato o dignità capitolare, o anche all'episcopato. Nella celebre scuola d'Alessandria, S. Dionigi, S. Eracleo, e il grande S. Achilla passarono tutti e tre l'un dopo l'altro da quella cattedra sulla sede vescovile di quella città, che era la seconda dopo Roma. Allora si aveva recente negli orecchi e nell'animo la parola dell'Apostolo che raccomandava a Timoteo di trovare «uomini idonei ad insegnare altrui» la grande dottrina evangelica. Questi uomini li caratterizza l'Apostolo coll'epiteto di «fedeli», e vuole che Timoteo non solo dia loro la dottrina che aveva ricevuta da lui, ma «loro la commendi»; et quæ audisti a me per multos testes, hæc commenda fidelibus hominibus qui idonei erunt et alios docere. II Timoth. n, 2.
34.
Or se a cosi piccoli uomini si affida l'ammaestramento del Clero, non è maraviglia che questi, rimossi gli scritti de' Santi e de' sapienti, adoperino a testo di loro lezioni de' piccoli libri, concinnati, come dicono ne' frontispizj, in uso della gioventù, da testicciuole loro pari. Imperocchè tutto vuole essere proporzionato, tutto si chiama; e un difetto ne produce un altro: e cotesta magrezza e vanezza de' libri usati nelle scuole, è appunto la terza cagione dell'insufficienza di loro educazione.
35.
V'hanno due maniere di libri. Alcuni sono libri classici, solenni, che contengono la sapienza del genere umano, scritti da' rappresentanti di questa sapienza: libri dove non è nulla d'arbitrario e di sterile, nè nel metodo, nè nello stile, nè nella dottrina: dove non sono registrati solamente de' veri particolari, in una parola, dell'erudizione; ma sono date le universali verità, le dottrine feconde, salutari, dove l'umanità ha trasfuso se stessa co' suoi sentimenti, co' suoi bisogni, colle sue speranze. Vi sono all'incontro degli altri libri minuti e parziali, opere individuali, dove tutto è povero, freddo; dove l'immensa verità non comparisce che minuzzata, e in quella forma, in che una menticina l'ha potuta abbracciare; e dove all'autore spossato nella fatica del partorirla, non è restato vigore d'imprimere al libro altro sentimento che quello del suo travaglio, altra vita che quella di uno che sviene; libri, a che il genere umano uscito degli anni della minorità fanciullesca volge per sempre le spalle, poichè non vi trova se stesso, nè i suoi pensieri, nè i suoi affetti; e a cui tuttavia si condanna barbaramente e ostinatamente la gioventù, che pur col senso naturale li ripudia, e che bene spesso, per un bisogno di cangiarli in migliori, cade nella seduzione de' libri corrompitori, o acquista un'avversione decisa agli studj, o da lungo patir violenza nello stringimento delle scuole prende un odio occulto, profondo, che dura quanto la vita, contro i maestri, i superiori tutti, i libri, e le verità stesse in que' libri contenute: sì, un odio, dico, non bene spiegato talora, ma che lavora di continuo sotto altre forme da quelle di odio; che si veste di tutti i pretesti; che ove si spieghi, è di maraviglia a colui stesso che lo ha in sè, perocchè non sapea d'averlo e non se ne sa rendere la ragione; e che ha tutto l'aspetto di empietà, o di brutale ingratitudine verso i precettori, per altro buoni, e che hanno profuse tante cure, tante parole, e tanto amore verso i loro discepoli.
36.
Ne' principj della Chiesa, la divina Scrittura era l'unico testo dell'istruzione popolare ed ecclesiastica. Questa Scrittura, che è veramente il libro del genere umano, il libro (GBrix 000), la scrittura per antonomasia. In un tal codice l'umanità è dipinta dal principio sino alla fine; comincia coll’origine del mondo, e termina colla futura sua distruzione; l'uomo si sente se stesso in tutte le modificazioni di cui è suscettivo, vi trova una risposta precisa, sicura e fino evidente, a tutte le grandi interrogazioni che ha sempre a fare a se stesso; e la mente di lui vi resti appagata colla scienza e col misterio, come il suo cuore vi resta pure appagato colla legge e colla grazia. Egli è quel libro «grande» di cui parla il profeta, scritto «collo stilo dell'uomo (1)»; perocchè in quel libro l'eterna verità parla in tutti que' modi, a cui si piega l'umana loquela: ora narra, ora ammaestra, ora sentenzia, ora canta: la memoria vi è pasciuta colla storia; l'immaginazione dilettata colla poesia; l'intelletto illuminato colla sapienza; il sentimento commosso in tutti insieme questi modi: la dottrina vi è così semplice, che l'idiota la crede fatta a posta per sè; e così sublime, che il dotto dispera di trovarci fondo: il dettato sembra umano, ma è Dio che in esso parla. Quindi «la Scrittura, dice Clemente di Alessandria, accende il fuoco dell'anima, e dirige nel tempo stesso convenientemente l'occhio alla contemplazione, deponendo per avventura in noi qualche seme, come fa l'agricoltore nella terra, e quel seme che ritrova in noi fecondando (2)»: le quali parole se si possono applicare alle lettere in genere, molto più propriamente convengono alle divine.
(2) Strom. Lib. 1.
37.
Tale era il libro delle scuole cristiane; e questo libro grande in mano de' grandi uomini che lo sponevano, era il nutrimento di altri grandi uomini. Fino che i Vescovi furono personalmente i maestri del popolo e del Clero, essi furono anche gli scrittori della Chiesa e della società. Quindi quasi tutte le grandi opere ne' primi sei secoli sono scritte da Vescovi, ed è per così dire un'eccezione della regola, trovare in quel tempo delle opere non iscritte da Vescovi, eccezione che cade a favore di qualche ingegno straordinario, come di Origene, di Tertulliano e d'altri tali, a' quali, atteso il loro gran merito, si apriva l'adito anco alla cattedra cristiana. Questi libri, dovuti all'Episcopato, formano per così dire una seconda epoca nella storia de' libri adoperati a formare la gioventù nelle scuole cristiane ed ecclesiastiche: e formano l'eredità che i Vescovi lasciarono al Clero inferiore, quando per gli affari della società politica, crollante da tutte parti e rifuggentesi nel seno della loro carità, essi furono tolti da quelle funzioni che avevano fino allora riguardate come annesse indivisibilmente al pastorale loro ufficio, quale era la formazione del popolo e del Clero; alla quale opera insensibilmente (1) il Clero inferiore surrogarono; e in prima quella parte del Clero che era a' Vescovi più vicina e per vita ecclesiastica più veneranda, cioè i canonici, e i monaci che la divina Providenza fece in quel tempo appunto fiorire in sovvenimiento al gran bisogno della Chiesa (2). Questa parte del Clero, sottentrata a Vescovi nella educazione della cristiana ed ecclesiastica gioventù, ricevette con rispetto quella preziosa eredità de' venerabili pastori e padri della Chiesa, e la riguardò come una norma sicura a cui attenersi nelle sue istruzioni: sicchè per lunga pezza dappoi può dirsi che gli antichi Vescovi erano colle loro opere i maestri ancora della gioventù; ma v'avea una differenza immensa, che prima l'ammaestravano colla viva voce e colla viva loro presenza; poscia solo colle loro scritture, morte per se stesse; nè v'avea guari chi le potesse ravvivare fra' precettori di quegli infausti tempi. Il Clero del second'ordine non tolse per così dire a far nulla da se stesso per gli cinque secoli successivi; non fece che ripetere quelle istruzioni e que' documenti che avea ricevuto dagli antichi padri (3), sia perchè non avesse la coscienza di essere egli il maestro in Israello, quella coscienza che tanto ingrandiva il petto a' Vescovi, sia perchè rimanesse anche oppressa la sua intellettiva attività dalle lagrimevoli circostanze de' tempi, che di stragi, di devastazioni e d'infortunj ogni cosa riempivano. Veramente, cessate le incursioni, e stabiliti i barbari nelle terre conquistate, i nuovi maestri posero mano anch'essi a comporre de' libri, i quali ritennero appunto il carattere della loro condizione; e quindi tanto a quelli degli antichi Vescovi riusciron minori per autorità, grandezza di dire, e sicurtà di pensare, quanto queʼ ministri subordinati erano inferiori in dignità e in autorità ai principi della Chiesa. Queste opere non poterono avere l'impronta della originalità; esse furono de' Compendj o Somme, nelle quali con ordine scientifico si registravano le cristiane dottrine; compendj per altro lato richiesti dal bisogno di facilitare l'acquisto della ecclesiastica tradizione, i cui monumenti di secolo in secolo immensamente accresciuti, ne rendevano troppo vasto lo studio; e questi compendj costituirono l'era della Teologia scolastica, che propriamente può dirsi l'opera caratteristica del magisterio presbiterale; de' quali compendj, il primo, e che valse per la sua celebrità a segnare il cominciamento dell'era, è quello che compilò nel secolo XII il Maestro delle Sentenze, cioè Pietro Lombardo. Ottimo pensiero l'epitomare la dottrina sparsa negl'immensi monumenti della ecclesiastica tradizione. In questi le cose stesse si ripetono necessariamente le mille volte, e quindi la fatica pure dello studiante s'immila. Ma la cristiana dottrina non si abbreviò solo in que' compendj per dirvi una volta ciò che in tanti monumenti trovavasi infinite volte ripetuto, cosa commendabile; ma la si abbreviò ancora in un'altra maniera, cioè abbandonando interamente tutto ciò che spettava al cuore (4) e alle altre facoltà umane, curandosi di soddisfare solo alla mente. Quindi questi nuovi libri non parlarono più oggimai all'uomo come gli antichi; parlarono ad una parte dell'uomo, ad una facoltà sola, che non è mai l'uomo: e le scuole acquistarono così quel carattere angustioso e ristretto che formò degli scuolari una classe separata dal restante degli uomini, a cui quelli abbandonarono il senso comune per attenersi a de' sottili ragionamenti. Tale effetto era naturale. Il formare un discorso pieno, persuasivo, che si rivolge all'uomo intero, stava nel carattere del Vescovo, che non è semplicemente istruttore, ma è padre (5) e pastore, a cui è data la missione non pure di mostrare la verità, ma di farla amare altresì, e di salvar l'uomo per la verità. Il prete non può tanto, e sente di non esser di ciò incaricato: quindi ristringesi a porre freddamente il vero sotto gli occhi de' discepoli, i quali ragionano con esso lui quasi eguali con eguale (6); e il suo metodo è scientifico, cioè non ha relazione alla persuasione che esige una disposizione varia, ma all'ordine oggettivo delle dottrine che è assoluto e invariabile; il che pure scema la pienezza del dire; e introduce quell'elemento di razionalismo che nel secolo XVI si sviluppò pienamente nel protestantismo (7), nel quale la scienza sacra, e la religione del Cristo uscirono al tutto dal Clero e rimasero, per così dire, intieramente secolarizzate.
(2) «La maggior parte delle scuole erano ne' monasteri, e le medesime cattedrali venivano offiziate da' monaci in alcuni paesi, come in Inghilterra e in Alemagna. I Canonici, le cul Instituzioni cominciarono alla metà dell'ottavo secolo con la regola di S. Crodegango, facevano quasi monastica vita, e le loro case chiamavansi parimente monasteri. Ora io computo i monasteri fra i principali mezzi, de' quali si è servita la Providenza per conservare la religione ne' più miserabili tempi. Erano questi asili della dottirina e della pietà, mentre che la ignoranza, il vizio e la barbarie innondava il rimanente del mondo. Vi si seguiva l'antica tradizione nel celebrare i divini Offizj, nella pratica delle cristiane virtù, i cui esempj vedevano i giovani vivere negli antichi. Vi si custodivano i libri di molti secoll, e se ne scrivevano de' nuovi esemplari; ed era questa una occupazione de' monaci: e non ci rimarrebbero libri di sorte alcuna, senza le biblioteche de' monasteri». Fleury, ivi, § XXII.
Il Vescovo stesso abitava co' canonici, il che mostra la tradizione de' costumi vescovili de' primi tempi conservata lungamente. Quando le distrazioni secolari disunivano i Vescovi ed i Canonici da questa santità di vita comune, i Concilj animati da Vescovi zelanti riformavano con nuovi regolamenti la vita ecclesiastica nello stesso piede: di modo che si vide sempre vivo lo stesso spirito nella Chiesa, e questa infaticabilmente travagliare per riparare le sue perdite. Si sa che lo stesso S. Carlo ebbe il medesimo desiderio di far vita comune e regolare col suo Clero: sicchè questo è il pensiero costante di tutti i secoli della Chiesa; a questo tende incessante mente il suo spirito, il suo voto.
(3) «Studiavano i dogmi della religione, dice ancora Fleury parlando de' monaci, nella Scrittura e ne’ santi Padri, e la disciplina ne' Canoni. Aveano poca avidità di sapere, e poca invenzione, ma un'alta stima degli antichi autori: si ristringevano a studiarli, a copiarli, a compilarli, ad abbreviarli. Questo è quel che si vede negli scritti di Beda, di Rabano, e degli altri Teologi dell'età media; non sono altro che raccolte di Santi Padri de sei primi secoli; ed era il mezzo più sicuro per mantenere la tradizione». Discorso intorno alla Storia Eccl. dall'anno DC fino al MCX, § XXI.
(4) S. Bernardo, S. Bonaventura e qualche altro, sono ingegni di eccezione: essi scrivono colla dignità de' primi Padri.
(5) Clemente Alessandrino dice: «Noi chiamiamo Padri quelli che ci hanno catechizzati. — Figlio poi è colui che viene erudito, qualora operi a tenore di ciò che gli insegna quegli che lo erudisce; e in questo senso la Scrittura dice: «Figliuolo, non ti dimenticare delle mie prescrizioni». (Prov. III ) Strom. 1.
(6) Quest'è anche la ragione per la quale i dottori di questi secoli nella filosofia seguirono Aristotile; quando quelli de' primi sei secoli avevano più simpatia per Platone.
(7) Il protestantismo, che oggidì ha rinunziato alla rivelazione per tenersi alla pura ragione, cioè alla ragione sistematica che non è ragione; è l'estremo e compiuto sviluppamento di quell'elemento nazionalistico, che fu seminato dagli Scolastici nella sacra dottrina. Non si creda che presso i Cattolici, cioè pressa quella parte di mondo cristiano che non ebbe il coraggio di seguire lo sviluppo di questo elemento fino al suo ultimo termine, che è l'uscir della Chiesa e della rivelazione stessa, sia stato ozioso quest'elemento di razionale dominazione, nè abbia recato veruno effetto atto ad essere da noi qui mostrato e riconosciuto per legittima prole di tal padre. È facile l'accorgersi che, in quanto alla dottrina dogmatica, effetto di lui furono le disputazioni che divisero le scuole cattoliche, massime intorno la grazia, e che divennero irreconciabili: in quanto al diritto civile e canonico, furono suo effetto le cavillazioni tante che in parte tolsero il vigore alle leggi più salutari; e in quanto alla morale, l'effetto non fu dissimile, perocchè vi cagionò tutto ciò che fu detto e fatto sulla materia del probabilismo, e ciò che fu detto e fatto in questa materia ebbe grande influenza sul decadimento de' costumi del popolo cristiano, decadimento avvenuto non meno per l'influire di ciò che si chiamò lassismo, che per l'influire di ciò che si chiamò rigorismo. Sono troppo note le battaglie teologiche sì dannose all'unione del Clero, e alla sua santificazione; e non aggiungerò su ciò altre parole. De' cavilli degli uomini di legge del secolo XIII il Fleury dice così: «Veggansi i canoni del gran Concilio di Laterano, e più ancora quelli del primo Concilio di Lione, e si conoscerà sino a quale estremo segno era allora salita la sottigliezza de' litiganti per deludere tutte le leggi e farle servire di pretesto alla ingiustizia, imperciocchè questo è quel che io chiamo spirito di cavillazione: ora gli Avvocati ed i pratici, ne' quali dominava questo spirito, erano i Cherici, que' soli che studiassero allora la giurisprudenza civile o canonica, come la medicina e le altre scienze. — Se la vanità sola e l'ambizione di distinguersi somministrava a' Filosofi ed a' Teologi tante cattive sottigliezze per disputare continuamente e non arrendersi mai; che non avrà fatto l'avidità del guadagno per eccitarvi più vigorosamente gli avvocati? Or che poteva mai essere un sì fatto Clero? Lo spirito del Vangelo non è altro che sincerità, candore, carità, disinteresse. Cotesti Cherici così sprovveduti di tali virtù erano molto poco atti ad insegnarle altrui». Discorso V sopra la Storia Eccl., § XVII.
Circa l'effetto ch'ebbe in morale quell'aver dato al regionamento umano il predominio nelle scuole, il Fleury dice queste parole, nelle quali non sono al tutto d'accordo: «L'effetto peggiore del metodo topico (cioè di quel metodo che insegna a cercare in ogni argomento il pro ed il contra, come facevano gli scolastici ), e della disperazione di poter trovare la verità, è quello di aver introdotte e autorizzate in morale le opinioni probabili». Il male non fu nell'aver introdotto le opinioni probabili, ma nell'averne abusato. «In fatti questa parte di Filosofia non fu trattata in miglior modo nelle nostre scuole che nelle altre. I nostri dottori accostumati a contestar tutto ed a rilevare tutte le verisimiglianze, ne ritrovaroņo ancora in materia di costumi; e l'interesse di lusingare le proprie passioni o le altrui, gl'indusse spesso ad uscire dal diritto cammino. Questa è l'origine, del rifasciamento tanto manifesto ne' casisti più moderni, la cui origine però è da me ritrovata cominciare fin dal XIII secolo. Si contentavano questi dottori di un certo calcolo di proporzioni, il cui risultato non si accordava sempre col buon senso o col Vangelo; ma conciliavano tutto con la sottigliezza delle loro distinzioni ». Discorso v sulla Storia Eccl., § IX.
38.
I compendii e le somme scolastiche toccarono il sommo di loro perfezione nel secolo XIII, in quella di S. Tommaso d'Aquino: e i maestri che succedettero fino a noi nelle scuole cristiane, sebbene acquistarono immensamente dal rifiorimento degli studj per ciò che risguarda la storia, la critica, le lingue, e l'eleganza dello stile; nel fondo però della dottrina non fecero che addietrarsi agli Scolastici, ripeterli, chiosarli, abbreviarli, quasi direi come i maestri che succedettero a' sei primi secoli della Chiesa aveano fatto de' Padri. Non sembri ingiurioso questo confronto, di cui ogni uomo che non s'arresti alla superficie delle cose sentirà il vero. Le lettere rifiorite nel XV, e XVI secolo trassero a sè l'attenzione degli uomini, i quali, abbandonata la speculazione pel diletto della immaginazione e del sentimento, lasciaron mancare il nerbo della filosofia cristiana, che perì, come prima era perita la grandezza e la pienezza della esposizione. Non si vide più l'importanza delle grandi, delle intrinseche ragioni della dottrina della fede, ritenute tuttavia da' migliori degli Scolastici; come da questi si era perduto di vista l'importanza della grandiosa e piena maniera di esporla usata da' primi Padri. Gli Scolastici avevano abbreviata la cristiana sapienza collo spogliarlo di tutto ciò che apparteneva al sentimento, e che le rendeva efficace; i discepoli (e i discepoli, di nuovo sel dica, non sono più che i maestri) continuarono ad abbreviarla, troncando da lei tutto ciò che vi avea di più profondo, di più intimo, di più sostanziale, ed evitando di parlare de' suoi grandi principj col pretesto di facilitarne lo studio, ma veracemente perché non gl'intendevano punto essi stessi. Così la ridussero miseramente a formole materiali, a conseguenze isolate, a notizie pratiche, delle quali la gerarchia non può far senza, se vuol agli occhi de' popoli condurre le cose della Religione in quel modo esteriore che furon condotte in addietro. Questa pertanto è la quarta ed ultima epoca nella storia de' libri usati nelle scuole cristiane: l'epoca de' teologi succeduti agli scolastici. E per questi gradi, della Scrittura, de' Padri, degli scolastici e de' teologi, siamo pervenuti finalmente ad avere questi testi così maravigliosi, che ne' nostri seminarj noi adoperiamo; i quali pur c'infondono tanta presunzione di sapere, tanto disprezzo pe' nostri maggiori: questi libri che ne' secoli avvenire, ne' quali stanno le speranze della Chiesa che non può perire giammai, saranno, a mio credere, giudicati tutto ciò che di più meschino e di più svenevole fu scritto ne' diciotto secoli che conta la Chiesa: libri, per riassumere tutto in una parola, senza spirito, senza principj, senza eloquenza e senza metodo (1); sebbene in una acconciata e regolare distribuzione di materie, in che fanno essi consistere il metodo, mostrino gli autori loro di avere esaurita tutta la capacità de' loro intelletti: e libri finalmente che non essendo fatti nè pel sentimento, nè per l'ingegno, nè per l'immaginazione, non sono a vero dire nè vescovili, nè sacerdotali, e a tutta ragione li diremo laicali: e che non esigono altri maestri nè altri espositori se non tali, che abbiano occhi onde leggere, nè altri discepoli se non tali, che abbiano gli orecchi ond'udire.
39.
Ma se piccoli libri e piccoli maestri vanno del pari; di questi due elementi potrà egli formarsene una grande scuola, potrà aversene un metodo dignitoso d'insegnamento? No; e la difettuosità di metodo è la quarta ed ultima cagione di questa piaga della Chiesa di cui parliamo, cioè dell'insufficiente educazione del Clero ne' tempi nostri.
Dicemmo, i costumi del Clero esser periti nella Chiesa in quel tempo che si divise nelle scuole la formazione del cuore da quella della mente (1). Più tardi si pensò a rimediare alla trabocchevole scostumatezza, naturale effetto di quella divisione; ed ora ne' ben regolati nostri Seminarj s'è introdotta la bontà, o almeno la regolarità de' costumi; ma non si prese però di vista la radice del male, non si pensò a riparare a quella separazione funesta della teoria dalla pratica, non si tolse a formar de' maestri altrettanti padri; e «ad esser padre, dicea il Crisostomo, non basta aver generato, ma conviene aver altresì educato bellamente il giovanetto (2)».
Tutto ciò che si fece, si fu l'aver posto degli ajuti e de' sostegni per così dire di fianco, a sostenere i cadenti costumi; ma ciò sicuramente non basta alla Chiesa: è necessario che i buoni costumi degli ecclesiastici trovino la loro radice e succhino il loro alimento dalla stessa solidità e pienezza della dottrina di Cristo; poichè non s'intende già di formare semplicemente degli uomini onesti, ma de' cristiani, e de' sacerdoti illuminati e santificati in Cristo. Era questo il primo principio e tutto il fondamento del metodo che usavasi ne' primi sccoli: scienza e santità unite strettissimamente, e l'una nascente dall'altra. Anzi propriamente in un verissimo senso può dirsi che la scienza nasceva dalla santità; perciocchè si voleva quella per solo l'amore che si portava a questa; si voleva quella scienza, perchè ella era tale che conteneva la santità nelle sue stesse viscere, nè altra se ne voleva; e così tutto era unificato: e in questa unità consiste propriamente la genuina indole della dottrina destinata a salvare il mondo: ella non è pura dottrina ideale, ma è verità pratica e reale; e perciò, rimossa la santità da essa, crederemo noi che si rimanga quella sapienza che ha insegnato Cristo? Ne ingannerebbe il crederlo: noi ci reputeremmo di essere savj, e saremmo stolti; noi prenderemmo per la dottrina di Cristo una vana e morta effigie di lei, vuota di vigore e di ogni vita.
(2) Ου' τό σπεῖραι ποιεῖ πατέρα μόνον, ἀλλὰ καὶ το παιδευσαι καλῶς 000 Hom. XII.
40.
Ecco come un santo desiderio della verità pratica guidava ne' suoi studj S. Papias, celebre discepolo degli Apostoli: «Papias, dice Eusebio nella sua Storia, si piaceva della compagnia non di quelli che parlassero molto, ma sì di quelli che gl'insegnassero la verità. Non cercava quelli che pubblicavano massime nuove inventate dallo spirito umano, ma sì quelli che gli riferivano le regole che il Signore ci ha lasciate a sostenimento di nostra fede, e intorno alle quali perciò la Verità stessa ci ha ammaestrati. Quando si abbatteva in alcuno che era stato discepolo de' vecchj egli raccoglieva con cura tutti i suoi discorsi. Domandava, per esempio, ciò che aveva detto S. Andrea, S. Pietro, S. Giovanni, S. Filippo, S. Tommaso, S. Giacopo, S. Matteo, o qualche altro de' discepoli di Gesù Cristo, come Aristone, o Giovanni il a vecchio. Poichè egli trovava che le istruzioni che traeva dai libri, gli erano di meno profitto di quelle che riceveva di viva voce da quelli co' quali s'interteneva. Egli notava ne' suoi scritti di essere stato discepolo di Aristone e di Giovanni il vecchio. Li citava sovente, e riferiva molte cose ch'egli diceva averne imparate (1)».
In questa descrizione che fa Eusebio, noi possiamo vedere qual puro amore di verità effettiva (che è il proprio carattere della dottrina di Cristo), senza vana curiosità, conduceva quegli uomini santi de' primi tempi a desiderare non tanto di sapere, quanto di penetrare la verità coll'animo, di assaporarla col gusto interiore, di nutrirsene come di un pane sostanzioso e vitale: quindi è che si faceva pendere l'insegnamento non tanto da' libri, quanto dalla viva voce, alla qual sola s'affidavano i più sublimi misteri (2): e questa desideravano più, perchè l'esperimentavano i discepoli in se stessi più salutare. Il che forma uno de' pregi del metodo che usavano i grandi allora a formare i grandi: cioè che l'ammaestramento non finiva in una breve lezione giornaliera, ma consisteva in una continua conversazione che avevano i discepoli co' maestri, i giovani ecclesiastici co' grandi Vescovi; vantaggio che peri naturalmente tostochè l'istruzione fu commessa esclusivamente al Clero inferiore, cioè a de' puri istruttori anzichè a de'pastori (3).
(2) Acciocchè le verità più sublimi non fossero udite dagl'Indegni, v’avea la scienza dell'arcano; non si confidavano quelle atte dottrine che a voce, e solo a que' discepoli che erano stati lungo tempo provati, e che se n'erano resi degni col costante proposito di conseguire la santità della vita cristiana. Tutti gli antichi scrittori parlano di questa prudenza e riverenza che s'aveva alle verità rivelate, e basterà qui citare Clemente d'Alessandria, il qual ne parla nel L. 1 degil Stromi, e in tanti altri luoghi delle sue opere.
(3) Anche ne' rimedj posti all'educazione del Clero abbandonata, rimase questo inconveniente perchè i rimedj non andavano alla radice del male. Uno de' rimedj di cui parlo si fu l'istituzione delle Università: ma queste non facevano che allontanare sempre più i cherici da' loro Vescovi come pure fanno al presente. «Un altro inconveniente delle Università, dice Fleury, è questo, che i maestri e i discepoll, i quali non erano in altro occupati che ne' loro studj, erano tutti cherici, e molti benefiziati, ma fuori delle loro Chiese non avevano funzioni od esercizio spettante agli ordini. Così non imparavano essi tutto quello che dipende dalla pratica, il modo di ammaestrare, l'amministrazione de' Sacramenti, il governo dell'anime, come avrebbero potuto apprenderlo ne' loro paesi, vedendo i Vescovi e i Sacerdoti ad operare, e servendo sotto i loro ordini. I dottori delle Università erano solamente dottori, unicamente applicati alla teoria: onde avevano poi tant'agio di scrivere, o di trattare così a lungo questioni inutili; e tanti motivi di emulazione e di contrasti, volendo gli uni raffinare più che gli altri. Ne' primi secoli i dottori erano i Vescovi sopraccarichi delle più solide occupazioni». Disc. V sulla Storia Eccl., §. X.
41.
La scienza è comune a tutti, buoni e malvagi: ma la verità viva e pratica del Vangelo non è che de' buoni. Quindi ove non trattisi che d'insegnare la scienza, non è uopo esser solleciti delle qualità morali de' precettori, le quali tanto erano dagli antichi ricercate e richieste, appunto perchè ciò che volevano era una verità santa, e quindi volgevano nell'animo, che santo dovesse esser altresì l'uomo che la insegnasse (1). E medesimamente avverrà che non si faccia una morale scelta de' discepoli, quando trattasi di un ammaestramento scientifico puramente, e non veramente morale. Ove si cerca all'opposto la sapienza morale dell'insegnamento, hassi somma cura di rimuovere dalla scuola tutti coloro, cui non muove un santo desiderio di quella sapienza. E tal cura s'aveva ne' primi tempi, ne' quali era per se stesso più facile lo scegliere saviamente gli alunni del santuario; conciossiachè aveasi a mano quel criterio morale unico e certo a distinguere i vocati da' non vocati; e i giovani stessi che a quella scuola s'accostavano, già sapevano a che fare ci venivano, e qual dottrina trattavasi di appararvi. Oltrachè la pia e pratica verità ha questo di proprio sopra la verità puramente ideale, che impone un rispetto e una venerazion di sè stessa tanto in chi la riceve quanto in chi la comunica, conciossiachè ella è di una natura essenzialmente sacra e divina; sicchè quelli che hanno la sublime incumbenza di doverla altrui comunicare, sogliono sperimentare una cotal ripugnanza e avversione in doverla prodigare agl'indegni, parendo loro di rendersi con ciò rei, in profanandone e in violandone la venerabile santità. Sentono questi altamente il senso di quelle parole con cui Cristo proibisce «di gittare le margarite dinanzi a' porci (2)». Il perchè gli antichi maestri, come li descrive Clemente Alessandrino «provavano col tempo, e giudicavano con attento giudizio, e discernevano dagli altri quello che poteva ascoltare le loro parole, ponendo osservazione a' discorsi di lui, a' costumi, alle consuetudini, alla vita, a' movimenti, all'abito, all'aspetto, e investigando s'egli era o trivio, o pietra, o strada calcata da' viandanti, o terra fertile, o boschiva, o buon campo, e ferace, e dissodato, e che potesse moltiplicar la semente»; ed imitavano Cristo che, come dice lo stesso Clemente «quelle cose che non eran per molti, non le rivelò già a molti, ma a pochi, a' quali sapeva esse ben convenire; perocchè quelli poteano non solo», dice «in sè riceverle», ma «informarne se stessi»; che è quanto dire, compire colla rettitudine della loro vita quella notizia di verità che ricevevano nella mente (3). — Ma così operando, pochi saranno i Sacerdoti. — E bene, Clemente non ha risposta a fare a tale obbiezione, che solo questa: «Pregate dunque il Signore della messe, acciocchè mandi degli operaj nella messe sua (4)».
(2) Matt. VII, 6.
(3) Strom. L. 1.
(4) Strom. L. 1.
42.
Nel tempo però che tutto riceveva unità dall'unità del principio, dall'oggetto unico proposto a studj veramente cristiani; quel vero e salutare principio rendea gli studj stessi completi e universali, tutto abbracciava, e specialmente tutta la Religione, i suoi arcani misteri, i suoi profondi principj, le sue grandi massime, il suo intero sistema in una parola: non ci avevano delle esclusioni arbitrarie, delle eccezioni ingiuste per certa parte di dottrina, e delle predilezioni per cert'altra: la parola di Cristo amavasi e cercavasi sola, e perciò volevasi penetrare tutto ciò che in quella parola indagar si potesse: e perchè in quella parola si cercava la vita nascosta, amministravasi mescolata colle preghiere, colle sante lagrime, colla liturgia, onde derivavasi la grazia che in un modo soprannaturale pasceva di luce divina le menti insaziabili di giustizia (1).
43.
Ah chi restituirà alla Chiesa un tal metodo, che è il solo degno di lei? Chi renderà alle scuole de' Sacerdoti i suoi 'grandi libri, e i suoi grandi precettori? Chi sanerà, in una parola, la piaga sì profonda della insufficiente educazione del Clero, che indebolisce tutto giorno, e fa mandar lamentevoli gemiti alla bella Sposa di Cristo? Non altri che l'Episcopato: a lui fu commesso il reggerla, a lui dato il potere miracoloso di sanarla inferma: ma a lui unito insieme, e non fra sè spezzato e diviso. L'Episcopato tutto in corpo si richiede alla grand'opera, congiunto in un solo volere, con una sola operazione. Or questa unione è appunto ciò che manca ai Pastori della santa Chiesa in questi tempi di fraude; ed ella è una terza piaga della Chiesa, non meno anzi più crudele dell'altre due fin qui da noi dimostrate.
III: Della piaga del costato della Santa Chiesa che è la disunione de' Vescovi.
44.
Il divino Autore della Chiesa, prima di lasciare il mondo pregò il Padre celeste che facesse sì che i suoi Apostoli formassero insieme una unità perfetta, come egli e il Padre insieme formavano la più perfetta delle unità, avendo una stessa natura. Questa unità sublimissima, di che parlava l'Uomo-Dio in quella orazione maravigliosa che fece dopo la cena, poche ore prima della sua passione, era principalmente una unità interiore, una unità di fede, di speranza, di amore. Ma a questa interiore unità, che non può mancar mai intieramente nella Chiesa, dovea rispondere l'esteriore, come l'effetto alla cagione, e l'espressione alla cosa che viene espressa, e la fabbrica al tipo o disegno su cui viene fabbricata; «Un corpo ed uno spirito», dice l'Apostolo (1); il che comprende tutto; perchè nel corpo viene significata la unità nell'ordine delle cose esterne e visibili, e nello spirito la unità nell'ordine delle cose che si tolgono a' nostri sguardi corporali; «Un Signore, soggiunge, una fede, un battesimo: un Dio e Padre di tutti, che è sopra tutto, e per tutte le cose, c in tutti noi (2)». Ecco di nuovo l'unità della divina natura, posta a fondamento ammirabile dell'unità che debbono formare gli uomini, que' dispersi che Cristo congregò sotto le sue ali, siccome una gallina congrega i suoi pulcini, e ne formò una sola Chiesa; ed ecco il fonte ad un tempo di quella unità dell'Episcopato nella Chiesa di Cristo, che venia sì altamente sentita da' primi Vescovi, e che S. Cipriano esprimeva con sì eloquenti parole nel libro che intitolò appunto «Dell'unità della Chiesa».
(2) Eph. IV, 5, 6.
45.
Gli Apostoli ebbero e mantennero questa doppia unità in grado eminente; perocchè in quanto all'interiore, una stessa dottrina e una stessa grazia tutti, per così dire, in comunione possedevano; e in quanto all'esteriore, un solo fra essi era il primo (1) e «l'origine di quell'unico Episcopato», come dice il gran Vescovo e Martire di Cartagine «che in solido tutti possedevano (2)». Ad un solo era stato dato in particolare ciò stesso che era stato dato a tutti in comune; e sopra un solo, come sopra un solo e indiviso scoglio, era edificata quella Chiesa di cui tutti insieme con esso lui e sopra lui collocati erano altresì in egual modo il fondamento.
(2) Episcopatus unus est, cujus a singulis pars in solidam tenetur. Lib. de unit. Eccl.
46.
La consapevolezza di questa perfetta unità nella gerarchia che è l'espressione bellissima, e quasi il vago riflesso della unità interiore dello spirito, ingrandiva il petto de' primi successori degli Apostoli, che si sentivano, tanti quanti erano sparsi per le nazioni, non formare tuttavia che un solo quasi direi autorevolissimo personaggio, e realizzare tutti insieme quell'ideale divino di un potere benefico, che a similitudine di Dio si trova tutto in ogni luogo; nè ignoravano, che questa stupenda unità era il testamento che Cristo avea lasciato a' suoi inviati pria di morire, cioè prima di spargere un sangue che suggellava quel suo nuovo ed eterno testamento. E in vero, l'unità de' suoi, simboleggiata nell'Eucaristico Pane, simboleggiata anche in quella tunica inconsutile che copriva le sue carni divine, era siccome l'ultimo segno tutti i voti di Cristo, e dovea essere il frutto de' suoi infiniti patimenti, avendo egli detto al Padre, che per ciò appunto desiderava «che fossero salvati nel suo nome, acciocchè potessero divenire una cosa sola (1)».
47.
Ora dominando nelle menti degli antichi Vescovi una sì grande idea della unità, e più ancora portandola essi nel cuore; niente trascuravano di tutto ciò che potesse avvincolarli insieme; e non che mantenere tutti la credenza perfettamente uguale, e l'amore pel corpo de' Pastori; ma altresì, ciò che sommamente importa al retto governo della Chiesa di Dio, niente amavano tanto, niente avevano, come si suol dire di più antico, quanto operare tutti con uniformità. Chi considera la vastità del governo della santa Chiesa sparsa per tutte le nazioni della terra, avrà certamente a stupire in trovare introdotto ovecchessia tanta consensione di dottrine, di discipline, e fino di consuetudini; e quanto poche e non punto essenziali sieno le differenze che vi si riscontrano.
48.
Ma ciò onde nasceva, onde si continuava?
1.º Dal conoscersi i Vescovi personalmente: la qual conoscenza cominciava fra essi anche prima di esser fatti Vescovi, ed era una natural conseguenza della dignitosa educazione, alla quale si formavano gli uomini grandi, fra' quali poi erano sempre eletti i Vescovi della Chiesa. Conciossiachè cotesti o erano stati condiscepoli nelle scuole di altri grandi Vescovi (1), o aveano cercato co' viaggi, fatti a posta, di conoscersi scambievolmente. Chè non si risparmiavano allora viaggi lunghissimi e oltremodo disagiati, per godere pur della vista di un uomo grande e celebre in santità e in dottrina, ed avere la ventura inestimabile di udire la sua voce, e di approfittare della sua conversazione; appunto perchè v'era quella persuasione, che i libri non bastano a comunicar la sapienza, nel senso in cui ella prendevasi questa parola, cioè non una sterile cognizione, ma una intelligeuza intima, un sentimento profondo, una convinzione operativa; e che all'opposto la presenza, la voce, il gesto, e fino le azioni più indifferenti (2) de' grandi hanno virtù di trasfondere in altrui e comunicare essa sapienza, e accender ne' giovanetti scintille di genio, il qual si muore, o rimane sepolto ed inerte, ove non venga quasi direbbesi percosso dal genio altrui. S. Girolamo dalla Dalmazia venne a Roma a ricevervi la prima educazione; indi viaggiò nelle Gallie, dove visitò tutti i personaggi che ivi fiorivano; passò in Aquileja a udire il Vescovo S. Valeriano, sotto il quale è memoria che si trovavano assembrati più uomini celeberrimi; poi se ne andò in Oriente ad Apollinare di Antiochia, si fece alunno di Gregorio Nazianzeno in Costantinopoli, e co' capelli canuti non isdegnò di apprendere in Alessandria dalla bocca del cieco Didimo quel sapere di verità, di cui a quel tempo non si finiva di andare in cerca se non per morte. Che più? anco per ben conoscere una sola questione di ecclesiastica dottrina, non si viaggiava mezzo mondo? Valga in esempio il prete Orosio, che dalla Spagna essendo andato in Africa ad imparare da S. Agostino il modo di confutare le eresie che allora infestavano la Chiesa; e questi il rimise pel medesimo fine a S. Girolamo, che andò trovare nella Palestina. Così apprendevano teologia i maggiori Sacerdoti di que' tempi; così i grandi uomini di quel Clero mettevano diligenza in conoscersi fra di loro!
(2) Questo si avvera tanto maggiormente nell'ordine soprannaturale. I Santi comunicano con ogni lor cosa e quasl riversano lo spirito della santità in quelli che li circondano; e questo espresse Cristo con somma efficacia in quelle sue parole: «Chi crede in me, come disse la Scrittura, usciranno del suo ventre fiumi di acqua viva». Giov. VII, 38.
49.
2.° Dalla corrispondenza epistolare che avevano insieme continuamente i Vescovi anche più lontani; e ciò sebbene mancassero i mezzi tanti che noi abbiamo oggidì di comunicazione. Per esempio fa maraviglia il vedere come un S. Vigilio Vescovo di Trento mandi in dono, accompagnata con lettera di amicizia, una parte delle reliquie de' Martiri dell'Anaunia, fino a S. Giovan Grisostomo Vescovo di Costantinopoli, e un'altra parte a Milano a S. Simpliciano. Ed oltre queste lettere di privata amicizia di Vescovo a Vescovo; si scrivevano ancora le Chiese l'una all'altra, massime le principali alle loro soggette; e in questa pia corrispondenza prendeva parte il presbiterio ed il popolo stesso; e quelle venerabili lettere venivano poi con riverenza lette nelle pubbliche adunanze i giorni festivi. Tale era l'esempio dato dagli Apostoli a' loro successori: tali sono le lettere di S. Pietro, di S. Paolo, di S. Giovanni, di S. Giacopo e di S. Giuda, che ancor si conservano inserite nel corpo delle Scritture canoniche; tali le lettere de' sommi Pontefici S. Clemente, e S. Sotero alla Chiesa di Corinto; come pure quelle che scrissero S. Ignazio, e S. Dionigio Vescovo di Corinto a varie Chiese, e specialmente alla Romana (1), e tante altre.
50.
3.º Dalle visite, che si facevano i Vescovi gli uni gli altri, o mossi dalla scambievole carità, o dallo zelo per gli affari della Chiesa; e non solo dallo zelo per la Chiesa particolare a loro affidata, ma assai più per la universale, consapevoli, si com'erano, di esser tutti Vescovi della Chiesa cattolica (1), e che una diocesi non può essere segregata dall'intero corpo de' fedeli più di quello che il possa essere un membro dal corpo. Perciocchè come qualunque membro del corpo umano ha bisogno di venire inaffiato da quella massa di sangue che tutto il corpo trascorre, e penetra per gli meati delle vene grosse e mezzane e capillari, fino alle ultime sue estremità, e da per tutto continuamente si cangia e si tramuta, per così dire, di vaso in vaso, sicchè non si può assegnare una porzione di quel sangue, che sia propria di un braccio, e un'altra che sia propria di una gamba, ma tutto è a tutto il corpo comune: e lo stesso si può dire di varj altri umori che girano secondo loro proprie leggi per l'intero corpo, siccome pure dell'azione simultanea di tutte le parti concordi a produrre un solo effetto, cioè la vita, di cui ciascun brano del corpo partecipa e vive, non perchè abbia una vita sua particolare, ma perchè la vita comune è appunto vita sua; così medesimamente è nella Chiesa cattolica, nella quale ciascuna Diocesi particolare conviene che viva della vita della Chiesa universale, mantenendo con questa una continua vitale comunicazione, e ricevendone la salutare influenza; e dove da questa si separi alcun poco, ella incontanente si fa come morta; o pure, ove si metta un impedimento al comunicare col tutto della Chiesa, ella non ha più che una vita assai languida e spossata, in ragione di quell'impedimento che la stringe e riduce svigorita; siccome un braccio legato strettamente da funicelle, a cui vien meno la sensitività e il movimento; se non anco alla guisa di un braccio, che tocco da accidente diventa paralitico, o intormentito, o agghiadato, ove la circolazione è oggimai lenta, e le funzioni sono arrestate, o sospese. Ma queste idee sono straniere alla massima parte del nostro Clero; e proccdendo così, noi avremo necessariamente di que' Vescovi, il cui vedere appena che giunga ai confini della loro diocesi, e i quali si persuaderanno di avere soddisfatto assai acconciamente, all'incarico episcopale, allorquando non sieno mancati alle comparse di uso nella loro Chiesa cattedrale, o in Seminario; quando il servizio esterno della diocesi sia in qualche modo coperto e non promuova reclamo da' laici; e finalmente quando abbiano eseguito materialmente le funzioni tutte del Pontificale del Cerimoniale de' Vescovi (2).
(2) Dell'uffizio che hanno i Vescovi di aver cura della Chiesa universale così dice S. Cipriano: Copiosum corpus est Sacerdotum concordiæ mutuæ glutiaæ atque unitatis vinculo copulatum, ut si quis ex collegio nostro hæresim facere, et gregem Christi lacerare et vastare tentaverit, subveniant cæteri. Nam etsi Pastores multi sumus, UNUM tamen GREGEM pascimus, et oves universas, quas Christus sanguine suo et passione quæsivit, colligere et fovere debemus. Ep. 68. al. 67. ad Steph.
51.
4.° Dalle frequenti adunanze e Concilj specialmente provinciali che si tenevano. L'unità della Chiesa si volea che fosse unità di voleri, unità di persuasioni; e ad ottener questa, niente vale il comandare di un solo con autorità, la quale, tutta sola, trae seco pur sempre qualche cosa di invidioso e di ostile, nè, per l'ordinario, rende i soggetti più illuminati, ma solo più aggravati. Di che l'Apostolo stesso diceva: «Tutto a me lice, ma non tutto è spediente (1)».
E quindi proveniva quel volersi continuamente anche il voto del popolo, che si può dire che fosse a que' tempi il consigliere fedele de' governatori della Chiesa (2); e quel render conto che faceva il Vescovo al popolo stesso di tutto ciò che nel governo della Diocesi egli operava (3); e quel cedere e condiscendere ai voleri popolari in tutto ciò che si poteva, il che è tanto dolce e affabile cosa, e sommamente conveniente al governo episcopale, governo sublime e che può tutto, ma non tuttavia come quello de' re della terra; perchè può tutto, solo pel bene, e niente pel male; e per la stessa sua essenza è decorato di umiltà, di modestia e di carità immensa; e in ogni cosa è al sommo ragionevole, e perciò stesso forte di sua dolcezza (4). Quindi ancora traeva origine quella congiunzione de' Vescovi co' loro presbiterj, di cui richiedevano il parere in ogni affare spettante il governo della Chiesa, acciocchè quelli che erano in parte della esecuzione, fossero anche in parte delle disposizioni che si venivano prendendo, e queste riuscissero consonanti al voto comune, e fossero conosciute nel loro spirito e nelle loro ragioni da quelli che le dovevano ridurre ad effetto (5). Quindi ancora que' Concilj, in cui tutti i Vescovi comprovinciali, come altrettanti fratelli, trattavano insieme due volte l'anno (6) degli affari comuni; si consultavano su' casi difficili che incontravano ne' loro governi particolari, e accordavano insieme tutto ciò che era mestieri per togliere i disordini; decidevano le cause, davano i successori a' Vescovi che morivano: i quali successori stabiliti da' Vescovi comprovinciali erano a questi non solo noti, ma aggraditi, e tall, che ottimamente contribuivano a conservare quella perfetta armonia che accordava insieme il corpo episcopale: quindi finalmente i Concilj maggiori di più provincie, i nazionali, e gli ecumenici.
(2) «Tutto si facea nella Chiesa, dice il Fleury, per consiglio, non volendo che vi regnasse altro che la ragione, la regola e la volontà di Dio.» — «Le assemblee hanno questo vantaggio, che per ordinario vi ha sempre alcuno che mostra qual sia il partito migliore, e riconduce gli altri a ragione. Producono il rispeno vicendevole, e si ha vergogna di palesarsi ingiusti in pubblico. Quelli che sono più deboli in virtù, vengono sostenuti dagli altri. Non è agevol cosa il corrompere una intera assemblea: ma è facile il guadagnare un solo uomo, o colui che lo governa; e se si determina da sè solo, seguita l'inclinazione delle proprie passioni che non hanno contrapposto. — In ciascuna città il Vescovo non faeea niente d'importante senza il consiglio de' Sacerdoti, de' diaconi, e de' principali del suo Clero. Spesso ancora si consigliava con tutto il popolo, quando avea esso interesse nell'affare, come nelle ordinazioni». Disc. 1 sulla Stor. Eccl. § V.
(3) S. Cipriano rendea conto al suo popolo di tutto ciò che faceva, e non potendo farlo di presenza, nel tempo della persecuzione, il faceva tuttavia per lettere, alcune delle quali ancora si conservano (Ved. Ep. 38 Pam. 33). Due secoli dopo, S. Agostino vedesi fare il medesimo col suo popolo. Ne' suoi sermoni lo rende informato di tutte le bisogne della Chiesa, e gli dà minutissimo conto della sua condotta. Sono degni d'essere osservati fra gli altri i Sermoni 355, 356.
(4) «Si aveva tal riguardo all'assenso del popolo, dice il Fleury, ne' sei primi secoli deila Chiesa, che se egli ricusava un Vescovo anche dopo consecrato, non veniva altrimenti costretto, ed un altro se ne creava che gli fosse accetto» (Discorso 1 sulla Stor. Eccl. IV). S. Agostino ne dice la ragione con queste parole dirette al suo popolo: «Noi siamo cristiani per noi medesimi, e Vescovi per voi». (Serm. 339).
(5) S. Cipriano, in una lettera che scrive al suo Clero dal nascondiglio ove si stava in tempo di persecuzione, rende per ragione del non aver dato risposta a certa lettera che alcuni suoi sacerdoti gli aveano inviata, l'esser egli solo; «perché, dice, nel principio a del mio vescovato deliberal di non far cosa di mio capo senza l'avviso vostro, e l'assenso del popolo» (Ep. 14). Questo egli faceva secondo l'esempio dato costantemente dagli Apostoli. Si consideri il procedere Apostolico nell'elezione de' diaconi. Avevano certamente gli Apostoli la potestà di eleggere cui volevano. E tuttavia con quanto dl dolcezza e di prudenza non propongono la cosa a' fedeli, perchè essi stessi i fedeli nominino quelli che stimassero i più degni e idonei a quell' uffizio? «Prendete in vista, dicono essi, o frateili, degli uomini che godano di un buon testimonlo, fino al numero di sette, acciocchè noi li possiamo costituire sopra questo ministerio» (Act. VI). E «piacque il discorso, seguita il sacro Storico, a tutta la moltitudine, che elesse i primi sette diaconi della Chiesa».
(6) Il V dei venti Canoni disciplinari del gran Concllio di Nicea ordina che in ogni provincia il Concilio si tenga due volte l'anno.
52.
5.° Dall'autorità del Metropolitano che presiedeva a tutti i Vescovi di una provincia, e delle sedi maggiori che più provincie e più metropolitani avevano sotto di sè; la quale ben ordinata distribuzione del reggimento ecclesiastico tutto mirabilmente univa ed incatenava per così dire tra sè il corpo della Chiesa; non essendo per avventura una gerarchia vana, e di solo onore.
53.
6.º E finalmente sopra tutto dall'autorità del sommo Pontefice, pietra precipua e sempre e sola immobile della gran mole dell'edificio episcopale, e perciò pietra di verace fondamento, che dà a tutta la Chiesa militante identità, e perennità. A lui ricorrevano in ogni loro grave bisogno tutti i Vescovi e tutte le Chiese del mondo siccome al padre, al giudice, al maestro, al centro, al fonte comune; da lui ricevevano consolazione i pastori perseguitati, e limosine gl'impoveriti e spogliati, come pure i fedeli di ogni nazione; da lui lume, e direzione, e difesa, e sicuro e tranquillo stato tutto l'intero orbe cattolico.
54.
Tali erano i sei anelli d'oro costituenti i saldissimi vincoli che stringevano insieme il corpo episcopale ne' più bei tempi della Chiesa: e veramente d'oro! perchè non d'altra materia formati che di santità, di carità, di adesione alla parola di Cristo e agli esempj apostolici, di zelo per quella Chiesa che col sangue di Cristo era fondata ed alle mani dei Vescovi commessa, e di timore e tremore che avean sempre presente nell'animo del conto inesorabile che ne dovea domandar loro un giorno lo stesso Signore ed invisibile Capo e Pastore Gesù Cristo.
Abbiamo veduto che le invasioni de' barbari, le quali rovesciarono il dominio romano, fecero cominciare alla Chiesa un di que' nuovi periodi che si possono chiamare di movimento, ne' quali ella si leva quasi direi dalla sua stazione, e comincia una marcia novella; periodi in cui ella sviluppa di sè una attività nuova, prima nascosta nel suo seno per mancanza d'occasione di manifestarsi, e allora esercita sull'umanità una nuova azione, e si produce una nuova serie di benefici effctti. Ed ora il periodo di cui parliamo ha per suo carattere «l'ingresso de' Vescovi ne' governi politici»: e il fine della Providenza in avvenimento così rilevante, dicemmo essere stato manifestamente di fare che la Religione del Cristo penetrasse l'intimo della società, e dominandola la santificasse; e quel fine fu conseguito, giacchè l'ordine della Providenza è immancabile e certo; ma fu conseguito a prezzo di gravi mali, giacchè le cose umane, colle quali opera la Providenza, sono tutte necessariamente limitate e imperfette. Ora uno di questi mali, oltre quelli che abbiamo enumerati, fu la disunione dell'Episcopato, terribile lanciata che andò a squarciare il petto e a trapassare il cuore stesso della tenera sposa di Gesù Cristo!
55.
Noi dobbiamo vedere per quali gradi avvenisse uno scempio così crudele. Ma prima mi sia permesso di fare una osservazione sulle leggi, secondo le quali vengono da Dio attemperate le vicende della santa Chiesa.
La Chiesa ha in sè del divino e dell'umano. Divino è il suo eterno disegno; divino il principal mezzo onde quel disegno viene eseguito, cioè l'assistenza del Redentore; divina finalmente la promessa che quel mezzo non mancherà mai, che non mancherà mai alla santa Chiesa e lume a conoscere la verità della fede, e grazia a praticarne la santità, e una suprema Providenza che tutto dispone in sulla terra in ordine a lei. Ma dopo ciò, oltre a quel mezzo principale; umani sono altri mezzi che entrano ad eseguire il disegno dell'Eterno: perciocchè la Chiesa è una società composta di uomini, e, fino che sono in via, di uomini soggetti alle imperfezioni e miserie della umanità. Indi è che questa società, nella parte in cui ella è umana, ubbidisce nel suo sviluppamento e nei suoi progressi a quelle leggi comuni che presiedono all'andamento di tutte le altre umane società. E tuttavia queste leggi, a cui le umane società sono sommesse nel loro svolgersi, non si possono applicare intieramente alla Chiesa, appunto perchè questa non è una società al tutto umana, ma in parte divina. Quindi, a ragione d'esempio, la legge che «ogni società comincia, progredisce fino a sua perfezione, poscia decade e perisce, non è intieramente applicabile alla Chiesa, a cui assiste una forza che sta fuori della sfera delle umane vicende, una forza infinita, che ripara le sue perdite, che le rifonde la vita quando questa le vien meno; sicchè questa società singolare ed unica disorbita dalla via comune delle altre società, appunto perchè ha qualche cosa in sè di estraneo e di superiore alle pure società umane. La Chiesa in somma è altrettanto ferma quanto la società umana presa in generale, la quale, costituita insieme coll'uomo, non perisce se non coll'ultimo individuo della specie.
Or perciocchè le altre società particolari si formano, si distruggono e si riformano di nuovo; v'ha per esse un periodo di distruzione che succede a un periodo di formazione, e che è susseguito da un altro periodo di formazione novella. Ma questi periodi organizzatori, e questi periodi critici non si possono applicare alla società umana in generale, nè medesima mente alla Chiesa di Gesù Cristo, le quali sempre sussistono, ma bensì solo al modo accidentale dell'una e dell'altra: questo solo si organizza, si distrugge, e si riorganizza. Il momento, in cui comincia ad operare la forza che presiede all'organizzazione, si può chiamare l'epoca di marcia; il momento in cui l'organizzazione è finita si può chiamare l'epoca di stazione. La Chiesa si trova successivamente in queste due epoche; ora vedesi in movimento verso qualche suo nuovo e grande sviluppo; ora vedesi in riposo come quella che è pervenuta al fine del suo viaggio (1).
56.
Un'altra osservazione si dee fare relativamente alla legge che presiede all'andamento delle società, ove applicar si voglia alla Chiesa; ed è che nelle altre società la ricomposizione succede alla distruzione, imperocchè quella tende a rifabbricare in un modo migliore ciò che prima era stato distrutto. Ma nella Chiesa la distruzione e la composizione sono contemporanee, non operandosi quella e questa intorno allo stesso oggetto; come succede nelle altre società; ma distruggendosi un qualche ordine nel tempo stesso che se ne ne compone un altro. Prendiamo l'esempio appunto da quel memorabile tempo in cui il Clero per cagione dell'invasione dei barbari (1) fa spinto ne' governi temporali, epoca di marcia per la Chiesa di Dio, quell'epoca che forma l'oggetto principale della nostra attenzione.
Il progresso della Chiesa in quel tempo, il nuovo ordine che andava organizzandosi, era la santificazione della società civile. Questa società, fino allora pagana, dovea convertirsi al Cristianesimo; cioè dovea conformare tutte le sue leggi, la sua costituzione, e fino i suoi usi, al nuovo codice di grazia e di amore, il Vangelo; ma insieme con questo progresso venia distruggendosi un altro ordine di cose, e vi avea nella Chiesa anche un regresso. Poichè il nuovo avviamento, che portava la Chiesa nella società civile, traeva seco lo sconcio indicato, che l'Episcopato, distratto dalle sue naturali incumbenze, ISTRUZIONE e CULTO (2), venisse gittato nel pelago de' secolareschi negozj. Tale occupazione fu una tentazione pel Clero improvvisa, sconosciuta, di cui si presentiva bensì il pericolo (3), ma a cui perciò non s'era ancora per esperienza appresa l'arte di resistere e di vincerla. Quindi a lungo andare l'umanità cadde nel terribil cimento: la santità del Clero diede un tracollo, e i più begli usi, e i più bei costumi ecclesiastici perirono. Ecco la distruzione che si operava a canto della organizzazione. Tale il dirò ancora, è la limitazione umana! Ella apparisce fino nella Chiesa, la quale nei suoi nuovi progressi e sviluppi soggiace pure ad una alterazione e ad un guasto.
(2) Quando ne' priml tempi si trattò del ministrare alle tavole de' fedeli, gli Apostoli elessero i sette Diaconi, di ciò incaricandoli. Quanto a sè, dissero che non era conveniente che s'occupassero de' negozj temporali; e designarono le due funzionl eminentemente episcopali con queste parole: Nos vero ORATIONI, et MINISTERIO VERBI instantes erimus (Act. VI, 4). L'orazione corrisponde al Culto, e la predicazione all'Istruzione.
(3) Lo provano i timori che manifestano ne' loro scritti S. Gregorio, e gli altri Vescovi, che furono i primi a doversi ingolfare ne' negozj secolareschi. Questi timori e lamenti vanno di mano in mano cessando nella Chiesa, sintomo dell'affezione che pigliava il Clero alle temporali fortune.
57.
Ma che succede a ciò? Dopo che l'organizzazione, che si intendeva conseguire, è compiuta, dopo che il periodo della distruzione è trascorso e tutto ha divorato ciò che era abbandonato dalla Providenza per così dire alla sua voracità; allora sembra per pochi istanti che questa distruzion consumata metta in pericolo la stessa esistenza della Chiesa, e che assorbisca nelle sue ruine, nell'abisso aperto dinnanzi a lei anchie ciò che si era ottenuto e organizzato simultaneamente. In tale frangente la Chiesa è turbata; appena la sua fede la sostiene; e nel suo estremo turbamento volge delle lamentevoli suppliche al divino Autor suo, che dorme nella navicella pericolante; ed allora batte il momento in che egli si desta, e minaccia il vento ed il mare. Allora l'esperienza è fatta; si conoscono a prova gli effetti funesti del principio distruttore, e si pensa finalmente a trovarvi i rimedj. Allora comincia il periodo nuovo in cui si toglie a ristorare i guasti sofferti dal gran vascello nella lunga e difficile sua navigazione: epoca di stazione, perocchè questi risarcimenti non portano la Chiesa innanzi, non le danno qualche nuovo e grande sviluppamento, ma solo la rassettano per così dire in quelle sue parti che hanno troppo sofferto dal faticoso viaggio. Intanto però un gran tratto di cammino è già percorso; e dopo racconciata la nave che non può perire, ella affrontar deve ancora altri mari, altri venti, altre procelle.
58.
Per il che l'ordine della Providenza nel governo della Chiesa è cotale, che la forza organizzatrice sia sempre più valida di quella che presiede alla distruzione: che le due forze operino contemporaneamente, acciocchè tutto avvenga colla massima celerità, e nulla si perda di tempo (1): ma che finito il loro lavoro, succeda nella Chiesa un cotal riposo, nel quale essa non faccia gran viaggio, nè grandi imprese affronti, ma si intenda a riparare a parte e con diligenza i suoi danni; fino che giunga il tempo di salpar nuovamente ad un'altra ardimentosa navigazione. E già da molti secoli, già fino dal sempre memorabile 1076, e con nuovo vigore dal Concilio di Trento, si lavora a ristorare minutamente i danni della disciplina e del costume ecclesiastico. Chi sa che non approssimi oggimai un tempo, in cui il gran naviglio sciolga nuovamente dalle sue rive, e spieghi le vele nell'alto alla scoperta di un qualche nuovo e fors'anco più vasto continente (2)!
(2) Al periodo di distruzione succede dunque un periodo di rifacimento. Questo rifacimento appartiene non al moto, ma allo stato della Chiesa. Contemporaneo poi alla distruzione è un periodo organizzatore: questo appartiene al movimento; è il tempo delle intraprese. A questo succede una stanchezza; tempo di stazione, Nel tempo di moto adunque lavorano due forze estremamente attive; l'una edifica, e l'altra distrugge. Nel tempo di stazione operano pure due forze, ma di poca lena entrambi; l'una raggiusta partitamente i guasti, l'altra guasta ancora, ma più per negligenza che per altro; siccome in fabbrica a cui, dopo essere edificata, manchi una buona manutenzione.
59.
Rimettendoci ora in via, ne' capitoli precedenti noi abbiamo veduto l'attività infaticabile che una forza distruttrice spiegò a danno della Chiesa ne' secoli che succedettero a' sei primi relativamente all'educazione del popolo e del Clero (1); seguitiamo ora a considerare questa forza inimica applicata a disciogliere l'unione dell'Episcopato.
I primi successori degli Apostoli, poveri e privati, trattavano fra di loro con quella semplicità che è infusa nell'anime dal Vangelo, e che è l'espressione del solo cuore. Per essa l'uomo comunica immediatamente se stesso al suo simile, e per essa la conversazione de' servi di Dio è così facile e soave, utile e santa. Tale era la conversazione de' primi Vescovi. Ma ove questi furono circondati e quasi vallati dal potere temporale, il loro accesso divenne difficile; l'ambizione secolaresca inventò deʼ titoli fissi, e determinò un cerimoniale materiale, esigendo dagli uomini, in prezzo del poter trattare co' loro Prelati, de' generosi sacrificj di amor proprio, però bene spesso un tributo di avvilimento, perchè di finzione e di menzogna. Per queste sempre crescenti esigenze si pervenne al punto che i soli preliminari del trattare de' cristiani co' principi della Chiesa si resero implicati di cavillose quistioni sopra formalità, e ben sovente tali, che non ammettevano una possibile, cioè una ragionevole soluzione; e il pensiero del pastore della greggia di Cristo, degno d'essere riserbato a meditare le sublimi verità, a trovare i prudenti eonsigli, si trovò esaurito nello studio e nella tutela di questi nuovi diritti della Chiesa, nascenti dal nuovo Codice di cerimonia. Quindi il carattere si rese diffidente, serio, e ingannatore per prevenzione e per recriminazione. Tutto si avviluppò; e un'assemblea di Vescovi, cosa per sè sì dolce e sì facile, abbisognò d'allora in avanti de' più serj e lunghi pensieri; giacchè prima di solo aderirvi fu necessario aver gran voglia di studiarne le cerimonie, aver gran borsa da farne le spese, aver gran tempo da gittarvi, e aver gran forze da sostenervi le fatiche pesanti di etichetta, che assai meno basta talora ad ammazzare de' vecchi cadenti (2).
(2) «I Vescovi, dice il Fleury, trattavano fra loro a guisa di fratelli, con poche cerimonie e molta carità; e se vedete che sì diano il titolo di santissimi, di veneratissimi, od altri simili, attribuitelo all'uso che s'era introdotto nella decadenza del romano Impero, di dare a ciascuna persona i titoli proporzionati alla sua condizione». Disc. sull'Istor. Eccl. de' sei primi secoli della Chiesa, § V.
60.
Tali difficoltà che allontanano i Vescovi fra loro, circondandoli per così dire di una atmosfera ripulsiva, è il segno sicuro di ambizione entrata furtivamente ne' loro petti. E qual mai cagione di divisione, ed anco di scisma, maggiore dell'ambizione, che è mescolata sempre colle sue due ministre, la cupidigia di ricchezza, e quella di potenza? Un fatto costante nella storia della Chiesa è questo, che «ovunque ad una sede episcopale si congiunse per lungo tempo un assai grande potere temporale, ivi si manifestarono altresì cagioni di discordie». Costantinopoli qui si affaccia tosto al pensiero. Non era un secolo dalla sua fondazione, che i Vescovi della nuova Roma, possenti per la vicinanza dell'Imperatore, ambirono di soverchiare le sedi più antiche e le più illustri della Chiesa, e riuscirono dopo molti contrasti ad ottenere il secondo posto di essa Chiesa (1). Non contenti, rivaleggiarono con Roma, e produssero il fatale scisma greco (2). Ecco evidentemente una delle terribili conseguenze del potere temporale annesso alla sede costantinopolitana, la perdita che fece la Chiesa, dell'oriente! Nell'occidente si offre alla nostra considerazione l'esarcato di Ravenna, stabilitovi nel VI secolo; e tosto rende quegli Arcivescovi indocili e insubordinati a Roma, a tale che solo con misure estreme finalmente si poterono umiliare (3). L'immenso fonte però delle discordie e delle disunioni nella Chiesa occidentale furono i varii Antipapi che vi comparvero; e finalmente nel secolo XIV, il grande scisma d'occidente, che, anche estinto, lasciò i più profondi germi di divisioni, d'invidie, di secrete ostilità fra le nazioni cristiane, germi rinforzati da tutto ciò che è stato fatto in occasione dello scisma dai sempre mai memorabili Concilj di Pisa, di Costanza e di Basilea. Fu quello scisma, che preparò la defezione del settentrione dalla Chiesa, accaduta un secolo dopo; ed estinto materialmente, egli dura tuttavia, e col suo spirito infausto opera infaticabilmente ravvolto sotto il manto di aulicismo, e di gallicanismo; e suoi frutti sono tante mal consigliate imprese ecclesiastiche di un Imperatore e di un Granduca; quella tanto cieca ambizione di quattro Arcivescovi di Germania che lottando colla Sede apostolica, unica, leale protettrice de' loro Stati temporali, perdettero que' lor dominj; e tutto ciò che si desiderò, si disse, e si tentò più recentemente ancora di fare in una Capitale cattolica, per istituirvi un patriarca e produrre nella Chiesa un nuovo scisma.
(2) Fu l'appoggio della potestà politica, che fece ribellare a Roma quest Arcivescovi. Essi giunsero ad ottenere dall'Imperatore un'ordinanza che fu chiamata Tipo, mediante la quale venivano sottratti dalla Chiesa romana! Esso Tipo fu poi consegnato nelle mani del Papa, quando si sottomisero sotto Leone II.
(3) L'anno 677 Ravenna ritornò all'ubbidienza di Papa Donno. Quegli Arcivescovi si ribellarono di nuovo nel 708, e fu un tratto della Providenza che quell'Esarcato ben presto cessasse, per la distruzione che fece di lui Astolfo re de' Longobardi l'anno 752, dopo esser durato soli 180 anni. Così la divina Providenza si servì di questi barbari invasori delle terre della Chiesa, a consolidare il romano dominio col porre in terra la potenza ravennate.
61.
Queste divisioni funestissime, che lacerano il seno della Sposa di Gesù Cristo, non fanno maraviglia, ove si consideri, che se i primi Vescovi che dovettero immergersi ne' negozj temporali, avevano il petto sì santo e l'animo veramente sì episcopale, che nol facevano se non con infinito dolore e con lagrime; non fu però il medesimo di tutti i loro successori. Dall'episcopato povero e faticante nella predicazion del Vangelo e nella cura immediata dell'anime, tutti quelli che erano dominati da uno spirito secolare; da cupidigia di ricchezza, e da avidità di potere profano, stavano assai lontani per se medesimi; conciossiachè non trovavano in esso che travagli e sollecitudini, e ben sovente ancora persecuzioni, stenti, martirj; e tanta era poi la fortezza, tanto lo spirito di sacrificio da esso richiesto, che potevasi ben dire di un tal posto quello che ne disse l'Apostolo: «Chi desidera l'episcopato, desidera un'opera buona (1)». Ma gli uomini santi lo ſuggivano tuttavia per un'altra ragione, cioè perchè vedevano in esso una dignità al tutto divina, quale è agli occhi della fede, a cui Iddio solo potea chiamare e sollevare; e perchè occupati da un umile sentimento di sè medesimi, non si credevano a pezza forniti di quelle virtù che sì grande e sì divino ministerio richiedeva per sua natura. Indi avvenia, che non presentandosi alcuno aspirante alle cattedre vescovili, la Chiesa era libera nella sua scelta, ed ella stessa andava in cerca degli uomini i più santi, con ispassionato giudizio, cioè senza che il giudizio fosse prevenuto e turbato da alcuna propensione degli elettori, e da alcun maneggio de' candidati. E così la elezione cadeva su personaggi, la pietà e sapienza de' quali più risplendeva. Ma mutossi questo buon ordine, tosto che il Vescovato non fu più un puro potere spirituale, e si aggiunse a lui l'amministrazione di abbondanti ricchezze, e le cure di temporali reggimenti. Egli allora divenne via più pauroso e importevole ai santi, che con ogni industrial da lui lontani si riparavano, fino ad obbligarsi co' voti di schivarne il peso, come fecero quegli apostolici uomini che, avanti tre secoli, ebbero il Lojola a capitano in fondare una compagnia di operaj infaticabili nella vigna del Signore (2). E nel tempo stesso l'episcopato trovò d'allora in poi troppi più concorrenti, che non sarebbe a lui bisognato, cioè tutti quelli che andavano in cerca di una temporale fortuna, ed avean chiusa altra porta migliore e più difficile a schiudersi, di quella della Chiesa.
Nacque allora appunto la divozione materiale e di formalità de' nobili; nacque quel merito de' plebei che si fece consistere in destrezza di maneggiare affari o in iscienza di leggi canoniche, anzichè in zelo e virtù di maneggiare la spada della divina parola e di guidare anime al Cielo, allora non videro più i principi terreni e i grandi ne’ pingui vescovadi, che de’ mezzi di premiare de' loro adulatori o de' loro ministri, o pure collocamenti pe' loro figliuoli cadetti o anche naturali: e ciò che da prima si fece per istinto d’inconsiderata cupidigia, non andò guari, che divenne un sistema politico e per poco costitutivo dello Stato. Potrei nominare in esempio di ciò che dico indifferentemente qualsivoglia nazione cristiana di Europa: perciocché considerando in ciascheduna, a qual termine vennero le cose della Chiesa, troverassi che nel fondo le massime e lo spirito è quel medesimo che fu nella repubblica Veneta degli ultimi tempi; ne' dominj della quale i Vescovi erano tutti cadetti delle case patrizie, ch’ebbero per avventura vocazione all’episcopato prima di nascere; cioè che prima di nascere furono condannati all’episcopato da uomini ingordi, crudeli, prosontuosi; i quali a compenso di quella condannazione dispensavano poi il pastore della Chiesa di Gesù Cristo da' suoi sacri doveri, e di buon grado gli consentivano di condurre in una oziosa ignavia una vita dissipata. È egli fra tali Vescovi, che si può aspettarsi di trovare la carità maggiore e la fortezza, e quell’unione intima veramente pastorale, che nasce da uno zelo comune per la prosperità della cara Sposa, la Chiesa, e da una sapienza che
sente d’ingrandirsi e di fortificarsi colla conscnsione delle massime e coll’uniformità della condotta?
(2) Molti prendono una specie di scandalo in veggendo che i religiosi tanto fanno nella Chiesa, senza tuttavia esser pastori, e con privilegi che in gran parte li sottraggono al governo de' Vescovi. Ma non è egli evidente, che questo fu un mezzo della Providenza, col quale ella sostenne la Chiesa di Dio, nel tempo appunto che i Vescovi erano distratti dalle temporali grandezze? L'istituzione de' frati mendicanti nel secolo XIII, e de' Cherici regolari nel XVI, ha manifestamente questo scopo di supplire a ciò che non faceva quello che si chiamò pur troppo il Clero secolare.
62.
Degli uomini, ne' quali è un solo pensiero, quello di far progredire l'uman genere verso la verità e la giustizia, e che non hanno, fuor di quest'uno, altro interesse, ben facilmente si stringono in fra loro co' nodi della più sincera amicizia, e intima corrispondenza. La verità è universale e immutabile; e quella unione che ha per oggetto questo bene divino, non può a meno di essere anch'essa universale, non limitando il numero de' suoi membri; come altresì avendo questo bene divino per vincolo, ella non può a meno di essere stabile e permanente, senza cessare per vicenda, nè allargarsi in mezzo al cangiamento pur di tutte le circostanze esteriori della vita. Tale era la fratellanza de' Vescovi antichi, che aveva ad oggetto e a nodo l'evangelica verità, e Dio stesso a fondamento. Ma ove l'animo dell'uomo si volge a' beni terreni, e se ne propone a fine il godimento, e per conseguente altresì la conservazione e l'aumento; egli non è più libero, non è più consecrato esclusivamente a quel bene sommo, che può esser di tutti senza che venga meno a nessuno, e che non riceve il prezzo dalle cose esteriori e mutabili, ma lo ha in sé solo immobilmente. L'uomo allora è vano: non può più formare una società veracemente leale, e di perpetua e indissolubile amicizia con altri uomini. La sua società non può essere altro mai che condizionata alle circostanze; sieno pure quali esser si vogliano le formalità esterne, sieno quali esser si vogliano in un tempo o nell'altro i segni convenuti di parziale affezione: l'unione ha tuttavia sempre un limite sottinteso, è accompagnata sempre di timori e di cautele, dee andar fornita di molte riserve, che incredibilmente la indeboliscono e le fanno del tutto cangiar natura. «Se, con chi, come, quanto, e fino a tanto che l'unione non nuoccia all'interesse preso di mira, che è l'oggetto, o almeno la condizione della unione medesima»: ecco quante formule sottintese. Ove adunque i Vescovi ricchi e possenti non sieno eroi straordinarj di virtù, ma più tosto di quel genere d'uomini, i quali mirarono forse tutta la vita in una pingue Sede come in loro sospirata beatitudine, che ne avverrà? Che s'aspetterà da questi apostoli? Qual dubbio che la loro sollecitudine avrà per confine il loro avere e temporal potere? Beati nella temporale loro sufficienza, non mai gran desiderio potranno sentire di mantenere una spirituale corrispondenza cogli altri Vescovi: chè, assorbiti in materiali affari, non avanza lor gran tempo nè voglia da tener vivi simiglianti ecclesiastici carteggi, che pure richieggono altra disposizione e tempra d'animo, ed altro genere di studj; o se per miracolo procacceranno di conservare una qualche unione e corrispondenza, certo questa riuscirà impacciata da tutte quelle pastoje sopra espresse del modo, delle persone, del grado e del tempo, in una parola, del non provare alcuno sturbo a' loro agi, o alcuna noja alla loro quieta beatitudine, o alcun pericolo di minorazione alla loro secolaresca grandezza.
63.
La storia della Chiesa dimostra ancora, che i Vescovi venuti in possesso di signorie, furono inimicati fra loro, e implicati in fazioni, in guerre, in tutte le orribili discordie che hanno agitati i popoli de' secoli interi, discordie atroci contro l'umanità, fatali a quella Chiesa che è fondata nell'amore, come pure orribilmente scandalose nelle mani di loro, a cui Cristo avea detto: «Vi mando siccome agnelli nel mezzo de' lupi (1)». Ed era ben naturale che tali Vescovi, resi uno degli Stati del governo politico, e per avventura il più influente, e a questa loro temporale fortuna oggimai affezionati, avvolti fossero in quelle risse e discordie, che fra i potenti del secolo ribollivano; perocchè il potere e la ricchezza sono di lor natura infauste fonti di contese, o a chi le vuol difendere per conservarle, o a chi le adopera quali mezzi di offendere, per ingrandirle. Però l'unione santa, perpetua, universale dell'episcopato de' primi tempi cessò, e a lei suceessero quelle unioni parziali e momentanee, che producono i temporali interessi, voglio dire le confederazioni, le leghe, le funzioni. Qual divario! Potea con tali partiti conservarsi l'unità del corpo episcopale? Non doveva necessariamente riuscirne un po' alla volta quell'isolamento universale de' Vescovi, che pur troppo è una delle piaghe più gravi ed atroci che fanno inconsolabilmente lagrimosa la Chiesa di Dio?
64.
Que' Vescovi, i quali sono immersi in cure e negozj secolari, egli è bene evidente che debbono avvolgersi di continuo con magnati e con principi: ed è evidente ancora, che l'esser continuo con tali persone del secolo non può farsi a lungo senza prenderne i costumi e i modi, e senza modificare al gusto di quelle anche se stessi, la propria famiglia, le proprie abitazioni. Egli è evidente ancora, che la conversazione secolare è assai opposta all'ecclesiastica, e che chi si è reso vago del fasto, del clamore e della licenza di quella; schifa oggimai la modestia, l'ordine e la severità di questa. Dovea dunque necessariamente avvenire, che al prelato, dalla grandezza del secolo occupato, non solo nojasse il ravvolgersi fra la plebe, pur suo gregge, e co' cherici inferiori, intesi esclusivamente alle umili funzioni della Chiesa e a' particolari della cura d'anime; ma che anche alla conversazione stessa cogli altri prelati, appunto perchè ecclesiastici, preferisse quella de' grandi secolari, più gaja, men censoria, e talora ben anco alle sue mire più vantaggiosa.
65.
Un fine della Providenza in far sì che la potestà ecclesiastica acquistasse grande influenza ne' politici reggimenti, fu certo quello di costituire de' mediatori pacifici fra i governanti ed i governati, fra i deboli ed i forti; acciocchè la Chiesa, dopo aver insegnato per sei secoli ai primi la sommissione e una mansuetudine senza esempio; insegnasse altresì ai secondi a mitigare l'uso della potenza, ed umiliasse anche questi sotto la Croce, e per la Croce sotto la giustizia; e così fosser cangiati da arbitri delle cose umane, in ministri del popolo di Dio per essa giustizia e per la beneficenza: e questa incumbenza della ecclesiastica potestà, questa nobile missione della Chiesa del Cristo, fu da lei esercitata colla bocca di tanti Vescovi che parlarono la verità e, come dice la Scrittura, i testimonj di Dio in cospetto de' re, i quali Vescovi anche nella perversione di un gran numero di loro fratelli, non mancarono mai. Questi contrapponendo i loro petti episcopali ai primi feroci loro risentimenti, ne ruppero l'impeto: calmati poscia i subitanei furori, li resero atti a conoscere l'esistenza di una potenza morale, ben altra da quella puramente materiale ch'essi possedevano; pacifica potenza, e piena di mansuetudine, ma che non richiede meno che di essere la direttrice, la giudicatrice della forza bruta; e questa inaudita potenza era l'evangelica legislazione, dalla qual sola ebbero origine tutte quelle lotte, soggetto di tante dicerie e di tante calunnie, e pur così ammirabili, così generose, che sostennero co' monarchi in favore de' popoli i Pontefici del medio evo, e che portarono al mondo per risultamento una tutta nuova sovranità, una tutta nuova monarchia, la monarchia cristiana. Così l'Eterno disponeva che il governo feroce dei signori della terra si modellasse a quello pacifico dei Vescovi della Chiesa, e che cessassero d'essere nel mondo cristiano degli schiavi, appunto perchè la Chiesa di Cristo non ha che dei figliuoli; che cessasse d'avervi un potere arbitrario, appunto perchè la Chiesa non ha che una potestà santa e ragionevole; che cessasse finalmente d'esservi pochi uomini a cui i molti fossero de' puri mezzi, appunto perchè la potestà della Chiesa non è che un ministerio e un servigio che i pochi prestano ai molti, sacrificando se stessi al bene degli uomini fatti lor prossimi. Iddio ottenne tutto ciò pel Cristo: l'ottenne ne' fatti, e dove i fatti mancarono, l'ottenne nel giudizio pubblico grave sui prevaricatori non abbastanza difesi in contro a questo dalla loro potenza. Conciossiachè le massime evangeliche entrate in tutte le menti, divennero gli elementi di un nuovo senso comune che fa giustizia de' monarchi, e la fa con quella severità che non si vide mai altro che ne' popoli cristiani. Ma questa nobile missione del Clero cattolico è consumata: il periodo della conversione della società finì nel secolo XVI. Oggidì tutto mostra che si prepari una nuova Epoca alla Chiesa, che ha lavorato gli ultimi secoli a racconciare i più minuti suoi danni. Perocchè un Clero reso servo e adulator vile de' principi, non è più un mediatore fra questi ed il popolo che lo rigetta; e nascono allora de' tempi simili ai nostri, in cui tutto è irreligione ed empietà. Il potere ecclesiastico è allora slogato; egli non istà più in mezzo al potere legale de' Re, e al potere morale de' popoli; ma assorbito dal primo, non è più che il primo medesimo, che da quell'ora rimane egli stesso mostruosamente snaturato, mostrante due facce, crudele l'una, e l'altra fraudolenta, e due forme, militare l'una, e l'altra clericale; e in quel tempo il mondo rigurgita quinci di bande militari, quindi di un numero eccedente d'inutili Sacerdoti: allora i re sono in cospetto ai popoli: vi sono o per riceverne la sentenza capitale, o (che è più funesto a dire) per darla: non è più chi li concilii, chi congiunga le destre degli uni e degli altri, chi ne benedica i patti, e ne riceva i giuramenti, senza fede, come senza sanzione: ciascuno de' due paventa e minaccia: prepara una battaglia campale, e in una battaglia tutto avventura. Qual maraviglia però se in Russia, in Germania, in Inghilterra, in Isvezia, in Danimarca e in altre nazioni, tostochè i principi già cattolici, dominati dal capriccio accidentale di qualche passione, vollero dichiararsi capi della religione, e dividere i loro stati dalla Chiesa; non trovassero quasi nessuna resistenza nell'episcopato, trovassero anzi ne' Vescovi i ministri più zelanti dello scempio crudele che intendevano fare del corpo della santa Chiesa? Quegli scismi erano fatti prima che si facessero: non furono aggiunte che le formalità esterne, non fu cangiato che un nome: il potere ecclesiastico, che solo poteva impedirli, non esisteva più, fuso nel potere sovrano: i Vescovi avevano rinunziato ad esser Vescovi, per esser grandi di corte; e non solo s'erano divisi fra loro, divenuti emuli gelosi e rissosi; ma altresì dal loro Capo il romano Pontefice, e dalla Chiesa universale, a tutto preferendo la loro unione individuale col Sovrano; così avevano rinunziato ogni esistenza propria; e col fatto, anteposto di essere anzi schiavi di uomini mollemente vestiti che Apostoli liberi di un Cristo ignudo. Ahimè, quale vista danno di sè oggidì le nazioni cattoliche! Quale sarebbe la unione e la generosità dell'episcopato, se entrasse nell'animo ad un sovrano di dividersi dall'unità della Chiesa!
66.
E si osservi, che quand'anco la prostituzione de' pastori primarj non venisse a tanta estremità (sebben niente può arrestarsi nel mezzo, e ogni male siccome ogni bene nella società coll'opera del tempo dee svilupparsi e toccare gli estremi suoi); tuttavia l'aderenza ossequiosa de' Vescovi a' principi, e il continuo avvolgersi di quelli materialmente nei negozj di questi diminuisce mai sempre l'unione del corpo episcopale. Perocchè il Vescovo fatto ministro al principe, o certo reso persona influente ne' politici affari, dee tenersi con circospezione con quelli che usan con lui, e anco co' medesimi confratelli suoi nell'episcopato; egli diventa da quell'ora uomo cauto, taciturno, riserbato, di difficile abbordo. In tali circostanze tutti i partiti politici che si formano in una nazione, anzi tutti i sistemi che si seguono nelle amministrazioni, separano e squarciano in altrettanti pezzi il corpo episcopale. pezzi che talora aderiscono fra sè quanto alle forme esterne, per qualche tempo di pubblica tranquillità; perocchè le forme eccclesiastiche ritenute dall'antichità non pubblicano che fratellanza ed amore; ma che però non sono meno disgiunti e rotti nel secreto; e più sciaguratamente rotti, perchè coperti superficialmente col manto della pastorale mitezza. Che poi diremo dell'unione de' Vescovi di più nazioni? Avendo cessato, in quanto al fatto, di essere Vescovi della Chiesa cattolica, essi non sono più che pontefici nazionali: e come il grado episcopale si è cangiato in una magistratura, in un impiego come tutti gli altri impieghi politici; così fanno anch'essi co' Vescovi stranieri, e colla stessa Chiesa di Dio le loro guerre e le loro paci, le loro tregue e le loro ostilità. Già nel secolo XV videsi il più assurdo scandalo che siasi mai veduto nella Chiesa; congregarsi un concilio diviso per nazioni, nel quale, rinnegata col fatto la potestà che i Vescovi hanno ricevuto da Cristo di essere giudici della fede e maestri in Israello, si tolsero a decidere le controversie dogmatiche del cristianesimo, non già voti di prelati, ma a voti di nazioni; e nelle assemblee di ciascuna nazione ammettersi a votare co' Vescovi e Sacerdoti e laici alla rinfusa: preludio infelice di quelle tante diete e congressi di principi secolari che nel XVI secolo susseguirono in Germania, in occasione della riforma, ai Concilj deplorabili del secolo precedente; e di quelle decisioni, onde tante magistrature cittadinesche giudicando in materia di religione rinunziarono alla fede de' loro padri. I Vescovi aveano perduto il loro voto; la potestà laicale se l'avea divorato. E dopo ciò, qual maraviglia de' preti costituzionali di Francia, e del mostruoso sistema della Chiesa nazionale?
67.
Sì; convien finire con una Chiesa nazionale, allorchè l'episcopato non si considera quasi più come il corpo de' pastori, ma come il primo degli Stati; allorchè egli è divenuto una magistratura politica, o un consiglio di Stato, o un'accolta di cortigiani: e questa nazionalità della Chiesa, che esiste in fatto assai prima che in formalità, è direttamente l'opposto, è la distruzione intera di ogni cattolicità. In che modo il Capo della Chiesa cattolica, geloso di lei, sposa del solo Cristo, si affratellerà di buon animo con simili Vescovi nazionali o regj? Non si trova in questa sola dimanda una abbondantissima ragione de' limiti messi dal Romano Pontefice al potere de' Vescovi, e delle riserve pontificie che divennero pure lungo argomento di tante querele e di tante calunnie (1)?
O ci avrebbe avuto altro mezzo di salvare la Chiesa nella dissoluzione di tutte le sue parti, nella divisione di tutti i suoi Vescovi, fuor di quest'uno, di rendere cioè più forte e più attivo il centro della medesima? Non era urgente in tali circostanze che il Capo de' Vescovi stringesse a tempo quelle redini ch'essi lasciaronsi così miseramente cader di mano, acciocchè non precipitasse il carro celeste nella voragine? In fatti, se rimane alcun che di libertà nella Chiesa (e senza libertà la Chiesa non esiste meglio che l'uomo senz'aria di cui respiri), questo poco che rimane non è presso a' Vescovi soggetti a principi cattolici, ma si è tutto concentrato nella sedia Romana, salva forse la libertà che gode la Chiesa presso gli Stati uniti d'America, o in altre regioni acattoliche; quivi solo il cattolicismo respira ancora in qualche modo. Dico in qualche modo; perchè tutto si è fatto, tutto si fa per trarre nell'ignominia de' ferri universali anche il Pontefice Romano; e s'egli è libero, non è libero che di giorno in giorno, e sempre stanco da' combattenti; è libero, ma come un Sansone nel mezzo de' Filistei, a patto che spezzi incessantemente e prodigiosamente le sempre nuove ritorte che gli si avvolgono intorno. E pure egli è libero; sì, egli è libero ancora a malgrado di tutte le transazioni che è costretto dolorosamente di fare con que' «re della terra che si stanno intorno a lui, con que' principi che sono convenuti insieme contro il Signore, e contro il suo Cristo (2)»; ma appunto perchè egli è libero, appunto perchè è indomabile, essendo superiore la virtù che il sorregge, alla potenza degli uomini, appunto per questo si è che «fremono le genti, e che i popoli meditano cose vane»; appunto per questo si leva la terra tutta, e fa impeto in lui solo tutto l'inferno, e non ha altra rocca inespugnata, in cui volgere le sue macchine: appunto per questo si è che le dissensioni tante degli uomini subitamente si attutano, ove si tratti di unirsi insieme ai danni del capo visibile della Chiesa. E appunto per questo si è ancora, che non pure gli empj, non pure gli eretici, non pure i regnatori, ma i Vescovi, ma i Cleri aulici e nazionali nel loro secreto non hanno altro oggetto più odioso, più abbominevole che il loro Padre comune, il Vescovo Romano; perchè egli è l'unico ostacolo che incontrano ancora in sulla via della dispersione, per la quale si sono messi per ignoranza, per infermità, per pregiudizio, per corruzione, per indiavolata malizia; via, dico, che conduce all'apostasia, alla vendita di Cristo, alla disperazione di Giuda; ed essi nulla pur ne comprendono! In tante sciagure della Sposa del Redentore, i fedeli discepoli del tradito Maestro non avrebbero conforto alcuno, se prima di essere crocefisso non avesse loro lasciata questa parola: «Tu sei pietra, e sopra questa pietra io edificherò la mia Chiesa, e le porte dell'inferno non prevarranno contro di lei (3)».
(2) Ps. IV.
(3) Matt. XVI, 18.
68.
Un altro deplorabile effetto di questa falsa posizione de' Vescovi, che più e più li divise fra loro, si fu la gelosia de' Sovrani verso di essi. Divenuti i prelati altrettanti signori temporali, subirono le gelosie e le vicende stesse della nobiltà; e quando questa fu temuta, o guerreggiata dal supremo potere, furon temuti o guerreggiati ancora i Vescovi, e questi anche più de' nobili. Quindi vennero altresì sopravvegliati, circoscritti sempre più nelle loro operazioni, vincolati in tutti i loro passi, chiusi e assediati come prigioni non solo dentro lo Stato, ma nelle stesse loro Diocesi. Così già furono divisi fra loro per massima di Stato, impediti dall'andare a' Concilj o dal congregarne essi stessi, sottomessi a infinite umiliazioni; ben presto il loro potere politico cadde con quello de' nobili; ma più deboli de' nobili, furono più agevolmente di essi spogliati delle loro signorie, invidiate loro d'altra parte da' nobili stessi; e per colmo di loro avvilimento, stipendiati: dal centro dell'unità cristiana, non se ne parla, tenuti lontani un milione di miglia; veduta di buon occhio ogni dissensione fra i Vescovi e il capo loro; seminata la zizzania; lodata, spalleggiata sotto mano, premiata la ribellione. Allora pertanto il Papa, questo Padre de' Padri, questo giudico supremo della fede, questo maestro universale de' Cristiani, non potè più egli stesso comunicare liberamente co' suoi confratelli e co' suoi figliuoli, con quelli che sono da Cristo incaricati di governar la Chiesa con lui e sotto di lui; non potè correggerli, chiamarli al suo tribunale, nè i suoi figliuoli poterono a lui ricorrere patendo ingiustizia (1); le sue decisioni in materia di fede, le sue sentenze in materia di costumi, dovettero prima di pubblicarsi esser sottoposte ad un tribunale laico, che pretese d'innalzarsi sopra ogni tribunale ecclesiastico, anzi che dico a un tribunale? sì bene al calcolo della politica di un principe non turco, nè ebreo, ma battezzato, cioè di un figlio e suddito della Chiesa (2), da cui egli ha pur ricevuto l'ammaestramento cristiano, e che ha giurato nel battesimo di mantenerlo; di un figlio e di un suddito, che può essere avvertito, ripreso, punito come qualsivoglia fedele fra il popolo; conciossiachè la Chiesa non ha accettazion di persone, e gli uomini sono veramente eguali in faccia alla legge di Gesù Cristo. Finalmente, ne' progressi del secolo si giunse a organizzare un nuovo ramo di Polizia esclusivamente per gli ecclesiastici; e fu una polizia la più minuziosa, la più inquieta, la più petulante, sotto le punture innumerabili della quale il Clero cattolico rimane martirizzato col supplizio di que' primi cristiani, che coperti di miele, ed esposti ai raggi del sole, morivano lentamente di beccature di mosche, di vespe e di tafani. Un sistema di questa fatta non fu però condotto alla perfezione tutto d'un tratto. La vasta sua costruzione fu l'opera lunga, faticosa e dotta de' legali, di questi sottilissimi adulatori di tutti i governi: ma il pensiero primo e generale di quest'opera della umana prepotenza è suggerito naturalmente alla politica de' regnatori e de' governi dalla posizione falsa di un Clero decaduto: egli è uno di que' pensieri che operano e dominano nell'anime, e nella condotta de' governanti lungamente prima che nessuno di essi se n'abbia formato una massima esplicita, o se n'abbia saputo render conto, e l'abbia ridotto a teoria. Viene più tardi qualche profondo politico, che si appropria quel pensiero; e da quell'ora egli si costituisce in sistema, e prende il nome dal ministro che prima l'ha veduto più chiaramente, e l'ha seguito più costantemente: indi in poi quel sistema si lavora con infaticabile industria, e si conduce con metodo rigoroso a tutti i gradi del suo ultimo sviluppamento. Chi crederebbe che un sistema politico sì rovinoso alla libertà, all'esistenza della Chiesa, noi lo dovessimo ad un Prelato? Ad un Prelato atteggiato di tutte le apparenze della pietà, ma però ministro di Principe? Ma non sapeva nè pure Richelieu, quando ribassava la nobiltà per render meno impacciato il potere supremo nelle sue mani, ch'egli componeva allora questa monarchia de' moderni troni, la quale è fatta intollerabile ai popoli che le si ribellano contro, perchè forti; ed è fatta intollerabile ai Cleri che vi succombono sotto perchè deboli: nè hanno per iscampo altro che il gemito secreto che prega dal ciclo un nuovo Mosè, che liberi il popolo di Dio dall'Egitto. Ah lo invii senza indugio alla sua Chiesa oppressata quel Signore che abita nella fiamma di un roveto inconsumabile!
(2) S. Gregorio Nazianzeno (orat. ad Civ.): Quid vero vos Principes et præfecti, quid igitur dicitis?.... Nam vos quoque potestati meæ lex Christi subjecit. Imperium et nos gerimus; adde etiam præstantius. Questa è dottrina della Chiesa cattolica.
69.
Se si considera poi come le ricchezze del Clero non usate in opere di carità doveano renderlo oggetto d'invidia alla plebe, di odj ai nobili che vedono in quelle ricchezze altrettanti beni patrimoniali sottratti alle loro famiglie, e di avida cupidigia ai Sovrani; non sarà difficile riconoscere in esse un fonte amplissimo di disunione nel popolo di Dio. Conviene riflettere oltracciò, che la ricchezza posseduta dal Clero non ha in questo corpo, per se stesso alieno dalle armi, una forza corrispondente che la protegga; e che qualunque ricchezza grande priva di difesa, finisce presto o tardi coll'essere il pasto di chi è forte, le cui brame sono non poco irritate dall'aspetto di tesori di facile acquisto. Egli è evidente che tutti gli spogli della Chiesa tante volte ripetuti nelle varie età, ebbero questa sommaria cagione, o per dir meglio questa occasione della debolezza de' possessori. Ciò ne spiega perchè non così di frequente furono spogliati i nobili come i cherici: quelli furono trovati bene spesso forti: ove però divennero deboli in paragone di altra forza estranea ad essi, questa non mancò mai di piombar su di loro; come ultimamente si vide nella francese rivoluzione, avvenimento men nuovo di quel che il vulgo suol darsi a credere. Ma ciò che è sommamente deplorabile negli spogliamenti del Clero si è questo, che per l'ignoranza degli uomini entra nelle menti una torta opinione, che le ricchezze della Chiesa formino una cosa sola colla Chiesa e colla cristiana Religione. Il Clero stesso ebbe pur troppo fomentato questo pregiudizio. Perciocchè non avendo egli altro modo di difendere i suoi beni temporali dagli aggressori che il privar questi de' beni spirituali; agli spogliatori della Chiesa egli rese il delitto del sacrilego ladroneccio indivisibile dalla rinunzia alla religione. Quindi que' principi che furono deliberati ad ogni costo di spogliare il Clero, si deliberarono insieme a dividersi per intiero dalla santa Chiesa. Certo è che se il Clero è avveduto, egli dee procedere in un modo più cauto ne' nostri tempi. Colle scomuniche annesse al rapimento delle sostanze ecclesiastiche si rendeva quel delitto maggiore; perocchè è maggior delitto il rapire e incontrare insieme ad occhi aperti la recisione di sè dalla Chiesa, di quello che sia il solo rapire. E un delitto maggiore, una maggiore empietà, è più difficile che si trovi chi la commetta in popoli religiosi, dove ancor vive la fede, dove non è che un grado limitato di malizia: di che, per certi tempi e in certi luoghi, le scomuniche poterono difendere le ricchezze della Chiesa (1). Ma nei tempi d'incredulità, come pure ovunque la passione e il grado della perversità è trapassato e sa bravare qualunque delitto; la scomunica non raffrena gli scellerati, ma gl'incita e li provoca a passare via oltre i termini nella loro stessa scelleraggine. Forse che in certe nazioni si avrebbe salvato il Cattolicismo dal suo naufragio, sgravandolo a tempo dalle ricchezze mai usate, che il facevano pericolare; a quel modo che si alleggerisce una nave in furiosa tempesta, col gitto in mare delle cose anche più preziose e più care, acciocchè si salvi il legno colle vite de' naviganti. Forse che abbandonando in tempo opportuno ad un Gustavo Vasa, ad un Federico I, e ad un Arrigo VIII le immense ricchezze che la Chiesa possedeva in Isvezia, in Danimarca e in Inghilterra o parte di esse; il Clero povero di quelle nazioni le avrebbe salvate salvando sè stesso, ed avrebbe risuscitata la fede con que' mezzi appunto co' quali gli Apostoli l'aveano piantata! Ma in che parte troveremo un Clero immensamente ricco, che abbia il coraggio di farsi povero? o che pur solo abbia il lume dell'intelletto non appannato a vedere che è scoccata l'ora in cui l'impoverire la Chiesa è un salvarla? Ah ma forse che l'esperienza lunga e funesta.... forse che il grido generoso di libertà mandato poco fa da un uomo, che, qualsiasi l'opinione che sott'altri rispetti s'abbia di lui, pure è dominato da un gran pensiero, che il solleva sopra tutte le particolarità, e un sentimento cattolico che ha qualche cosa di straordinario, si trasfonde in tutte le sue parole, non ha percosso l'aria in vano, non ha in vano irritati gli orecchi di quelle scolte che sono poste da Dio alla custodia d'Israello (2): — forse quell'inquietudine stessa de' popoli che nel manifestarsi prende delle forme al tutto materiali, perchè un sentimento che ha bisogno di espandersi, si veste di quelle forme che prima incontra, sebbene a lui inadeguate, e può esser anco in contraddizione con esso, quell'inquietudine dico, que' lamenti continui degli aggravj materiali, forse che ha una sorgente segreta, che i popoli stessi non hanno ancora rivelata a se medesimi; e si nasconde per avventura un bisogno religioso dove pare che più trionfi l'irreligione; il bisogno di una religione libera di comunicarsi al cuore de' popoli senza l'intermezzo de' principi e de' governi; e il grido irreligioso mentisce a se stesso, e nell'odio di un ministero della religione asservato, confonde e ravvolge per errore la religione medesima; e nell'ordine della divina Providenza si prepara un rimescolamento delle nazioni che ha ben altro fine che di diminuire i tributi (cui i popoli rivoluzionanti sopportano pazientemente maggiori), ma, chi lo crederebbe? di liberare la Chiesa di quel Cristo, in cui mano sono tutte le cose.
(2) Si allude alla proposta che un prete fece al Clero di Francia di rinnuziare agli stipendj che riceve dal governo, e ricuperare così la propria sua libertà; proposta generosa, e degna de' primi tempi della Chiesa. Ella rammenta la libertà, di cui tanto era geloso l'Apostolo Paolo, che per non scemarlasi, non voleva esser mantenuto a spese de' fedeli, sebben n'avesse il diritto come ogni altro Apostolo; e preferiva di aggiungere alle fatiche immense dell'Apostolato anche il lavoro delle mani, col quale guadagnarsi giornalmente quel poco di che avea bisogno per sostenersi: «Omnia mihi licent, diceva, sed ego SUB NULLIUS REDIGAR POTESTATE (1 Cor. VI, 12). Sentimentl così nobill riescono strani a' nostri tempi; ma qualche errore li riceverà; il seme gittato non si morrà senza portare il suo frutto: chè la parola di Dio non ritorna vacua giammai.
Ma chi la ha pronunziata questa parola divina, chi ha sentito sì altamente il prezzo della libertà della Chiesa, perchè ha prodigata poi questa libertà della Chiesa agli empj? perchè non ha veduto che la libertà non è che un diritto esclusivo della verità? perchè ha accomunati i diritti della immutabile verità alla menzogna? ha innalzata l'umanità senza Dio a quell'altezza di grado che solo appartiene all'umanità divinizzata dal Cristo? non si è formato ad adorar nella Chiesa, cioè nella società de' figliuoli di Dio, la colonna ed il firmamento della verità, e s'è lusingato di trovare questa colonna e questo firmamento nella società de' discendenti di Adamo, de' figliuoli degli uomini? Certo il sistema è coerente: se all'umanità del peccato appartiene la verità, a lei appartiene altresì la libertà. Ma per me non veggo possibile che la verità e la giustizia si partano insieme; per me tengo che la verità sia l'appannaggio della società de' giusti; che il diritto d'esser libero non appartenga all'errore; e che perciò l'uomo non nasca, ma si renda libero pel Cristo, pel quale riceve la luce della verità e l'ornamento della giustizia. A coloro solo che sono conscii di non possedere la verità, ma di andarne perpetuamente in cerca, che non possono nè pur mentendo persuadere a se stessi di averne più che una speranza vana che mal non si avvera, a costoro dico, appartiene quella dottrina di disperazione che «tutti i pensieri che ascendono dal cuor dell'uomo sieno egualmente in diritto di propagarsi e di assalire la persuasione inferma e cedevole de' popoli». Non è di un cattolico tale dottrina, no; perchè egli sa di posscdere il vero, ne sente la dignità, il prezzo infinito, e vede che non istà in lui di alienare i diritti. E questa è la ragione perchè il Capo della Chiesa cattolica ha innalzata la sua voce contro una dottrina che si presentava a nome del cattolicismo, l'ha disconosciuta per tale. Doni Iddio lume alla mente dell'uomo, di cui non possiamo parlare senza trasporto di stima e di affetto; gli doni tanto dominio di se stesso, e tanta fortezza di animo, che vincitore dell'amor proprio, e delle adulazioni degli amici e dei nemici, rientri interamente e lealmente nei cammino della verità, alla quale ha prestato tanti servigi, ed ha mostrato tanto di affetto e di devozione, che s'è messo in una fortunata necessità di non potere oggimai più essere coerente a se stesso, se non ritrattando francamente i proprj errori, e sottomettendosi a pieno alla Cattedra eterna a cui il magisterio della verità è affidato.
IV: Della piaga del piede destro della santa Chiesa, che è la nomina de' Vescovi abbandonata al potere laicale.
70.
Ogni società libera ha essenzialmente il diritto di eleggersi i proprj ufficiali. Questo diritto le è tanto essenziale e inalienabile, come quello di esistere. Una società che ha ceduto in altrui mani l'elezione de' proprj ministri, ha con questo alienato se stessa: l'esistenza non è più sua: quegli da cui l'elezione de' suoi ministri dipende, può a suo grado farla esistere, e farla cessare da un momento all'altro; ed anche quando esiste, non esiste per sè, ma per lui, per sua benigna concessione; ciò che forma un'esistenza apparente e precaria, ma non un'esistenza vera e durevole.
71.
Ora se v'ha in sulla terra società che abbia il diritto di esistere, che è quanto dire, che abbia il diritto di esser libera; per tutti i cattolici è certamente la Chiesa di Gesù Cristo: perciocchè questo diritto essa l'ha ricevuto dalla parola immortale del divino suo fondatore; e questa parola, che sovravvive al cielo e alla terra, glielo ha garantito dicendo: «Io sono con voi fino alla fine de' secoli (1)». La Chiesa di Gesù Cristo non può adunque cedere in altrui mano il proprio governo, non può vendere nè alienare in alcun modo a chicchessia la elezione de' proprj governatori, perchè non può distruggere se medesima; e qualunque cessione in questo proposito è irrita per sè, è contratto viziato nell'origine, un patto nullo, a quel modo che è nullo qualsiasi vincolo d'iniquità.
72.
Cristo elesse a principio gli Apostoli; questi elessero i loro successori (1); e a' successori degli Apostoli ha sempre appartenuto (2), e immutabilmente appartiene l'eleggere degli altri a cui consegnare il deposito che dee tramandarsi illeso sopra la terra sino alla fine, e di cui ad essi soli sarà dimandato conto dal Padrone che s'è degnato di porlo nelle loro mani. Il perchè la colpa della mala scelta de' prelati della Chiesa piomberà sulla testa de' prelati precedenti, i quali si sono lasciati i primi uscir di mano le elezioni de' loro successori, o che non hanno usati i mezzi tutti in loro potere per rinvenire delle altre mani pure e fedeli a cui trasmettere dopo di sè il sacro deposito della parola e delle istituzioni di Gesù Cristo.
(2) S. Paolo avea consacrato Tito in Vescovo di Creta; ora scrivendogli gli ordina che faccia anch'egli il medesimo con altre città. «Per questa ragione, dice, ti ho lasciato a Creta, acciocchè tu corregga quelle cose che mancano, e costituisca nelle singole città de' seniori (cioè de' Vescovi) com'io ho disposto con te». Tit. 1, 5.
73.
Vero è che non essendo il governo istituito da Gesù Cristo nella sua Chiesa una dominazione terrena, ma un servigio in favore degli uomini, un ministero di salute per le anime (1); egli non è retto dall'arbitrio di una dura autorità, non si picca di un crudo diritto; ma egli si piega, e, fondato nell'umiltà e nella ragione, riceve la legge, per così dire, da quei soggetti medesimi in vantaggio de' quali è stato istituito, e la sua mirabile costituzione è appunto quella di potere ogni cosa pel bene e niente pel male: tale è la sola sua superiorità, il solo diritto che egli vanta, il diritto di giovare. Indi quel dolce principio dell'ecclesiastico reggimento, che in tutto manifestavasi ne' primi secoli della Chiesa, e particolarniente nella elezione de' primari pastori ed era questo «IL CLERO GIUDICE, IL POPOLO CONSIGLIERE». Certamente ove si fosse trattato di un rigido e stretto diritto, nessuna parte poteva avere la plebe cristiana nella elezione de' Vescovi; ma perchè era la sapienza e la carità quella che presiedeva all'esercizio del diritto che i governatori della Chiesa avean ricevuto da Cristo, e lo temperava, ammollendone ogni durezza; perciò nulla decidevano arbitrariamente que' savj prelati, nulla in secreto, nulla di proprio capo; volevano il testimonio altrui ed il consiglio, e giudicavano che il consiglio migliore di tutti, il consiglio meno soggetto ad ingannarsi fosse appunto quello dell'intero corpo de' fedeli. Così la Chiesa de' credenti operava siccome un solo uomo; e sebbene in quest'uomo il capo si distinguesse dalle membra, tuttavia non rifiutava i servigi delle membra, e non si recideva da se stesso per voglia di essere solo, e da quelle indipendente. Indi è che i desiderj de' popoli designavano e i Vescovi e i Sacerdoti (2); ed era troppo ragionevole che quelli che dovevano abbandonare le proprie anime (e quando dico le anime, dico tutto ciò che posso dire, parlando di popoli, ne' quali è viva la fede) alle mani d'un altro uomo, sapessero che uomo egli fosse, ed avessero confidenza in esso, nella sua santità e nella sua prudenza (3). Ma ove il Vescovo ed il Sacerdote già non ritenga di pastore che il nome, non sia più il confidente, l'amico, il padre de' fedeli, che a lui con piena fiducia abbandonano non pur ciò che aver possono di più caro, ma se medesimi; ove il Clero si restringa alle formalità o alle materiali e determinate cerimonie di culto, reso, quasi volea dire, simile agli antichi Sacerdoti del paganesimo (4); quando le cose di quella religione, che insegna ad adorare Iddio in ispirito e verità, sono venute a questo termine; non è difficile allora che il popolo si sottometta a ricevere con indifferenza qualsivoglia pastore gli s'imponga, e che il diritto di eleggerlo passi d'una in altra mano, d'uno in altro padrone, come farebbe la proprietà di un terreno o di una casa. E si pronunzieranno invettive contro l'indifferenza pubblica in materia di religione? quando si esige pur dal popolo, e lo si educa in modo, ch'egli sia disposto a ricevere a suo Vescovo qualsiasi incognito e straniero personaggio col quale nè ha comunanza alcuna di affetti, nè vincoli di ricevuti benefizj, e le cui sante opere nè mai vide, nè udì tampoco per fama? Dio voglia che non ne abbia se non di sante! Ma l'esigere, e rendere il popolo indifferente ai proprj pastori, non è il medesimo che renderlo indifferente a qualunque dottrina gli s'insegni, indifferente ad essere condotto per una o per un'altra via? Non è un esigere che non s'abbia più dagli uomini bisogno d'aver confidenza ne' ministri della religione, cioè che s'abbia rinunziato ai bisogni ed ai rimorsi dell'anima, che in somma si possa far senza religione, o contentarsi al più della esteriorità e materialità di essa? E che è questo se non l'aver fatto al popolo un obbligo di una cieca, o per meglio dire irragionevole obbedienza, che è un sinonimo perfettissimo di indifferenza religiosa (5)? Vero è che quando si è riuscito ad ottener questo dal popolo cristiano, allora si è riuscito a pervertirlo, a distruggere nell'anima sua il cristianesimo, lasciandolo solo nelle abitudini: e di un popolo tanto infelice, che mediante una secreta, lenta e costante corruzione ha perduto senza accorgersi il principio religioso, di un tal popolo, dico, assopito sui suoi religiosi interessi, e già nel fatto indipendente da' suoi Vescovi (6), indifferente perciò a qualsiasi cherico presieda al coro, ed eseguisca le sacre cerimonie che non intende; si può dire giustamente quello che diceva un Padre del terzo secolo della Chiesa, cioè, che «secondo il merito del popolo, Iddio provvede altresì i pastori delle Chiese (7)».
(2) Rimane ancora nel Pontificale Romano la cerimonia colla quale il Vescovo dimanda degli ordinandi se godano di un buon testimonio presso i fedeli. Ma deh che cosa ho detto, quando ho detto, che rimane una cerimonia!
(3) Origene nell'Omilia XXII sul Num., e nella VI sul Levit. dice che «nell'ordinazione del Vescovo, oltre all'elezione di Dio, si ricerca la presenza del popolo, affine che tutti sien rassicurati, che si elegge in Pontefice il più eccellente e il più dotto che sia, e il più santo, e il più distinto in ogni virtù. Il popolo sarà dunque presente, perchè nessuno abbia a dolersi, e che sia tolto ogni a scrupolo».
(4) Un tale concetto del sacerdozio pur troppo prevale: si crede, o si affetta di credere che le funzioni del cristiano sacerdote tutte si limitino dalle mura materiali della Chiesa!! Ecco in che modo parlava poco fa il sig. Dupin seniore nella camera de' deputati di Francia (seduta del 23 febbrajo 1833): J'ai le plus profond respect pour la liberté du prètre, tant qu'il se renferme dans ses fonctions: si celte liberté était attaquée, je serais le premier à la défendre; mais que le prêtre se contente du maniement des choses saintes, ET QU'IL NE SORTE PAS DU SEUIL DE SON ÉGLISE; hors de la, il rentre pour mois dans la foule des citoyens; il n'a plus de droits que ceux du droit comun. È questo il prete cattolico? è il prete istituito da Gesù Cristo questo di cui si parla? Ma dove mai Gesù Cristo ha rinserrato il sacerdozio entro le mura della Chiesa? Oh non gli ha detto: «Andate, predicate a tutte le genti»? non gli ha detto: «Voi siete il sale della terra»? Quando ha parlato di templi materiali il divino Fondatore della Chiesa il quale ha insegnato che «i veri adoratori adorano il Padre in ispirito e verità»? E non ha dato al sacerdote la facoltà di sciogliere e di legare? forse solo dentro le chiese? allorchè gli ha comandato di annunziare la verità dal di sopra de' tetti, allorchè lo ha invitato dicendo: «Come il Padre ha mandato me, così io mando voi»: allorchè gli ha ingiunto di portare il Vangelo nel cospetto del tiranni e dei dominatori della terra, metteva egli allora quegli stretti limiti al sacerdozio cristiano, di cui lo circonda il sig. Dupin? Ma l'ignoranza, o i pregiudizj del sig. Dupin sono in certo modo scusabili, poichè sono l'effetto di tutto il tristo sistema delle cose pubbliche, e degli imbarazzi creati dalla politica alla Religione.
(5) Il grande S. Leone conosceva assai bene che il costringere il popolo a ricevere un Vescovo da lui non voluto era un depravarlo, e questa è una delle ragioni per le quali quel santissimo Pontefice sta fermo nel mantenere la disciplina antica della Chiesa circa l'elezione de' Vescovi fatta per via del Clero, popolo, e Vescovi provinciali. Ecco uno de' molti passi di questo grand'uomo, che potrei riportar qui in prova di ciò che affermo. Egli scrive nell'anno 445 ad Anastasio Vescovo di Tessalonica in questo modo (cap. 5): «Quando si tratterà dell'elezione del sommo Sacerdote, si preferisca a tutti colui, che il consenso del Clero e della plebe ha concordemente richiesto: di modo che se forse i voti si spartirono in altra persona, venga preferito quegli, a giudizio del Metropolitano, il quale ha conseguito più di affetto, e possiede più meriti: a solo si badi, che nessuno si ordini di quelli che non sono voluti o non domandati, acciocchè la plebe contrariata non disprezzi od odii il suo Vescovo; e NON DIVENTI MENO RELIGIOSA CHE NON CONVIENE, NON AVENDO POTUTO AVERE QUELLO CH'ESSA AVREBBE VOLUTO»; ne plebs invita Episcopum aut contemnat aut oderit; et fiat minus religiosa quam convenit, cui non licuerit habere quem voluerit. Tale era la maniera di pensare de' Leoni! Vedete ciò che il medesimo sommo Pontefice scrive nella lettera a' Vescovi della provincia Viennese cap. 3, e nella lettera a Rustico di Narbona cap. 7.
(6) Per vedere quant'era la stretta unione e dipendenza, negli antichi tempi, de' popoli co' loro Vescovi, basterà desumerlo da una circostanza, che non solo i Sacerdoti, ma anco i semplici fedeli, passando da una provincia ad un'altra, doveano prendere da' loro Vescovi delle lettere per mostrare che essi erano nella comunione della Chiesa. Nel Concilio di Arles dell'anno 314 si ordina «che anche i governatori delle provincie, giunti a quelle cariche mentr'erano fedeli, debbono come gli altri prender lettere di comunione de' loro Vescovi, e il Vescovo del luogo dove esercitano la carica, dee aver pensiero d'essi, e se alcuna cosa fanno contro la disciplina, scomunicarli». Lo stesso di tutti coloro che sostengono pubblici impieghi.
(7) Origen. in Iudic. hom. IV.
74.
Il combattimento col potere secolare che voleva tirare a sè le elezioni de' Vescovi durò per molti secoli: la Chiesa si difendeva co' canoni; ma questi sono rispettati in ragione della religione de' principi; e della opinione religiosa de' popoli, perciò la ragione in che venne meno la libertà nelle elezioni del Clero, può essere una misura sicura del decremento della fede, della moralità e della pietà ne' governi e nelle nazioni. Eccone una breve storia.
Già nel secolo VI cominciò a pesare immensamente nella bilancia degli elettori più che i meriti del candidato, il favore del sovrano: e allora i Concilj co' loro canoni accorsero sollecitamente al pericolo, difendendo la libertà di quelle elezioni.
Il Papa Simmaco in un Concilio tenuto a Roma l'anno 500, dove intervennero dugento e diciotto Vescovi, pubblicò un decreto in conferma delle elezioni canoniche de' Vescovi contro la potestà laica, che continuamente vi volea porre le mani, il qual decreto comincia con queste parole: «Non ci piacque che abbiano verun potere a stabilire checchessia nella Chiesa alcuni di quelli, a' quali spetta il dovere di venir dietro, e non l'autorità di comandare»; e dopo questo esordio, fissa il modo antico di eleggere i Vescovi co' voti del Clero e del popolo (1).
Il concilio di Clermont dell'anno 533 (2) ingiunge che il Vescovo sia ordinato per l'elezione de' Cherici e de' cittadini, e col consenso del Metropolitano, senza che ci abbia luogo la protezione de' grandi, senza uso d'artificio, e senza costringere veruno per timori o per doni a scrivere un decreto di elezione: altrimenti sia il concorrente privato della comunion della chiesa che vuol governare (3).
Questa stessa premura di tener libere le elezioni dell'influenza della potenza temporale, si vede nel II concilio di Orleans dell'anno 533 (4), e nel III dell'anno 538 (5) come pure nell'Avernese dell'anno 535, e in altri: il che mostra il bisogno che avea la Chiesa in questi tempi di difendersi in qualche modo dalla potenza temporale, che pur troppo sdrusciva continuamente in essa, e si faceva signora de' suoi diritti.
A questa poco dopo è riuscito in Francia di far sancire per legge ecclesiastica la necessità dell'assenso regio, che già di fatto s'era reso necessario nelle elezioni de' Vescovi: ciò che si fece col celebre canone del concilio V d'Orleans (549), nel quale però sono salvi i diritti del popolo e del Clero (6). Nè l'assenso regio è punto irragionevole il chiedersi, anzi egli è certamente conforme allo spirito della Chiesa, spirito di unione e di pace, che vuole i ministri del Santuario a tutti accetti, e quindi molto più a' capi de' popoli; ma egli involge pur quell'assenso un sommo pericolo, cioè non forse si tramuti in comando (7), non diventi grazia sovrana; perocchè in tal caso la Chiesa libera per grazia, è serva per giustizia (8); e la grazia di sua natura è arbitraria; sicchè l'avere o non avere la Chiesa i pastori più degni, sarebbe abbandonato al volere e al capriccio medesimo di persona laica perchè possente, e di quelli e di quelle che più acquistino su di essa influenza.
E così si vide avvenire; e non solo fu grazia l'assenso, ma fu una grazia anche il comando; e finalmente fu una grazia venduta, e si volle vender ben caro; e i beni della Chiesa (9), l'avvilimento, l'anima fu la moneta destinata a comperarla (10).
Questo pericolo diede cagione al Concilio III di Parigi tenuto quattro anni dopo l'Orleanese, cioè nel 553, di rimettere in istato con un canone l'antica libertà delle elezioni, senza far più menzione di regio consenso.
«Nessun Vescovo, dice il canone 8.º di questo sinodo, sia ordinato contro la volontà de' cittadini, ma solo quegli che l'elezione del popolo e de' cherici ha con PIENISSIMA VOLONTA' dimandato. Nessuno venga intruso per comando del principe, o per qual si voglia condizione, contro la volontà del Metropolitano, e de' Vescovi comprovinciali. Che se taluno presunse con eccesso di temerità d'invadere per ordine del re l'altezza di questo onore, sia riputato indegno d'essere ricevuto da' Comprovinciali di quel luogo, i quali lo riguardino per indebitamente ordinato».
In sulla fine di questo medesimo secolo VI, il grande Pontefice S. Gregorio sentiva tutta l'importanza della libertà della Chiesa, e d'altra parte ben intendeva che i Vescovi che hanno ricevuto il loro innalzamento dalla potenza secolare, sono servi di essa. In occasione della morte di Natale Vescovo di Salona, metropoli della Dalmazia, scrivea il Papa in questo modo al soddiacono Antonino rettore del patrimonio di quella provincia l'anno 593: «Avvertite immediatamente il Clero ed il popolo della città, di eleggere concordi un Vescovo, e mandateci il decreto della elezione, affine che il Vescovo sia ordinato col nostro assenso, come negli antichi tempi. Sopra tutto abbiate cura, che in tale opera non entrino nè regali, nè protezione di persone potenti; poichè quegli che è ordinato per tal via, è costretto ad ubbidire a' suoi protettori, a spese de' beni della Chiesa e della disciplina» (11).
Nel 615 il Concilio V di Parigi proclamò pure la libertà delle elezioni; se non che Clotario II modificò il Concilio con un editto col quale protestava di voler bensì osservati gli statuti de' canoni circa le elezioni de' Vescovi, ma fatta però eccezione a que' Vescovi che sarebbe piaciuto a lui che fossero ordinati, o che avrebbe mandati egli dal suo palazzo scelti fra i degni sacerdoti di corte: editto che anche sotto Dagoberto suo successore si fece valere (12).
Il concilio Cabilonese però sotto Clodoveo II nell'anno 650 dichiarò di nuovo irrite e nulle senza eccezione alcuna tutte quelle elezioni, che non procedesscro secondo le formme stabilite da' padri (13).
E in questo tempo si vede in Francia una continua lotta, sebbene secreta e fatta con menature e riguardi, fra i re e il Clero; quegli per usurpare le elezioni vescovili, questo per tenerle libere (14); lotta che s'ebbe varia vicenda, ma rimanendo sempre la chiesa se non del tutto oppressa, almeno premuta e intollerabilmente aggravata dal peso della forza.
I Papi non dormirono certamente sopra il pericolo ogni dì crescente, che la potestà de' principi non invadesse le elezioni episcopali, invase le quali, la Chiesa intera pende nelle loro mani; e vedesi sul principio dell'VIII secolo Gregorio II scrivere fino in Oriente a quell'imperatore per ammonirlo e distorlo dal metter le mani in questo sacrosanto diritto che ha la Chiesa di dare a se stessa i proprj prelati (15). Ma che? La prepotenza si rinnovava continuamente, e la Chiesa non poteva opporre che sempre nuove leggi, nuovi canoni, e nulla più.
Il settimo Concilio ecumenico in fatti, che fu tenuto a Nicea in questo stesso secolo l'anno 787, non mancò anch'egli di fare scudo alla Chiesa di un suo canone contro alla prepotenza di questo mondo, che suol persuadere lecito a se stesso tutto che può: «Ogni elezione, dice il santo Concilio (16), di Vescovi, o Preti, o Diaconi, fatta da' principi, rimangasi irrita secondo la regola che dice: Se alcuno usando delle potestà secolari ottiene per esse una Chiesa, sia deposto, e sieno segregati tutti quelli che con esso comunicano. Conciossiachè è necessario che quegli che hassi a promuovere all'Episcopato, sia eletto da' Vescovi, come fu definito da' santi Padri che convennero appresso Nicea».
Il sinodo tenuto l'anno 844 vicino alla villa di Teodone (17), mandò un solenne monitorio ai regj fratelli Lotario, Lodovico e Carlo, perchè le Chiese non rimanessero più oltre vedovate di pastore, siccome accadeva dal dipendere le elezioni di quei Vescovi da' principi, i quali in discordia fra loro, non avevano il tempo e l'animo agl'interessi della Chiesa, e così la Chiesa da tale servitù partecipava di tutte le vicende del potere laicale: «Come legati di Dio, dicono con molta dignità e libertà que' Padri, noi vi ammoniamo, che le sedi, le quali rimangonsi vedove di pastore per le vostre discordie, debbano senza dilazione, e rimossa al tutto qualsiasi peste di eretica simonia, ricevere i loro Vescovi, i quali vogliono essere dati da Dio conforme l'autorità de'canoni, e da voi regolarmente designati, e dalla grazia dello Spirito consecrati».
Intorno a questo tempo stesso il sommo Pontefice Nicolò I, fortissimo difensore de' canoni in ogni cosa, non mancò di parlare più volte altamente anche contro questo abuso di mescolarsi nelle elezioni de' Vescovi la laica potestà, come si vede, fra gli altri documenti, nella lettera da lui diretta ai Vescovi del regno di Lottario, a' quali comanda sotto pena di scomunica di avvertire il re perchè tolga via Ilduino dalla Chiesa di Cambrai, che gli avea data, sebbene ne fosse indegno e irregolare, e che permetta «al Clero e al popolo di quella Chiesa di eleggersi da sè un Vescovo a quel modo a che prescrivono i sacri canoni» (18).
Sotto il successore di Nicolò il grande, che fu Adriano II, si celebrò l'ottavo Concilio ecumenico in Costantinopoli nell'869, tempo in cui già la libertà della Chiesa era stata oltremodo vulnerata (19). Si fanno quindi con tutta la forza le stesse proteste in difesa di questa libertà, si ripetono le stesse massime dell'antichità in ordine all'elezioni de' Vescovi: proibizioni di non ordinar Vescovi per autorità e comando di principe sotto pena di deposizione (20): e fino divieto a' laici possenti di intervenire alla elezione de' Vescovi, se non invitativi dalla Chiesa (21).
Ma che? quanto è tarda la ragione e la giustizia nella influenza che esercita sugli uomini in paragone delle passioni! e massime se queste hanno in loro pro la forza esterna? I principi cristiani, lungi dal prestare orecchio alle esortazioni della loro madre la Chiesa, ai suoi comandi, alle sue minaccie; non fecero che nuove usurpazioni sulla sua libertà, sostenute da sottigliezze legali e da violenza. Dico ciò in generale; perocchè certo non mancarono anche de' monarchi docili e rispettosi, i quali ubbidirono; e dirò di più, quasi tutti i principi sentirono una qualche influenza delle continue decisioni e leggi ecclesiastiche che venivano perseverantemente pubblicandosi da' Pontefici e da’ Sinodi intorno la disciplina della Chiesa, della quale il punto massimo di tutti fu sempre considerato essere le elezioni: e però essi talora posero più di riserbo nell'estendere la loro potenza a padroneggiare le elezioni vescovili; non s'avanzarono a eludere le leggi canoniche che mediante de' trovati più ingegnosi; finalmente posero delle dichiarazioni e clausole rispettose alle loro usurpazioni, che formavano una contradizione e una condanna manifesta delle medesime (22). Ma tutto ciò non rese meno necessaria la vigilanza della Chiesa, e la fortezza di quegl'integerrimi speculatori d'Israele che pugnarono le guerre del Signore, e che il secolo non mancò di calunniare, attribuendo i loro generosi sforzi alla propria ambizione ed orgoglio, quando essi operavano, necessitati dalla giustizia, per la guarentigia del deposito loro affidato, e per isfuggire la sentenza di Cristo, che dee un giorno domandar loro un rigoroso conto di quel deposito.
Già fino nel gran Concilio Niceno si sentì il bisogno di fermare con un canone (can. 6) l'apostolica e divina consuetudine delle elezioni; il che prova che appena gl'imperatori furono cristiani, la libertà della Chiesa s'accorse d'essere minacciata. Per la stessa cagione i Concilj susseguenti non mancarono di pubblicar decreti perchè restasse fermo l'antico e legittimo modo di eleggere i Vescovi per via di Clero e popolo; intra gli altri l'Antiocheno, can. 19 e 23.
Fra' canoni apostolici se ne trova uno, ed è il XXIX, che dice così: «Se un Vescovo, facendo uso de' principi sccolari, ha ottenuto la Chiesa pel loro favore, sia deposto, segregato, e simigliantemente sia fatto di tutti quelli che con lui comunicano».
Il papa Celestino I, sul principio del secolo V, fece parimente un decreto, col quale manteneva la stessa libertà: Nullus invitis, dice, detur Episcopus; Cleri, Plebis et Ordinis consensus et desiderium requiratur.
Il grande S. Leone, che tenne la cattedra di S. Pietro nello stesso secolo, cloè dal 440 fino al 461, e che abbiamo citato più sopra, fu di continuo inteso a guarentire la forma libera e canonica delle elezioni de' Vescovi: basti indicare il decreto ad Anastasio vescovo di Tessalonica, ove dice: Nulla ratio sinit, ut inter Episcopos habeantur, qui nec a Clericis sunt electi, nec a plebe expetiti, nec a Provincialibus cum Metropolitani judicio consecrati.
(2) Can. 2.
(3) Can. 4.
(4) Can. 7.
(5) Can. 3. Il Fleury esponendo il contenuto di questo Concilio dice che «vi si raccomanda l'antica formalità nell'elezioni de' Vescovi della provincia col consenso del Clero e de' cittadini; probabilmente per gli torbidi che la possanza temporale incominciava ad introdurvi». Lib.XXXII, § LIX.
(6) Can. 10. Nulli episcopatum præmiis aut comparatione liceat adipisci, sed cum voluntate regis JUXTA ELECTIONEM CLERI AC PLEBIS.
(7) Così pur troppo è avvenuto. Fra le forme conservateci da Marcolfo (L. 1. Ved. anche l'Appendice al T. II. de' Concilj della Francia del P. Sirmondo), le quali erano in uso in Francia sotto i Re della famiglia Merovingia, v'è appunto non quella del consenso che il re desse alle elezioni de' Vescovi, ma sì del precetto. Ella è espressa così: «Col consiglio e volontà de' Vescovi, e de' nostri grandi, secondo la volontà e il consenso del clero e delle plebi della stessa città, nella sopra detta città N, noi vi commettiamo in nome di Dio la Pontificale dignità. Per il che col presente PRECETTO decidiamo e comandiamo che la sopraddetta città, o i beni di essa Chiesa, e il Clero rimangano sotto il vostro arbitrio e governo». Nulla di più frequente negli scrittori di questo tempo che il trovare la frase che «PER COMANDO DEL RE» questi o quegli fosse fatto Vescovo. Vi hanno ancora le formole di suppliche che presentava il popolo al re perchè uscisse fuori questo precetto: facevano bisogno delle suppliche per ottenere de' comandi! tali comandi!
(8) L'adulazione e la vanità inventano queste espressioni, e son prima senza valore, ma passano ben presto ad acquistarne uno troppo reale. È strano il non accorgersi che in questo modo non si concilia a' sovrani quel vero e costante rispetto che loro si dee, ma si usa un linguaggio che diventa in un tempo o nell'altro satirico. Per vero egli sembra un discorso ironico e mordace quello di uno scrittore del secolo scorso, per altro assai erudito, il quale essendo stato censurato per aver detto di questo tempo di cui parliamo, che era «un beneficio del re che ll Clero godesse la libertà dell'eleggere, e che il re era l'arbitro e il giudice dell'elezione» (quasichè queste due cose possano stare insieme); si difende col dire che per beneficio regio intende l'avere i re cessato dall'usurpazione. Non sarebbe questo uno de' benefiej de' ladronl, i quali donano la vita? Ecco le parole dello scrittore per altro sinceramente divoto alla laica potestà: Jus eligendi penes Clerum erat. Sed quia sæpe reges electionum usum interturbaverant, assensum in merum imperium vertere soliti, Ecclesia Gallicana his qui veterem electionum usum restituerant, ut Ludovico Pio, plurimum se debere profitebatur. Eorum certe beneficiorum erat asserta et vindicata sacrarum electionum libertas etc. N. Alex. ad calcem Dissert. XI in sæc, XV ei XVI.
(9) S. Gregorio di Tour scriveva (anno 527) Jam tunc germen illud iniquum cœperat fructificare, ut sacerdotium aut venderetur a regibus aut compararetur a Clericis; le quali parole scrive it Santo dopo aver recati più fatti di Cherici che avevano ottenute le sedi episcopali dal re non per virtù pastorale che avessero, ma per la virtù de' danari.
(10) I re Goti usurparonsi la nomina dello stesso sommo Pontefice, turbandone la canonica elezione. Cacciati questi d'Italia, Giustiniano tenne per sè il diritto di confermare i Pontefici; i successori di lui esigettero una grossa somma di danaro dal nuovo Papa per la grazia di questa conferma, la qual somma fu pagata fino a Costantino Pogonato, che ascese al trono l'anno 668.
(11) II. Ind. c. II, ep. 22. S. Gregorio era vigilantissimo sulla libertà delle elezioni de' vescovati; e questo è argomento che s'incontra frequente nelle sue lettere. Ved. fra l'altre III ep. 7.
(12) Ecco l'espressione dell'editto che è una contraddizione in terminis: Ideoque definitionis nostræ est, ut Canonum statuta IN OMNIBUS conserventur .... Ita ut, Episcopo decedente, in loco ipsius, qui a Metropolitano ordinari debet cum Provincialibus a Clero et populo eligatur. Dopo di queste belle parole, susseguono immediatamente queste altre: Et si persona condigna fuerit, PER ORDINATIONEM PRINCIPIS ordinetur: vel certe, si DE PALATIO eligitur, per meritum personæ et doctrinæ ordinetur. Ecco come la potestà civile intendeva che si mantenessero gli statuti canonici IN OMNIBUS!!!
(13) Can. 10.
(14) Ecco alcuni fatti. Gregorio di Tours (L. IV, c. 5 e 6) narra che i Vescovi pregarono con Istanza Catone, eletto canonicamente a Vescovo della Chiesa di Arvernia, che consentisse d'essere consecrato senza aspettare la nomina del re Teobaldo (a.554). Lo stesso S. Gregorio racconta (L. VI, c. 7) che Albino successe a Ferreolo nella sede Uceticese extra regis consilium. Morto Albino, narra il medesimo storico che un certo Giovino ricevette il PRECETTO regio di prendersi quell'episcopato, ma essendosi sollecitati a far l'elezione canonica i Vescovi comprovinciali, prevennero Giovino, e diedero la sede al diacono Marcello (Lib. VII,c.31). — Dimandando i cittadini dl Tours al re che loro concedesse a Vescovo Eufonio, che avevano canonicamente eletto, il re rispose: PRAECEPERAM ut Cato Presbyter illic ordinaretur, et cur est spreta JUSSIO NOSTRA?, (Gregor. Touron. L. IV, II, 15). Avendo il re Clotario messo nella Chiesa Santonese per Vescovo Emerito, convenne sopportarlo; ma morto il re Clotario, il metropolitano Leonzio, congregati i Vescovi della provincia, lo depose dall'episcopato come quello che non era canonicamente eletto (anno 562) (Greg. Tour. L. IV, c. 26). Medesimamente i Vescovi dell'Aquitania s'affrettarono a dar la Chicsa di Aqui al prete Faustiniano, a malgrado che il re Childerico avesse destinato quella sede pel conte Nicezio. Perciò Costantino Roncaglia saviamente dice che «avendo giudicato i Vescovi essere di loro dovere l'opporsi all'autorità del re che tentava di largheggiare colle sedi episcopali, è manifesto che que' principi non furono mai nel pacifico possesso di tal potere, che attribuivano a sè stessi nell'elezione de’ Vescovi a loro volontà», e che «la Chiesa non vi ha mai consentito liberamente, quantunque non di rado le sia forza di sopportar molte cose come a pietosa madre, acciocchè non le intervenga di peggio».
(15) Fra l'altre cose egli scrive a Leone Isaurico queste notabili parole: Quemadmodum Pontifex introspiciendi in palatium potestatem non habet ac dignitates regias deferendi: sic neque imperator in Ecclesiam introspiciendi et electiones in Clero peragendi. Epist. II ad Leon. Isaurum.
(16) Can. 3.
(17) Can. 2.
(18) Ep. LXIII.
(19) I Vescovi di Francla in questo tempo non potevano più uscir del regno senza licenza espressa del re; nè un Metropolitano poteva inviare un Vescovo qual suo legato fuori di Stato, come si rileva dalla lettera d'Incmaro di Reims a Papa Adriano scritta nell' 869.
(20) Can. 8. Apostolicis el synodicis canonibus promotiones et consecrationes Episcoporum, et potentia et præceptione principum factas interdicentibus, concordantes, definimus, et sententiam nos quoque proferimus, ut sit quis Episcopus, per versutiam vel tyrannidem principum, hujusmodi dignitatis consecrationem susceperit, deponatur omnimodis, utpote quinon ex voluntate Dei, et ritu ac decreto Ecclesiastico, sed ex voluntate carnalis sensus, ex hominibus, et per homines, Dei donum possidere voluit vel consensit.
Can. 83. Promotiones atque consecrationes Episcoporum, concordans prioribus conciliis, electione ac decreto Episcoporum Collegii fieri, sancta hæc et universalis Synodus definit et statuit atque jure promulgat, neminem laicorum principum vel potentum semet inserere electioni Patriarchæ, vel Metropolitæ, aut cujuslibet Episcopi; ne videlicet inordinata hinc et incongrua fiat confusio vel contentio; præsertim cum nullam in talibus potestatem quemquam potestativorum vel cæterorum laicorum habere conveniat, sed potius silere ac attendere sibi, usquequo regulariter a Collegio ecclesiastico suscipiat finem electio futuri Pontificis. Si vero quis laicorum ad concertandum et cooperandum ab Ecclesia invitatur, licet hujusmodi cum reverentia, si forte voluerit, obtemperare se ascientibus; taliter enim sibi dignum Pastorem regulariter ad Ecclesiæ suæ salutem promoveat. Quisquis autem sæcularium principum et potentum, vel alterius dignitatis laicus, adversus communem et consonantem, atque canonicam electionem ecclesiastici ordinis agere tentaverit, anatema sit, donec obediat ac consentiat quod Ecclesia de electione ac ordinatione proprii Præsulis se velle monstraverit.
(21) Tanto più riescono osservabill questi canoni, dice il Fleury, «quanto che si pubblicavano in presenza dell' imperatore e del senato». Lib. LI, § XLV. Altri canoni furono fatti in questo Concilio in difesa della libertà della Chiesa. I principali sono i seguenti. Can. 21. «Quelli che sono possenti nel mondo rispetteranno i cinque Patriarchi senza intraprendere di toglier loro il possedimento delle sedi, e nulla fare contro l'onore loro dovuto» dal quale si vede come i patriarcati erano presi di mira più che le altre sedi, per l'emolumento e la potenza temporale maggiore che vi era annessa. — Can. 14. «I Vescovi dalle loro Chiese per andar incontro agli strategi, o governatori, discendendo da cavallo, o prostrandosi dinanzi a loro. Deggiono mantenere la necessaria autorità per riprenderli quando occorre». — · Can. 17. «I Patriarchi hanno diritto dl convocare i Metropolitani al loro Concilio, quando stimino a proposito, senza che quelli si possano scusare dicendo che sono ritenuti dal principe». E soggiungono queste parole: «Rigettiam con orrore quel che dicono alcunl ignoranti, che non si possano tener concilj senza la presenza del principe». Così parlano i Concilj ecumenici!
(22) Ecco a ragion d'esempio con qual miscuglio di comando e di preghiera, di sommissione e di autorità, con quale stile di pietà che involge la prepotenza, scrive Luigi ad Adone Arcivescovo di Vienna, per imporgli, o comecchessia muoverlo a far Vescovo di Grenoble un certo Bernario, unicamente perchè era un cherico dell'Imperator Lottario, e perchè questo Imperatore desiderava che fosse fatto Vescovo: «Il nostro amantissimo fratello Lottario, dice, pregò la nostra mansuetudine (mansuetudinem nostram), che a un certo suo cherico per nome Bernario volessimo concedere l'episcopato di Grenoble, il che benignissimamente abbiam falto (quod nos benignissime fecimus)». Ecco la prepotenza di Sua Mansuetudine: prima fa la cosa, e pol umilmente si rivolge alla Chiesa per essa. «Perciò ammoniamo la tua santità (monemus), che se il nostro fratello dolcissimo ti manderà il predetto cherico ad ordinare, tu ubbidisca (obedias) tostamente (mox) alla volontà sua, assicurandoti della nostra concessione che sia ordinato nella Chiesa di Grenoble». Le raccomandazioni di Carlo Il Calvo, e di Luigi III, erano su questo medesimo stile, che contiene più contraddizioni che parole. Talora in raccomandando qualche soggetto, aggiungevano la clausola: «Se ne fosse trovato degno»; lasciandone l'esame al Metropolitano; ma quello che valessero realmente sì fatte clausole, si può giudicare dal fatto del Concilio di Fismes con Luigi III, che poco appresso raccontiamo.
75.
Uno di questi generosi prelati della Chiesa, che in sulla fine del nono secolo difese in Francia con nobilità e rettitudine episcopale la libertà delle elezioni vescovili, fu il celebre arcivescovo di Reims Incmaro. Basterà raccontare qui ciò che gli avvenne col Re Luigi III.
Si teneva il Concilio di Fismes l'anno 881, a cui presiedeva l'arcivescovo Incmaro. Venuta a vacare la sede di Beauvais, per la morte del vescovo Odone, un cherico chiamato Odoacre si presentò al Concilio con decreto di elezione del Clero e popolo di Beauvais ottenuto per favore della Corte. Il Concilio aveva il diritto di esaminare questo cherico, innanzi confirmarlo, od avendol fatto, il trovò indegno. Fu stesa allora una lettera al re, nella quale i Padri esponevano i motivi pe' quali non potevano, secondo i canoni, procedere alla consecrazione di Odoacre, e la si mandò al sovrano con una deputazione di Vescovi. In Corte tosto ne fu grande rumorio: vi si diceva «che quando il re permetteva di fare una elezione, dovea essere eletto quello che voleva egli (1). Che i beni ecclesiastici erano in suo potere, e che li dava a chi gli piaceva (2)». Il re scrisse una lettera ad Incmaro collo stile solito, incerto, contradditorio. Protestavasi di «voler seguire i suoi consigli sì negli affari dello Stato come in quelli della Chiesa, pregandolo di aver per lui la premura stessa che avea avuto per gli altri re suoi predecessori»; poscia aggiungeva, in prova certamente di voler seguire i suoi consigli: «lo vi prego che col vostro assenso e col vostro ministerio io possa dare il vescovato di Beauvais a Odoacre vostro caro figliuolo, e mio fidato servo. Se avete per me questa compiacenza, io onorerò in tutto quelli che avete voi per più cari (3)».
È dunque per una compiacenza verso un uomo, che si può dare al gregge di Cristo un Pastore? Si possono affidare le anime redente dal Sangue dell' Uomo-Dio alle mani non di chi ha santità e prudenza, ma di chi è amato da un potente, è bramato da un re? acciocchè sia arricchito co' beni dell'episcopato? Qual travolgimento d'idee?
Incmaro non mancò al suo dovere: rispose che «nella lettera del Concilio non v'avea cosa che fosse contro il rispetto dovuto al re, nè contro il bene dello Stato, e ch'essa non tendeva ad altro che a mantenere al Metropolitano ed a' Vescovi della provincia il diritto di esaminare e di confirmare le elezioni secondo i canoni». «Che siate voi il signore delle elezioni, aggiunge, e de' beni ecclesiastici, questi sono discorsi usciti dall'inferno e dalla bocca del serpente. Ricordatevi della promessa da voi fatta alla vostra consacrazione, e che fu sottoscritta di vostra mano; e presentata a Dio sopra l'altare dinanzi a' Vescovi; fatela voi rileggere in presenza del vostro consiglio; e non pretendete d'introdurre nella Chiesa quel che i grandi imperatori vostri predecessori non pretesero al loro tempo. Spero di conservarvi sempre la fedeltà e la divozione, che a vol debbo; e non mi diedi poco pensiero per la vostra elezione: non vogliate dunque rendermi mal per bene, col cercar di persuadermi in mia vecchiezza di allontanarmi dalle sante regole che ho seguite, grazie al Signore, sino al presente, pel corso di trentasei anni di vescovado. Quanto alle promesse che voi mi fate, non pretendo di domandarvi nulla, se non per la vostra salvezza, in benefizio de' poveri. Ma vi prego di considerare, che le ordinazioni contro i canoni sono simoniache; e che tutti quelli che ne sono mediatori, sono parte di questa colpa. Io qui non vi ho parlato di mio capo, nè spacciati i pensieri miei. Vi ho riferite le parole di Gesù Cristo, de' suoi Apostoli, e de' suoi Santi, che regnano seco lui nel Cielo. Temete se non le ascoltate! I Vescovi però si raccolgano in Concilio, per procedere ad una regolare elezione col Clero e col popolo di Beauvais, e col vostro consenso».
I Vescovi che parlavano in tal modo ai re la verità, e nol facevano per disprezzo, credevano di dare ad essi la maggior prova del loro fedele e inviolabile attaccamento. Quanto poco ciò si conosce! E da chi avranno speranza i monarchi di udire la verità e la parola divina, se i Vescovi gliela occultano? Ah sappiano dunque discernere l'accento di quella apostolica libertà, che è ben tutt'altro che poco rispetto e divozione! Sappiano apprezzarlo i regnanti cattolici; sappiano, essere un dono inestimabile di Dio l'aver uomini che parlano loro per coscienza, e che per non violarle si fanno incontro alla loro indegnazione e a quella tanto più opprimente de' loro adulatori e servili ministri; nè a qualunque patto voglion tradirli, nè render loro piacenti menzogne; le quali sembrano pur accrescere la loro terrena potenza, ma veramente ne scavano lentamente i fondamenti, e ne preparano la ruina. La Chiesa «colonna e firmamento di verità», fu sempre di questo avviso, che non si dovessero ingannare nè pur quei principi che vogliono essere ingannati, e che puniscono crudelmente chi, non gl'inganna: e questa lealtà della Chiesa sempre amica, è destinata a consolidare i troni, dando loro per appoggio la giustizia e la pietà. E una voce sì fedele, fu tanto male interpretata! tanto male intesa! tanto calunniata da nemici mortali del principato, mascherati da zelanti suoi sostenitori! Sanno questi assai bene, che se il principe dà gli orecchi alle severe parole della Chiesa, essa Chiesa e lo Stato prosperano di comune accordo; e però di nulla sono più solleciti, che di far credere al principe, che la Chiesa detragga sempre a' diritti suoi; e la libertà apostolica de' Papi e de' Vescovi la fan passare per ambizione, e detrazione temeraria della regia dignità.
Sotto tale aspetto appunto fu dipinta agli occhi di Luigi III da' suoi ministri la dignitosa e fedele risposta d'Incmaro: e mentre ella dovea aumentare nel giovane principe la venerazione per l'antico prelato, e la gratitudine, non fece che adontarlo, e condurlo a mortificare il generoso vecchio colla seguente risposta: «Se voi non acconsentite alla elezione di Odoacre, io avrò per cosa certa, che non vogliate voi rendermi il dovuto rispetto (4) nè mantenermi i diritti miei; ma che vogliate in tutto resistere alla mia volontà. Contro un mio pari, farei uso di tutta la mia possanza per mantenere la mia dignità (5); ma contro un mio suddito che vuol deprimerla, mi servirò del mio dispregio. Non si andrà più oltre in questo affare, sin tanto ch'io non ne abbia informato il re mio fratello, ed i re miei cugini; perchè si raccolga un Concilio di tutti i Vescovi de' nostri regni (6), che sanzioneranno conforme alla dignità nostra. Finalmente, se necessità il voglia, faremo dall'altra parte quanto richiederà la ragione».
Se Incmaro avesse operato per ambizione o per interesse, una tale risposta, colla quale si vedea minacciato di perdere la grazia sovrana, l'avrebbe indubitatamente fatto piegare: ma l'uomo che opera per coscienza, non si piega: non è capace il principe di farsi tradire da costui, perocchè la fedeltà, che questi ha verso il principe, è fondata nella fedeltà che ha verso Dio: ella non è una fedeltà d'interesse, ma una fedeltà di dovere. Incmaro in fatti liberamente rispose: e quanto al rimprovero di mancamento di rispetto e di ubbidienza, si contentò di dare una mentita solenne al secretario che scrisse la lettera del re. Circa il resto poi aggiunse: «Rispetto a ciò che dite, che voi farete, se necessità il voglia, quel che richiederà la ragione, veggo lo bene che questo si dice per intimorirmi; ma voi non avete altra possanza, fuor quella che viene dall'alto; e piaccia pure a Dio, per mezzo vostro, o per mezzo di chi gli aggrada, liberarmi da questa prigione; voglio dire da questo corpo vecchio ed infermo, per appellarmi a lui; che desidero di vedere con tutto il cuor mio; non perchè io lo meriti, chè non merito altro che male; ma per sua grazia gratuita. Che s'io peccai acconsentendo alla vostra elezione, contra la volontà e minaccie di molti, prego il Signore che voi me ne diate il castigo in questa vita, affine di non soggiacervi nell'altra. E poichè vi sta tanto a cuore la elezione di Odoacre, mandatemi a dire in qual tempo i Vescovi della Provincia di Reims, con quelli che furono a voi deputati dal Concilio di Fismes, si potranno raccogliere. Io mi ci farò portare, se sarò ancora in vita. Mandate ancora Odoacre, con quelli che l'hanno eletto, sieno essi del palagio o della Chiesa di Beauvais; venite ancor voi, se vi piace: o vengano de' commissarj per voi; e si vedrà se Odoacre sia entrato nell'ovile per la porta. Ma sappia egli; che se non viene, lo manderemo a cercare in qualsiasi luogo si trovi nella provincia di Reims, e sarà da noi giudicato come usurpatore di una Chiesa, per modo che non farà mai più niuna ecclesiastica funzione in niun luogo di questa provincia; e tutti coloro che avranno avuta parte nella sua colpa, saranno scomunicati, sino a tanto che non soddisfacciano alla Chiesa».
Parole così splendide, così degne de' Vescovi de' primi secoli non trattennero la prepotenza: i cortigiani, i quali fanno a gara a cui riesca di parlare parole più lusinghevoli negli orecchi del loro signore, e di mostrarglisi più devoti, trassero Luigi III a impiegare la forza: l'intrusione di Odoacre fu consumata, armata mano: l'infelice Chiesa di Beauvais sostenne questo mercenario; non lo scrisse però nel catalogo de' suoi pastori: un anno dopo, scomunicato per questo ed altri delitti, fu deposto, essendo già Luigi III disceso nel sepolcro a render conto al divino giudice di sua condotta (7).
(2) Si noti la solita confusione d'idee che facevano questi cortigiani. I beni ecclesiastici che non sono che l'accessorio, si fanno il principale; anzi il tutto dell'episcopato!
(3) Hinem. ep. 12, t. II, p. 188.
(4) Dove si fa consistere il rispetto al re! nel commettere delle viltà! nel tradire la Chiesa di Cristo, e le anime da lui compere a prezzo di sangue, per andargli a' versi!
(5) Una dignità che sta nella soperchieria!
(6) Il capricelo o puntiglio di un semplice fedele che incomoda tutti i Vescovi di un regno a congregarsi in concilio, e perchè? per ottener da essi che facciano «una legge non a tenore della giustizia, ma del piacer suo» al quale dà il nome di sua dignità. È strana la speranza di corrompere un Concilio nazionale per vendicarsi della rettitudine di un Concilio provinciale! Ma non abbiamo veduto delle speranze simill produrre gli stessi risultamenti a' nostri giorni? a chi è uscito di mente il Concilio nazionale di Parigi?
(7) Tutti quelli, ai quali il nome di una Providenza che regola le cose umane, suona qualche cosa, e che pur credono che nulla avvenga senza una sapiente dispensazione della medesima, non potranno a meno di riflettere sulla coincidenza della morte di questo giovine principe Luigi III colla ammonizione che gli faceva il prelato di Reims nell'affare del vescovato di Beauvais. Questi, nella lettera che rispose al Re fermo in volere Vescovo Odoacre a dispetto delle leggi canoniche, dice fra l'altre cose: «Che se voi non cambiate quel che faceste di male, Dio lo raddrizzerà quando a lui piacerà. L'imperator Luigi non visse tanto quanto Carlo suo padre, vostro avo Carlo non visse quanto il suo, nè vostro padre quanto il suo. E quando voi siete a Compiégne in loro cambio, abbassate gli occhi; guardate dov'è il padre vostro, e chiedete dov'è sotterrato il vostro avolo; e non v'innalzate dinanzi a colui che è morto per voi, e risuscitato, e che più non muore. Voi partirete presto di qua; ma la Chiesa co' suol Pastori, sotto Gesù Cristo loro Capo, durerà eternamente, secondo la sua promessa». Il Fleury, che non è certamente uno storico credulo, dopo riferite queste parole del degno Arcivescovo, soggiunge: questa minaccia d'Incmaro potea stimarsi per una profezia, quando si vide morire questo giovane re Luigi nel seguente anno». (Lib. LIII, § XXXII).
76.
Ciò che avea reso immensamente più facile l'impresa d'impadronirsi delle elezioni vescovili, tentata assiduamente dalla temporale potenza de' principi, si fu la divisione del popolo dal Clero, avvenuta per le cagioni che ho accennato. Sempre più diviso il popolo da' suoi pastori, e sempre più corrotto, cominciò a meno importargli d'averne di degni. E d'altro lato, essendo cangiate le sedi episcopali in posti di beatitudine temporale, per le dovizie riboccanti e gli onori, e quindi più aspirando ad essi i più avidi, ed ottenendoli i più briganti; era ben facile che il popolo guasto fosse comperato e venduto, e squarciato in partiti, e sommosso in tumulti, e reso fautore, finalmente di indegni che l'adulassero, e nei quali egli amasse e cercasse i proprii sui vizj, anzichè le virtù episcopali: disordini che diedero mesta cagione di escluderlo dalle elezioni intieramente: il che fu fatto prima in Oriente, dove anche prima la potenza laicale padroneggiò le elezioni; e poscia in Occidente: e ciò tolse ai canoni la loro sanzione, che nel popolo principalmente consisteva. Nè fu contento il Clero (assecondandolo in ciò, senza ch'egli se n'avvedesse, la politica de' principi, se non per deliberato consiglio, certo per un cotal suo infallibile istinto) di riserbare a sè solo tutte le elezioni, senza consultare nè contare più per nulla il desiderio della moltitudine de' fedeli; che nel Clero stesso ben presto prevalsero alcuni pochi sopra la grande maggioranza degli ecclesiastici (1), e convertirono in un privilegio del loro ceto la facoltà di eleggere il Vescovo; e questi, che furono i canonici delle cattedrali, riuscirono a far confermare ciò che s'erano arrogato, con leggi della Chiesa. Esclusa pertanto dalle elezioni vescovili la gran massa del popolo, e quella altresì del Clero; il corpo elettorale fu stenuato, senza più alcuna forza da mantenere il diritto di eleggere, contro quelli che se ne volessero insignorire.
Per altro l'avere Incmaro avvertito di ciò Edenulfo, mostra che si rendeva fin d'allora ad alterare questo antico costume. Innocenzo III, sulla fine del secolo XII, in una sua decretale (de caus. possess.et propriet. c. 3) attribuisce il diritto di eleggere ad Cathedratium Ecclesiarum clericos. Il IV Conclllo di Laterano finalmente nel 1215 can. 24-26, restrinse le elezioni ai soli canoniel delle cattedrali.
77.
In questo stato di cose, al tempo de' Papi francesi residenti in Avignone (1), ebbero principalmente luogo le riserve pontificie, le grazie aspettative, e le annate per una conseguenza di quelle: in prima vedute di buon occhio dai principi, e talora da essi richieste, perchè indebolivano via più la sanzione del diritto che ha la Chiesa di eleggersi i pastori (2); giacchè la sanzione che tutela il diritto, conviene che sia tanto forte, quanto il diritto è esteso; e però una persona sola, eziandiochè rivestita di qualsivoglia dignità, non ha forza corrispondente all'estensione del diritto dell'eleggere i Vescovi per tutto il mondo: e però colle riserve universali fu assunta una responsabilità soverchiante le forze, fu intrapreso l'esercizio di un diritto immensamente vasto, alla cui guardia non si poteva mettere una potenza corrispondente: e un diritto senza guardia di altrettanta sanzione è precario, è un diritto perduto. Di qui i lamenti delle nazioni; di qui le umiliazioni de' concordati, co' quali la madre de' fedeli è costretta da figliuoli malcontenti di discendere a patti con essi (3): di qui finalmente quella piaga orribile nel corpo della Chiesa, per la quale, tolte le elezioni antiche, tolte le elezioni del Clero, spogliati i Capitoli del loro diritto, spogliati i Papi delle loro riserve, la nomina de' Vescovi di tutte le nazioni cattoliche cadde nelle sole mani laicali, riservata la conferma (che è ben poca cosa) al Capo della Chiesa; con che fu consumata l'opera della forza vestita al di fuori di benigna pelle, cioè «la servitù della Chiesa sotto tutte le forme della libertà (4). Ma prima di mostrare l'acerbità insofferibile di piaga sì orrenda, prima di parlare di questa finzione di libertà, di questa verità di servitù; io debbo trattenermi ancora ad annoverare le altre cause per le quali le elezioni Vescovili vennero a sì infelice stato, e continuarmi a narrare i combattimenti lunghi de' santi Pontefici e de' Pastori che tanto fecero, tanto sofferirono per impedirne l'avvenimento e mantenere la Chiesa libera di verace libertà, siccome fu costituita eternamente dal divino suo Fondatore.
Bonifacio IX sulla fine di questo secolo XIV estese le annate ai vescovati, e le rese perpetue.
(2) Questa osservazione spiega un fatto, che altremante sembra inesplicabile. Il Concilio di Basilea, sostenuto dalle potestà laicali, annulla le riserve pontificie. Quale fu il vero e l'utimo intendimento della politica de' principi col mettersi dalla parte del Concilio di Basilea? forse di distruggere le riserve? no; ma d'indebolirle per padroneggiarle. La prova di ciò sta nella condotta de' re di Francia a questo proposito. Carlo VII riceve con apparente esultanza i decreti di Basilea, e li dichiara legge dello Stato nell'assemblea di Bourges, dove pubblica la Prammatica sanzione. E che perciò? Questo stesso Carlo VII poco dopo, e i suol successori Luigi XI, e Carlo VIII, pregano il Papa, che si riservi la collazione di certi vescovadi, e li conferisca a tenore delle regie preghiere. Volevano dunque le riserve, ma deboll, ma perchè il Papa facesse di queste il piacer loro: il vero spirito adunque della politica era di abrogare le riserve unicamente per indebolirle, e indebolite, servirsi di esse per eludere le leggi della Chiesa.
(3) Forse mai per lo spazio di XV secoli, fra tante sciagure ch'ebbe, la Chiesa non cadde in tanto avvilimento da esser costretta di venire a sì fatti patti co' fedeli! Tanta umillazione fu dovuta al peccati del Clero: «Se il sale diverrà fatuo, in che si salerà? non vale più a nulla, se non ad esser gittato fuori, e calcato sotto i piedi degli uomini (1) ». Dico ciò, perchè non si può dissimulare che i concordati sieno veri patti, chiamandoli con questo nome gli stessi sommi Pontefici; Nos attendentes, dicc Giulio III, concordata dicta vim PACTI inter partes habere etc. (Constit. 14 sept. 1554 apud Raynald): benchè niun patto tiene quando incomincia a divenire iniquo; nè i patti colla Chiesa si debbono intendere così strettamente, che offendano la plenezza della sua potestà pel bene de' cristianl; la quale, essenzialmente libera, non può essere giammai legata. E queste mie parole non sono già vòlte a condannare i concordatl, ma a deplorare la necessità. Vero è che co' concordati, nè con qualsivoglia convenzione umana, non si può derogare ai dirittl divini e immutabill della Chiesa; chè non si può restringere la sua potestà legislatrice ricevuta da Gesù Cristo, nè diminuire in modo alcuno quella pienezza di autorità per la quale ella può tutto pel bene, e quindi può comandare, può ingiungere ai fedeli senza limite di sorte quanto ella trova necessario ed utile all'eterna loro salute, e all'incremento sopra la terra del Regno di Cristo.
(1) Matth. v. 13.
(4) Quando il gran Pontefice Adriano I scrisse a Carlo Magno (ann. 784) per fargli conoscere che alla potestà laica non apparteneva l'entrare nelle elezioni de' Vescovi, e che dovea lasciarle libere, allora ebbe alle mani il Papa un argomento persuasivo e calzante da fare a Carlo, e questo fu, che nè pur egli, sebbene fosse il Papa, s'ingeriva nelle elezioni, perchè meglio sì rimanessero libere. E di fatti fece uso Adriano di questo argomento: ecco le sue parole: Nunquam nos in qualibet electione invenimus nec invenire huvemus. Sed neque Vestram Excellentiam optamus in talem rem incumbere. Sed qualis a Clero et plebe.... electus canonice fuerit, et nihil sit quod sacro obsit ordini, solita traditione illum ordinamus (Tom. II Conc. Gall. p. 93 e 120). Questo argomento, validissimo da fare a' principi, fu perduto da' Papi, dopo il tempo delle riserve.
78.
Quando i condottieri del Nord guidarono i barbari alla conquista del Mezzodì, essi, dopo la conquista, s'intitolarono re di Francia, d'Italia, d'lnghilterra, cioè delle terre, anzichè de' Franeesi, degl'Italiani, degl'Inglesi, cioè delle persone. Essendo però impossibile ad un solo possessore, per forte che sia, conservare la proprietà della terra di sì vasti tratti di paesi, per la legge accennata, che «la sanzione atta a difendere un diritto, dee rispondere all'estensione del diritto stesso»: que' capitani, re di nuovo genere, inventarono i feudi, come mezzo di conservare a sè la proprietà de' latifondi, cedendone l'usufrutto ad altri, che in tal modo cangiavano in altrettanti custodi fedeli di que' terreni; di cui altramente sarebbero stati pericolosi assalitori, massime quei loro commilitoni, che non avrebber sofferto in pace per alcun modo il non partecipare delle comuni conquiste. Questi beneficati dal re, e chiamati in parte di uno interesse medesimo, furono que' fedeli, da cui derivò poscia il nome di feudi; i quali al re giuravano fedeltà e vassallaggio di servigi determinati, massime del somministrar militi, e militare essi stessi nelle guerre che il re intraprendeva. Finissimo ritrovato per quelle circostanze. In tal guisa que' conquistatori conservarono le proprietà delle terre, asservando ad un tempo le persone coll'esca del dominio utile ad esse ceduto, il quale alla morte di ogni feudatario ricadeva alle mani del re, che ne investiva un altro suo fido, chi meglio gli piacesse (1).
Ora, ben presto s'accorse la politica de' nuovi padroni dell'Europa, che anche meglio che non sia a de' soldati secolari, convenia loro affidare il deposito delle terre da conservare a de' Vescovi e a delle Chiese: il che diede origine a’ feudi, e alle Signorie ecclesiastiche, già fino dal tempo di Clodoveo. Carlo Magno però fu quegli che sopra tutti sentì l'importanza di questo trovato. «Il Magno Carlo», dice Guglielmo di Malmesbury «per fiaccare la ferocia delle nazioni germaniche, avea dato quasi tutte le terre alle Chiese, riflettendo con sommo avvedimento, che gli uomini di un ordine sacro non vorrebbero, così facilmcute come i laici, buttar giù dalle spalle il fedele servigio dell'imperante. Oltracciò, ribellando i laici, gli ecclesiastici potranno frenarli coll'autorità della scomunica, e colla severità del potere (2)».
Cosi grandi liberalità usate da'principi co' Vescovi, erano quello stesso che sono i regali de' clienti ai giudici. Oltre a che, la stessa natura di queste regie munificenze traeva seco quasi necessariamente la servitù della Chiesa. I Vescovi cangiati in altrettanti vassalli, obbligati a prestare il giuramento e l'omaggio di feudalità nelle mani regie (3): consorti del re suoi cointeressati nella grandezza di questa terra, suoi devoti, suoi commilitoni nelle spedizioni e nelle guerre che intraprendere gli piaceva; non era possibile che sentissero più la forza di quel detto dell'Apostolo: «Nessuno che milita sotto il vessillo di Dio, non s'implica in negozj secolareschi (4)»; nè che non s'avvezzassero a riguardare nel loro re unicamente il loro Signore temporale, e in se stessi de' servi suoi, partecipanti per grazia sua le sue ricchezze e il suo potere; dimenticandosi ad un tempo, che quel loro re era pur insieme un semplice laico, un figlio della Chiesa, una pecora del loro ovile, e ch'essi erano vescovi messi dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio. Non era possibile in una parola, che essendo divenuti uomini del re (5), avessero egualmente presente di essere uomini di Dio; imperciocchè «nessuno può servire a due padroni (6)».
(2) De gestis regum Anglorum, Lib. V Carolus Magnus pro contundenda gentium illarum (germanicarum) ferocia, omnes pene terras Ecclesiis contulerat, consiliosissime perpendens, nolle Sacri Ordinis homines tam facile quam laicos fidelitatem domino rejicere. Præterea, si laici rebellarent, illos posse excommunicationis auctoritate et potentiæ severitate compescere.
(3) E non si restò qui; perocchè dove mai si resta? Il giuramento che si esigeva da' Vescovi come feudatarj, poi si esigette da' Vescovi come Vescovi, per extensionem direbbero i legali, e con questa clausola crederebbero di aver giustificata l'usurpazione. La Chiesa non tacque; e proibì di prestare il giuramento a que' Vescovi che non avevano ricevuta dal principe cosa temporale. Fu pubblicato di ciò solenne decreto da Innocenzo III, nel Concilio IV di Laterano, can. 43, che dice così: Nimis de JURE DIVINO quidam laici usurpare conantur, cum viros Ecclesiasticos, nihil temporale detinentes ab eis, ad præstandum sibi fidelitatis juramenta compellunt. Quia vero, secundum Apostulum, servus suo domino stat aut cadit, sacri auctoritate Concilii prohibemus, ne tales Clerici personis sæcularibus præstare cogantur hujusmodi juramenta.
(4) 2 Timoth. II, 4.
(5) Quegli che era investito dei feudo dal re, chiamavasi homo regis. Non si può trovare una maniera di dire che più esprima l'assoluta padronanza del re su quest'uomo, divenuto come regia proprietà. Quale pensiero strano non sarebbe l'immaginare un S. Pletro, un S. Paolo, o un Grisostomo, un Ambrogio da homo Dei fatto homo regis! E la parola homo era divenuta un sinonimo di soldato a quei tempi, come si può vedere nel Du-Cange Gloss. med. et infim. latinit. Voc. Miles.
(6) Matt. VI, 24.
79.
Effetto delle cose temporali usate ad un fine temporale è pur troppo, quello di accecare gli uomini; e tutta la possanza della Chiesa, tutta l'ecclesiastica libertà appartiene ad un ordine di cose spirituale e invisibile. Qual maraviglia pertanto, se venendo annesso alla potestà ed all'uffizio spirituale dell'episcopato, una grande potestà esterna e sensibile, un ufficio temporale e materiale; i Vescovi, uomini anch'essi, si restassero, attrettanto che i principi, accecati e occupati da questo accessorio, e in questo riponessero ben presto il nerbo principale della loro episcopale dignità; che, con questo poter temporale ricevuto dal prineipe mescolassero e confondessero il potere spirituale ricevuto da Cristo; che questo potere invisibile col temporale mescolato e confuso, svanisse per così dire, e si perdesse dalla loro veduta; quindi che si chiamasse episcopato il beneficio annesso; non intendendosi più possibile una divisione dell'episcopale officio dal temporale beneficio, nè come sussistere potesse quello senza di questo? Di vero le frasi correnti nello stile di quella età, depositarie delle comuni opinioni, provano manifestamente ciò che io dico; esse fondono ogni cosa insieme; in vece di dire che il re dona i beni temporali annessi alla sede episcopale, dicono che «dona, conferisce l'episcopato, conferisce la dignità episcopale, comanda, precetta che il tale sia Vescovo, per ordinazione del re il tale viene ordinato ecc. (1)».
Ripeto, che queste maniere di dire non valevano, al tempo nel quale furono inventate, tutto ciò che significano: ma esse però predicevano ciò che un tempo avrebber valuto. Avviene appunto così: prima s'inventano delle frasi, e per qualche tempo corrono senza valore, e sono altrettante deboli condiscendenze che fa la verità alle passioni, altrettante menzogne. Dietro le frasi però non tardano le cose; conciossiachè v'ha una legge che spinge gli uomini a dire la verità, e che quindi li porta a realizzare le parole che proferiscono eziandiochè vanamente. Di che le maniere correnti del parlare di una nazione preaccennano il cammino ch'essa sta prendendo, a chi sa vedere il fondo delle umane viccnde; e nelle maniere di esprimersi questi legge le tendenze de' popoli, e profetizza a che vogliano riuscire i loro avviamenti. Quella identificazione de' benefizj temporali colla dignità episcopale nell'uso del parlare, quell'attribuire al potere laicale la distribuzione delle pontificali dignità a quel modo che si distribuiscono i doni dipendenti di lor natura dall'arbitrio del donatore, chiaramente indicava l'adulazione, la corruzione del Clero, vôlto già alla bassa servitù de' principi secolari, preferendo le ricchezze del secolo alla libertà di Cristo; e ne' principi appariva la tendenza infaticabile di invader tutto, di conquistare la Chiesa come aveano conquistato il suolo: tendenza che poteva per qualche tempo sostenersi senza il suo naturale sviluppamento, per la pietà personale di alcuni; ma che doveva poi coll'ajuto del tempo indubitatamente cadere là dove gravitava, e maturare il frutto di cui portava il germe.
Così veggiamo che da principio, tolti alcuni atti arbitrarj nelle elezioni, que' re riconoscevano però nella Chiesa il diritto di scegliere i proprj Pastori; e anche allorquando conferivano di loro arbitrio le sedie episcopali, solevano farlo con parole che temperassero la stranezza di quella loro ingiustizia, e che spirassero una cotale pietà, cauti di non offendere di un tratto l'opinione de' Prelati e de' popoli, ancora rigida, ancora fermata sulla norma de' canoni e della verità, non resa bastevolmente flessibile e cortigiana (2).
La pietà, la rettitudine e la politica di Carlo Magno andò più innanzi, e restituì alla Chiesa anche quella parte di libertà che era stata violata da' re della stirpe di Merovingi: e Lodovico il Pio imitò l'esempio del suo magnanimo genitore (3).
Ma non così i re che vennero appresso.
(2) Ecco come era temperato il Præceptum de Episcopatu de' Re franchi, secondo la formola conservataci da Marcolfo: Cognovimus Antistitem illum ab hac luce migrasse, ob cujus successorem sollicitudinem congruam una cum Pontificibus (vel proceribus nostris) plenius tractantes, DECREVIMUS illustri viro illi Pontificatem in ipsa urbe committere dignitatem.
(3) Il Sommo Pontefice Adriano I aveva ammonito Carlo Magno del suo obbligo di lasciar libere le elezioni de' Vescovi; e questo grand'uomo ricevette l'ammonimento del Capo della Chiesa con quella docilità che mostra assai più grandezza d'animo ne’ sommi principi cristiani, che non sieno le loro resistenze e disubbidienze. Anzi ne' suoi capitolari di Aquisgrana dell'anno 803, cap. II, dichiarò e sancì questa libertà col seguente Decreto: «Non essendo noi ignari de' sacri Canoni, abbiamo prestato il nostro assenso all'ordine ecelesiastico (acciocchè la Santa Chiesa stia più sicuramente nel possesso dell'onor suo) di questo, che i Vescovi sieno eletti della propria Diocesi, con elezione di Clero e di popolo, a tenore degli statuti de' canoni, rimossa ogni accettazione di persone e di regali, pel merito della propria vita, e pel dono della sapienza; a fine che possano per ogni verso giovare a' loro sudditi coll'esempio e colla parola». Nell'anno 806, Lodovico Il Pio confermò la legge di Carlo Magno nel Capitolare pubblicato dopo Il Sinodo di Aquisgrana.
80.
Che i feudi alla morte di ciascun Vescovo ricadessero nelle mani del re, e che il re in sede vacante ne godesse il frutto, ciò che si chiamò la regalia, questo era comportabile, perchè nasceva dalla natura stessa de' feudi; ma non si restarono qui. Per avidità di percepire questi redditi, i principi tennero le Chiese lungamente prive de' loro pastori (1); impedendone le elezioni, esigendo che elegger Vescovo non si potesse senza il regio permesso (2), e facendo per tal modo dipendere il Vangelo e la salute dell'anime dal volere del re, dal suo capriccio, e soprattutto dalla sua cupidigia. E perchè i semplici Sacerdoti godevano anch'essi de' redditi della Chiesa, fu comandato che la Chiesa di Dio non avesse da quell'ora più il diritto di ordinarsi nè manco un minimo suo prete, se non per grazia e concessione sovrana (3)!
(2) La Chiesa mostrò sempre ripugnanza a tale dipendenza; e la lotta fra la Chiesa che vuole operare liberamente, e il potere secolare che vuol sottometterla a sè, è continua nella Storla. Quindi spesso accadevano contrasti per elezioni fatte senza averne prima ottenuto il permesso del re. Riccardo I (circa l'anno 1190), in una lettera al Vescovo di Londra, si lamenta altamente di un'elezione fatta senza aver lui prima consultato: Quod si ita est, regiam majestatem nostram non modicum est offensam; e dichlara: Nou enim aliqua ratione sustineremus quod a præfatis monachis vel ab aliis quidquam cum detrimento honoris nostri in electione Episcopi fieret: et si forte factum esset, quin in irritum revocaretur. Ma i progressi che al tempo di Riccardo avea fatto la potestà laicale nell'invasione dei diritti della Chiesa e nell'oppressione della sua libertà, erano incredibili; e rendevano la resistenza dalla parte della Chiesa sempre più debole; e la Chiesa sarebbe perita, se Iddio, che veglia alla sua conservazione, non avesse suscitato de' Papl d'una fortezza e di una magnanimità sopraumana, che di nuovo la francassero. Che avrebbe detto la Chiesa ne' suoi più bel giorni, se dei principl secolari avessero preteso che per eleggere i proprj Pastori ella avesse dovuto dipender da essi, e ad ogni nuova elezione di Vescovo impetrar la grazia di poterla fare? Che avrebbero detto gli Ambrosii o i Grisostomi a sentire che il figlio della Chiesa vuole legar le mani a sua madre, e non lasciarla operare se non a quella guisa che una schiava è lasciata operare dal beneplacito del suo padrone? Con che nobile e santa fierezza non avrebbero risposto a simili prepotenze, sostenendo i sacri diritti della sposa di Cristo? Ancora nel sec. X, e nello stesso Oriente la Chiesa mostrava di sentire tutta l'indegnità di una simile oppressione a cui la si traeva, Cedreno racconta, che Niceforo Foca avea vietato di fare elezione di Vescovi senza il suo permesso; e sebbene quell'imperatore si fosse macchiato di molti delitti, tuttavia lo storico mette questa legge, colla quale facea dipendere le elezioni de' pastori della Chiesa dalla sua volontà, per la massima di tutte le sue scelleratezze: Id omnium gravissimum, dice, quod legem tulit, cui et EPISCOPI QUIDAM LEVES ATQUE ADULATORES (ecco dove sta la radice del male!) SUBSCRIPSERUNT, ne absque imperatoris sententiâ ac permissu Episcopus vel eligeretur vel ordinaretur. Essendo poi succeduto a Foca Giovanni Tzimiscem, il Patriarca che allora governava la Chiesa di Costantinopoli, Polieutte, con sacerdotale petto, ricusò di ammetterlo nella Chiesa co' fedeli, e di coronarlo, se prima non soddisfaceva pe' suoi delitti, e particolarmente non abrogasse la legge di Niceforo, distruttrice della ecclesiastica libertà; il che fece l'imperatore, lacerando quella legge alla vista di tutto il popolo (Cedren. ad ann. 969).
(3) Fra le formole di Marcolfo (19) vi è appunto quella intitolata Præceptum de Clericatu, la quale è la licenza necessaria che distribuiva il re a chi voleva rendersi cherico. Si chiama poi precetto, perchè tutto quello che esce dalla bocca regia dee essere un precetto, la solita menzogna dell'adulazione. Se io fossi da tanto da poter consigliare i principi, suggerirei loro di bandire tutta la falsità dal frasario della Corte, e di piantare la loro potenza sul solido DELLA VERITA'. Con questo solo, quanto i loro troni si renderebbero più fermi e più augusti! Ma chi non sogghigna a queste parole? Per altro i Vescovi talora ordinavano de' cherici senza badare alla regia concessione. Fra le lettere di Gerberto ve n'ha una di un Arcivescovo di Reims (Ep. 57), colla quale dice «di esser tassato di delitto nella maestà del re per avere conferito i gradi ecclesiastici senza l'autorità e licenza di lui».
I Re di Francia pure volevano che dipendesse da loro il potersi i fedeli cristiani ritirar dal mondo e consacrarsi a Dio nelle religioni. Incmaro però, in una lettera a Carlo di Calvo, dice espressamente a quel monarca che una tal legge non fu mai ricevuta dalla Chiesa. Questa lettera è pubblicata dal P. Cellotti col Concilio Duziacese.
81.
Di più: gli uomini di legge, che sono nelle Corti quello che i sofisti demagoghi sono in un popolo pervenuto alla corruzione, trovarono questo singolare argomento: «Il principale tira seco l'accessorio; ma i feudi fra i beni della Chiesa sono il principale; dunque anche tutti i beni della Chiesa devono prendere la condizione de' feudi, e restar soggetti alla stessa legislazione (1)». Con questa singolare argomentazione tutti i beni della Chiesa ebbero l'alto onore di esser considerati come enti nobili, come beni di prim'ordine, e perciò beni in qualche modo regi (2). Indi il re pretese non più sui soli feudi, ma su tutti i beni ecclesiastici indistintamente que' diritti che aveva sui feudi: volle aver da tutti la regalia, cioè i frutti de' benefizj (3) vacanti, che alla morte del beneficiato dovean ricadere nelle mani del principe, il quale poi molte volte ne disponeva a suo buon piacimento come di cosa al tutto propria (4). Talora si diede la forma stessa di feudi ai beni ecclesiastici liberi. Cosi furono infeudate le decime (5); e facendosi de' passi sempre più innanzi, per questa via si attribuirono queste decime o altri beni liberi infeudati in beneficio ai laici, come si faceva talora dei veri feudi alla morte de' Vescovi o degli Abati (6); e perchè si considerava indivisa la dignità spirituale col beneficio temporale, toccava a vedersi de' laici, e per lo più de' soldati, comandare nelle Abbazie in mezzo a monaci come abati, e negli episcopj in mezzo a cherici come Vescovi (7).
(2) Questi avevano, si dice, una protezione e difesa maggiore: ma il potere civile non è istituito per difendere tutte le proprietà egualmente?
(3) Il nome di benefizj, che si ritiene ancora universalmente nella Chiesa, trae l'origine de' benefizj prima militari, e poi anco ecclesiastici, che assegnavano i monarchi delle nuove sovranità del medio evo. Rammenta quel nome la vendita che il Clero fece della sua libertà al principe, cambiandola colle ricchezze.
(4) La Chiesa non ha taciuto: ha cercato difendersi contro sì fatte usurpazioni. Ma che opporre alle armi? Ella non avea che la ragione, l'autorità, i canoni. Eccone alcuni:
Il grande concilio ecumenico di Calcedonla già fino dall'anno 451 avea formato questo canone: Redditus vero viduatæ Ecclesiæ integros reservari apud æconomum ejusdem Ecclesiæ placuit.
Il Concilio Regiense dell'anno 493 can. 6 così decreta: Stabili definitione consultum est, ut de cætero observaretur, ne quis ad eam Ecclesiam, quæ Episcopum perdidisset, nisi vicinæ Ecclesiæ Episcopus exequiarum tempore accederet, qui visitatoris vice tamen ipsius curam districtissime gereret, ne quid ante ordinationem discordantium in novitatibus Clericorum subversioni liceret. Itaque cum tale aliquid accidit, vicinis vicinarum Ecclesiarum inspectio, recensio, descriptioque mandatur.
Ne' Concilj di Spagna Valentino e Ilerdese degli anni 524, 523, si ripete la disciplina stabilita nel concilio di Calcedonia.
Nel concilio II d'Orleans dell'anno 533, c. 6, si decreta che, morto il Vescovo di una Diocesi, il suo vicino venendo a fargli i funerali, ragunì i Sacerdoti, faccia un esatto inventario delle cose di quella Chiesa, e n'affidi la custodia a persone diligenti e sicure, come nel concilio Regiense.
Il Concilio V di Parigi dell'anno 614, can. 7, decreta, che nessuno tocchi i beni di un Vescovo o d'un cherico qualsiasi che muoja, nè pure se v'interviene regio precetto, e ciò sotto pena di scomunica, e vuole che ab Archidiacono vel Clero in omnibus defensentur et conserventur.
Il celebre Inemaro Arcivescovo di Reims così scriveva nel secolo IX a' Vescovi e principali della sua provincia (ep.IX): Et sicut Episcopus et suas et ecclesiasticas facultates sub debita discretione in vita sua dispensandi habet potestatem, ita facultates Ecclesiæ viduatæ post mortem Episcopi penes æconomum integræ conservari jubentur futuro successori ejus Episcopo; quoniam res et facultates ecclesiastica NON IMPERATORUM ATQUE REGUM POTESTATE SUNT ad dispensandum vel invadendum, sive diripiendum, sed ad defensandum atque tuendum. Le stesse cose questo celebre Vescovo scrive direttamente al re Carlo il Calvo, ep. XXIX; e lo stesso ripete in diverse sue lettere, come nella XXI, e XLV.
Un altro celebre arcivescovo di Reims, cioè Gerberto, quegli stesso che fu poi sommo Pontefice col nome di Silvestro II, stabilisce la stessa dottrina nella sua lettera 118 diretta al Clero ed al popolo.
Essendo queste leggi tanto ripetute e inculcate nella Chiesa, non potevano i principi fino al secolo IX manomettere le facoltà della chiesa senza incorrere nella pubblica disapprovazione: quindi gli Annall Bertiniani, in ragion d'esempio, all'anno 882 non mancano di notare come un delitto dell'imperatore Carlo il Grasso, l'aver dato a consumare ad Ugone figliuolo di Lottario il juniore le facoltà della Chiesa di Metz, quas sacri Canones, dicono, futuro Episcopo reservari præcipinat.
(5) Che le decime sieno state usurpate da laici, e tenute in feudo, e sieno state concesse in feudo da principi, come pure da Vescovi e rettori di Chiese, è cosa nota, ed apparisce dal corpo del jus canonico. Vedi l'Estravagante de Decmn. cap. 23, e l'Estravagante de iis quæ fiunt a Prælat, sine consensu capit. 17.
(6) Chi vuol vedere degli esempj di ciò che dico, consulti la Storia di Nat. Alessandro, sec. XIII e XIV, Dissert. VIII, art. III.
(7) Il Concilio dl Meaux dell'anno 843, non mancò di parlare con apostolica libertà al re Carlo il Calvo, che esercitava nella Chiesa un simigliante dispotismo, accordando i beni della Chiesa a' lalci, «di che avveniva che contro ogni autorità, contro i decreti de' Padri, è la consuetudine di tutta la cristiana religione, i laici risiedessero come padroni e maestri ne' monasteri regolari in mezzo de' Sacerdoti e de' Leviti e d'altri religiosi, e che, come fossero Abati; decidcssero della loro vita e conversazione, e li giudicassero, e che dispensassero loro e commettessero secondo la regola, le cure delle anime e i divini tabernacoli non solo senza a la presenza, ma ben anco senza la consapevolezza del Vescovo». Ved. I can. 10 e 42 del citato Concilio. E perciò que' Padri decretano ut præcepta illicita jure beneficiario de rebus ecclesiasticis facta a Vobis (parlano al re Carlo di Calvo) sine dilatione rescindantur, et ut de cætero ne fiant, a dignitate Vestri nominis regii cavcatur (can. 8); e gli mettono sott'occhio con forza l'indegnità dello straziare la vesta di Cristo, ciò che non hanno fatto nè pure i soldatl che l'hanno crocifisso: Ante oculos reducentes tunicam Christi, qui vos elegit et exallavit, quam nec milites ausi fuerunt scindere, tempore vestro quantocitius reconsuite et resarcite: et nec violenta ablatione, nec illicitorum præceptorum confirmatione res ab Ecclesiis vobis ad tuendum et defensandum ac propagandum commissis auferre tentate; sed ut sanctæ memoriæ avus et pater vester eas gubernandas vobis, fautore Deo, dimiserunt, redintegrate, præcepta regalia earumdem Ecclesiarum conservate et confirmate. Can. II.
È osservabile in questo Concilio, che si distinguono i beni dati alla Chiesa come Allodj e liberi, da quelli dati in Feudi; e sì riprende il re principalmente per la dispensazione a' laici de' primi.
82.
Il Clero in tale oppressione ogni giorno più perdea la coscienza della sua dignità, della sua libertà; e si stimava compensato di tali perdite, di cui non conosceva più il prezzo, coll'aumento delle ricchezze e del potere temporale (1).
Non già, che sia mai mancata nella Chiesa una voce solenne che s'innalzasse dal profondo dell'umiliazione per dire ancora la verità. Questa non sarà mai taciuta al mondo: perocchè la Chiesa immortale non sarebbe più, da quell'istante che cessasse dall'annunziarla. Ma era come una voce solitaria, erano come de' lamenti e de' gemiti che s'ascoltano qua e colà uscire in mezzo a funerea campagna.
Io mi contenterò di riferire un passo di Floro, Diacono di Lione, che in questo secolo X, in cui le elezioni de' Vescovi erano venute a sì mal partito, e la loro libertà quasi del tutto perita, tolse a scrivere un libro appunto «sull' elezione dei Vescovi», per far sentire quale questa dovea essere, secondo le sante leggi della Chiesa, e per confutare quella opinione che già cominciava a prender piede nella corte, introducendosi insensibilmente, come un punto di diritto, «che fosse necessaria la volontà del re, perchè l'elezione del Vescovo fosse legittima e rata».
Comincia dall'esporre nettamente la dottrina vera intorno alle ordinazioni episcopali, cosi dicendo: «È manifesto a tutti quelli che amministrano nella Chiesa di Dio l'uffizio sacerdotale, doversi osservare tutte quelle cose che l'autorità de' Sacri Canoni, e la consuetudine ecclesiastica comanda SECONDO LA DISPOSIZIONE DELLA DIVINA LEGGE E LA TRADIZIONE APOSTOLICA intorno all'ordinazione de' Vescovi, cioè che, defunto il pastore, e resa la sede vacante, uno del Clero di quella, quegli che un comune e concorde consentimento del medesimo clero e di tutta la plebe avrà eletto, e con pubblico decreto designato notoriamente e solennemente, e che sarà consecrato da un legittimo numero di Vescovi, debba giustamente ottenere il luogo del pontefice mancato; non dubitandosi punto, che non debba esser cosa firmata dal giudizio e dispensazione divina ciò che fu celebrato con tant'ordine e legittima osservanza dalla Chiesa di Dio. Tali sono le cose che si rinvengono stabilite ne' Concilj de' Padri, e ne' decreti de' Pontefici della Sede apostolica, e dalla Chiesa di Cristo comprovati fin da principio».
In prova di questa dottrina reca le parole di S. Cipriano, che in una lettera ad Antoniano, parlando dell'elezione di S. Cornelio, scrivea così: «Il Vescovo formarsi dal giudizio di Dio e del suo Cristo, dal testimonio di tutti i cherici, dal suffragio della plebe, e dal consenso degli antichi Sacerdoti, e degli ottimi (bonorum vivorum)».
Dopo di che in tal modo soggiunge: «Secondo queste parole del beato Cipriano apparisce, che dal tempo degli Apostoli, ed appresso per anni quasi quattrocento, tutti i Vescovi delle Chiese di Dio sono stati ordinati, ed hanno legittimamente governato il popolo cristiano, senza alcun consulto della umana potestà. Quando poi cominciarono i principi ad esser cristiani, un manifesto argomento basta a convincerci, che, universalmente parlando, si mantenne nelle ordinazioni de' Vescovi la libertà della Chiesa. Perocchè non era possibile che tenendo la monarchia di tutto il mondo un solo imperatore, questi potesse conoscere e scegliere tutti i Vescovi che si doveano ordinare in tutte le vastissime parti della terra, in Asia, Europa ed Africa. E tuttavia fu sempre compiuta e valida l'ordinazione che celebrò la santa Chiesa giusta la tradizione degli Apostoli, e la forma di una religiosa osservanza. Che poi in alcuni regni sia invalsa la consuetudine, che l'ordinazione episcopale si faccia consultando il principe; ciò vale ad aumento di fraternità, per aver pace e concordia col mondano potere; ma non a render più vera o autorevole la sacra ordinazione: la quale non già mediante la regia potenza, ma si bene solo col cenno di Dio, e col consenso de' fedeli della Chiesa si può conferire a chicchessia. Conciossiachè l'episcopato non è un ufficio umano, ma un dono dello Spirito Santo... Di che avviene che il principe gravemente pecca se stima poter darsi per suo benefizio quello che solo la divina grazia dispensa: quando il ministero della sua potestà in tale negozio dee venir dietro aggiungendosi, non andare innanzi preferendosi (2)».
(2) — Cum ministerium suæ potestatis in hujusmodi negotium peragendo adjungere debeat, non præferre. Questa è la vera idea di ciò che possono fare i principi in favore della Chiesa, non costituirsi legislatori, ma dar mano perchè le leggi e disposizioni della Chiesa sieno, secondo il volere della Chiesa, e non altramente eseguite.
83.
Ma conviene confessare, che il potere laicale con una perseveranza di tanti secoli nella costante tendenza di asservare la Chiesa, mediante un'alternativa di benefizj e di soperchierie era arrivato finalmente tanto innanzi, che non poteva più: la conquista era compiuta: la Chiesa stessa sembrava stanca in questo decimo secolo di gridare e di protestare inutilmente contro alle usurpazioni, parea che non trovasse più nè voce nè fiato, o che fosse come divenuta rauca; sì debolmente e di rado parlava.
Noi siamo al più infausto de' secoli. Il Clero fuori della sua via, accecato da' beni temporali, e per poco assuefatto a mercanteggiare la dignità e la coscienza: s'aggiunse una notabile circostanza, valida ad ajutare la ecclesiastica servitù, cioè la potenza di Ottone I, che umiliò i grandi signori, e rese più forte e assoluto il potere monarchico: grande beneficio alla società, se il potere monarchico non fosse stato istradato nella via dell'usurpazione de' diritti della Chiesa. Con tale precedenza, con viziosa consuetudine, ogni accrescimento di sua forza non era che un accrescimento della stessa usurpazione (1).
Nel principio del secolo XI si trovò dunque la libertà delle elezioni intieramente perita.
Dell'Inghilterra l'Abate Ingolfo contemporaneo in Guglielmo il conquistatore dice così:
«Da troppi anni a questa parte non si fa più alcuna elezione di prelati meramente libera e canonica; ma tutte le dignità tanto di Vescovi come di Abbati, la regia corte le confcrisce coll'anello e il bastone a suo bel piaccre» (2).
Della Francia nel tempo di Filippo I così il Papa si lamentava con Procleo vescovo di Chalon:
«Fra gli altri principi di questo nostro tempo, che con perversa cupidigia mercanteggiando hanno del tutto conculcata la loro madre; abbiamo di sicura relazione saputo, che Filippo re de' Franchi ebbe sì fattamente oppresse le Chiese gallicane, che sembra esser già pervenuto all'estremo suo punto il soperchio di sì detestabile tentativo. La qual cosa noi la portiamo in vero con tanto maggior cordoglio in quel reame, quanto che si sa come esso altre volte fu e per prudenza, e per religione, e per forze più potente ad un tempo e verso la romana Chiesa molto più devoto» (3).
Della Germania ecco quello che dice S. Anselmo, Vescovo di Lucca, scrittore contemporaneo:
«Il tuo re rivolge il discorso all' antipapa Guiberto» vende di continuo i vescovati, pubblicando editti che non s'abbia d'aver per Vescovo quegli che è eletto dal Clero, o dimandato dal popolo, se non antiviene il regio volere, quasi che egli sia il portinajo di questa porta della quale la verità disse: A costui il portinajo apre! — «Voi squarciate le membra della Chiesa cattolica che avete invasa per tutto il regno, e cui, ridotta in servitù, tenete in vostra balia siccome vile schiava; e date di piglio alla libertà della legge di Dio col vile ossequio che rendete all'imperatore, dicendo: tutte le cose essere soggette al diritto imperiale, i Vescovati, le abbazie, tutte le Chiese senza esclusione alcuna; quando il Signore dice: La mia Chiesa, la colomba mia, le mie pecore. E Paolo: Nessuno prende da se stesso la dignità se non è chiamato da Dio come Aronne» (4).
(2) A multis annis retroactis nulla electio Prælatorum erat mere libera et canonica; sed omnes dignitates tam Episcoporum quam Abbatum per annulum et baculum regis Curia pro sua complacentia conferebat.
(3) Inter cæteros nostri hujus temporis principes, qui Ecclesiam Dei perversa cupiditate venumdando dissipaverunt, et matrem suam ancillari subjectione penitus conculcarunt, Philippum regem Francorum Gallicanas Ecclesias in tantum oppressisse certa relatione didicimus, ut ad summum tam detestandi hujus facinoris cumulum pervenisse videatur. Quam rem de regno illo tanto profecto tulimus molestins, quanto et prudentia et religione et viribus noscitur fuisse potentins, et erga Romanam Ecclesiam multo devotius. Ep. 35.
(4) Tali opinioni spacciarono gli adulatori dell'imperatore; e il santo Vescovo di Lucca tolse a ribatterle con un'opera apposita, nobile e franca, ove si sente tutto il linguaggio dell'antichità, che, come ho tante volte detto, non è mai al tutto mancato nella santa Chiesa. Ecco l'argomento del libro II, ch'egli stesso spone nell'esordio con queste parole: Opitulante Domini nostri elementia, qui nos et sermones nostros suo mirabili nutu regit atque disponit, acciugimur respondere his qui dicunt, regali potestati Christi Ecclesiam subjacere, ut ei pro suo libito, vel prece, vel pretio, vel gratis, liceat Pastores imponere, ejusque possesiones vel in sua vel in cujus libuerit jura transferri: e questa risposta che fa il santo Vescovo è piena di erudizione e di forza.
84.
Ma in cotesti tempi tanto infelici, ne' quali la Chiesa di Dio sembra irreparabilmente perire, Cristo suol ricordarsi della sua parola, si risveglia, e suscita qualche uomo straordinario, che con una immensa potenza morale, e certamente non umana, tutto affronta, a tutto resiste, e che a tutto riman superiore; rivendica la Chiesa, la ristora dalle sue perdite; e quasi direi ringiovinisce il regno dell'Eterno sopra la terra. Ognuno ha già compreso quali sia il Mandato di Dio nel tempo di cui parliamo: ognuno s'accorge che noi abbiamo descritto Gregorio VII.
Quest'uomo per sempre memorabile ascese sulla Cattedra di Pietro l'anno 1073. Già al suo predecessore erano state portate le accuse non meno della dissolutezza sfrenata e della tirannide inaudita verso i cristiani suoi sudditi: che dello strazio che faceva della Chiesa Enrico IV; ma S. Alessandro II, prevenuto dalla morte, non avea potuto por la mano entro la piaga profonda e mortale del corpo di Cristo (1). Era riserbato dalla Providenza all'umile monaco Ildebrando il durissimo ufficio di adoperare, dopo i dolci fomenti e lenitivi, altresì il ferro che con taglio ardito e maestro sanasse l'invecchiata cancrena (2). Questi avea ricusato il pontificato: accettato poi per coscienza di non opporsi al volere divino, vide sì tetri essere i tempi, che volendo un Papa adempire i proprj doveri, dovea rimanerne vittima. S'infiammò quindi d'uno spirito di sacrifizio, e mostrò tosto al mondo di avere quel sublime concetto dell'episcopato che aveano i Vescovi primi della Chiesa, scrivendo a' suoi confratelli «Noi considerando, e pel breve termine di questa vita, e per la frivola qualità de' comodi temporali, che niuno può ricever meglio questo nome di Vescovo, che allorquando patisce persecuzione per la giustizia, abbiamo decretato d'incorrere più tosto le inimicizie degli iniqui ubbidendo ai divini comandamenti, che turpemente, a quelli piacendo, provocare l'ira del cielo» (3).
(2) Non sono mai senza interesse le parole de' contemporanei. Però mi do cura di giustificar tutto ciò che dico, co' loro testimonj, in una materia massime così alterata e confusa dagli storici di partito. Ecco come Mariano Scoto (in Cronico ad an. 1076) racconta quest'avvenimento: «Egli non temette (parla dell'imperatore Enrico), per quanto fu in lui, d'insozzare e d'offuscare l'unica e difetta Sposa dei Signore per mezzo de' concubinarj, cioè degli eretici, rendendo venali, ad esempio di Simone, gli spirituali ufficj della Chiesa, gratuiti doni dello Spirito Santo, con iniqui a contratti e contrarj alla cattolica fede. Or de' personaggi costituiti nella Chiesa a quel tempo, vedendo e udendo queste ed altre simiglianti scelleratezze del re Enrico, nefande ed inaudite, zelando il zelo di Dio per la casa d'Israele come il Profeta Elia, gemendo e dolendosi e con lettere e a viva voce, mandati de' a nuuzj a Roma, si lagnarono presso Alessandro vescovo della Sede Apostolica e di queste e d'altre cose senza numero che nel regno teutonico erano dette e fatte dagl'insani eretici simoniaci, autore e patrono di tutte il re Enrico. — Intanto venuto a mancare il Signore Apostolico Alessandro, prese a governare l'Apostolica sede Gregorio, detto anche Ildebrando, di professione monaco. Que sti, udite le querimonie e i giusti clamori de' cattolici contro il re Enrico e l'immanità delle sue scelleratezze, acceso del zelo di Dio, pronunciò il detto re già scomunicato principalmente per la colpa della simonia». Gli scrittori contemporanei sono d'accordo nel dipingere Enrico come dato ad ogni sorte di sfrenatezza, sì relativamente a' costumi privati, come alla tirannide verso i sudditi, e l'empietà sfrontata verso la Chiesa. Ed egli però trova il patrocinio degli scrittori del passato secolo! E Gregorio, il giusto e magnanimo Gregorio, che espone la sua quiete e la sua vita per raffrenare un bestiale tiranno, per proteggere il popolo oppresso, e salvare il Cristianesimo che periva senza un pronto e forte riparo, egli è l'ambizioso, egli solo merita l'abbominio e le esecrazioni dell'umanità! Ma lode al Cielo che muove i Protestanti stessi a riconoscere in Gregorio VII il vero difensore del genere umano, non pur della Chiesa, il demjurgo della moderna civiltà! (Vedi l'opera' pubblicata in tedesco col titolo: Ildebrando e il suo secolo!) Sebbene il secolo di questo Gregorio rimarrà tuttavia ampia materia alle meditazioni de' secoli futuri.
(3) Ep. 11, Lib. IX.
85.
Innanzi tratto nulladimeno tentò con Enrico, il più paternamente che si potesse, tutte le vie della dolcezza e della pazienza; ma elle riuscirono affatto inutili: e i nunzi del Pontefice, le sue lettere, le tante sue amorose premure egualmenle spregiate ed illuse. Raccolse i Vescovi ed i Cardinali in Sinodo, e li addimandò di consiglio. Furono loro esposti i passi fatti dal Padre de' fedeli per disingannare il figliuolo traviato, e dall'altra parte le contumelie, gl'insulti, e l'aumento di scelleraggine col quale vi avea corrisposto Enrico; massime poi lo scisma che avea già tentato di fare nella Chiesa col ministero di molti Vescovi corrotti, vilissimi suoi mancipj, in Lombardia ed in Germania; furono lette le lettere imperiali che recavano gli ambasciatori quivi presenti al Sinodo, piene d'ogni maniera di sacrileghi vilipendj; e s'udirono parlare gli ambasciatori, che in pieno concilio tennero al Papa il seguente discorso: «Comanda il re nostro Signore, che tu deponga la Sede apostolica e il papato, perchè è suo, e che non ingombri più questo santo luogo» (1): furono considerate tutte le circostanze, la stranezza de' tempi, il malore irremediabile senza un forte rimedio; e tutti i Padri d'accordo, nessuno eccettuato, consigliarono il Papa, se v'avea mai circostanza in cui fosse espediente usare rigore, esser quella: doversi però tentare anche quest'ultima via: la Chiesa non doversi abbandonare; doversi anzi lasciare a' futuri secoli solenne esempio di ecclesiastica costanza; d'altra parte l'imperatore non aver ricevuto la corona incondizionatamente, ma bensì, sotto condizioni e patti giurati; esser seguito un vero contratto fra lui, quando fu eletto imperatore, e il popolo cristiano; incontrati obblighi scambievoli: il popolo aver dato il giuramento di fedeltà condizionato al mantenimento de' patti riguardanti principalmente la libertà e difesa della religione: di sua natura la Chiesa esser madre e tutrice dei cristiani; aver essa ricevuti i giuramenti imperiali in nome proprio e del popolo: non convenire al popolo svincolarsi da sè de' suoi giuramenti, ma sì spettare al Capo della Chiesa il provvedere alla salute di lui e della sua religione, siccome interprete e giudice de' giuramenti: perciò esso il Sommo Pontefice essere oggimai obbligato in coscienza, sì per la causa della Chiesa come per quella del popolo fedele, di pronunziare la sentenza, dichiarando l'imperatore mancato a' suoi giuramenti, e per conseguente il popolo disciolto altresì egli da' suoi. Questo è il fondo, e la vera spiegazione del consiglio dato unanimamente da tutto il Sinodo al sommo Pontefice Gregorio VII (2). Gregorio pertanto, stretto dalla propria coscienza, scomunicò Enrico IV, e dichiarò i suoi sudditi sciolti dal loro giuramento di fedeltà l'anno 1076.
(2) Tale dottrina di Diritto pubblico era comune in quel tempo fra' Cristlani, e nessuno la metteva in controversia. I re erano realmente costituzionali, sebbene non fosse inventata questa parola. Il Concilio parlò supponendolo. Ecco le parole del Concilio riferite da Paolo Benriedese nella Vita di Gregorio VII. Narra che, detta ch'ebbe il Pontefice un'orazione gravissima a' Padri, informandoli dello Stato delle cose, essi esclamarono: Tua, sanctissime Pater, censura, quem ad regendum nostri temporis sæculum divina peperit clementia, contra blasphemum, invasorem, tyrannum, desertorem, talem sententiam proferat, quæ hunc conterat, ET FUTURIS SÆCULIS TRANSGRESSIONIS CAUTELAM conferat. — Tandem omnibus acclamantibus definitum est, ut honore regio privaretur, et anathematis vinculis tam prænominatus Rex, quam omnes assentanei sui colligarentur. Accepta itaque fiducia, Dominus Papa, EX TOTIUS SYNODI CONSENSU, ET JUDICIO, protulit Anathema.
86.
Questo gran fatto segna l'epoca, come ho già detto, del periodo di rifacimento della Chiesa. Esso fu il segnale di una terribil battaglia: la Chiesa sollevava la testa oppressa tanto tempo da un giogo ignominoso, e ciò dovea necessariamente dar cagione ad una disperata pugna fra l'oppressa, e la forza opprimente. Non trionfò se non dopo tre secoli di combattimenti. Svincolatasi con fortezza dalla servitù del potere laicale, il grande scisma d'occidente la dilacerò. Non appena fu estinto, che vennero le eresie del settentrione; e solo col Concilio di Trento la Chiesa cominciò a riposare. Intanto le due gran massime di Gregorio VII, cioè la libertà dell'ecclesiastico potere, e la costumatezza de' Cherici, fur poste immutabilmente: e la prima portò subitamente il suo frutto, dando forza alla Chiesa e valore da trionfare di tanti nemici, e il Concilio stesso di Trento frutto di lei si può nominare, dopo il qual Concilio cominciò sensibilmente a fruttare anche la seconda massima colla correzione che si venne facendo della disciplina clericale e de' costumi.
87.
Tre stati adunque si distinguono del Cristianesimo rispetto al potere politico; quando gl'imperanti non erano ancora entrati nella Chiesa, quando entrati non aveano ancora subito la salutare influenza del Vangelo, e quando questa influenza ebbe portato a loro prò i suoi più benefici effetti.
Fino che la Chiesa di Cristo non possedeva che il popolo, e il sovrano era a lei straniero, ella non potea rivolger la voce de' suoi celesti ammaestramenti che al popolo, e gli diceva: «Tu, o popolo fedele, gemi sotto il dominio bene spesso tirannico di principi empj o superstiziosi che adorano i falsi numi. Sopporta in pace la tua oppressione: mira tutto ciò che avviene, come scritto nell'ordine della Providenza: ella veglia sopra di te: quella potenza non sarebbe in mano di principi infedeli, se non fosse anch'essa ordinata dall'eterna Providenza a tuo profitto; perchè ogni potenza viene da Dio, che è l'onnipotente. Non v'ha che il peccato che sia male, non v'ha che la virtù che sia bene. Cúrati di questa, e il resto abbandona alle sollecitudini del tuo Padre che sta ne' cieli. Quando a lui ne parrà, quando egli vedrà che un altro ordine di cose dia a te più copia di meriti per l'eterna vita; allora egli muterà le cose esteriori, e tu avrai fra di te i tuoi principi. Intanto rispetta quelli che ti son dati, ubbidiscili in tutto ciò che non è avverso alle legge di Dio; combatti, muori per essi: e questo non per timore, ma il fa per coscienza, cioè per onorare in essi quel Dio che dall'alto tutte dispone le cose umane».
Quando poi venne il tempo in cui i principi si convertirono alla fede, al popolo tenne sempre lo stesso discorso; ma ella tolse ad ammaestrare anche principi; e perchè ne' principi non era ancora penetrato il Vangelo bene a fondo, e non l'avevano che alla superficie, ella parlò loro per così dire non in pubblico, ma in privato; e nel tempo che da una parte dicea al popolo: «Non ti consentirò mai di ribellare al tuo sovrano, sia egli pur discolo; e se tu se' popol di Cristo, è l'umiltà che de' professare, la sommissione e il sacrificio»: dall'altra, prendeva separatamente i monarchi da parte, e diceva loro: «Sappiate che voi non siete più che uomini: che gli uomini sono uguali innanzi all'Eterno; che voi sarete giudicati da Cristo come l'ultimo e il più tapino de' vostri sudditi, e via più severatamente, perchè sta scritto: «Giudizio durissimo sarà fatto di quelli che presiedono». «Sappiate che il vostro stato è pauroso, e non desiderabile agli occhi della fede: che la giustizia e la carità sono le sole vie per le quali voi potrete sfuggire gli eterni supplizj, e salvare le anime vostre: che non dovete stimare nè porre il cuore alle grandezze da cui siete circondati, le quali alla morte tutto al più vi abbandoneranno: che siete fatti capi del popolo cristiano dalla Providenza non pel vostro, ma pel suo vantaggio; che la vostra dignità è un ministero, un servigio; e che per farvi più grandi degli altri, dovete rendervi i minori di tutti». Tali erano le sublimi e umanissime verità che la Chiesa fece sonare agli orecchi, ed istillò negli animi de' regnatori quando divennero suoi figliuoli: ed essi le udirono con rispetto, e con maraviglia di trovare una nuova nobiltà, che non poteva esser lor data dalla potenza, nè dal fasto delle corone, ma solo dall'umiltà della croce del Salvatore. E che ne fu? Penetrarono il cuore e vinsero tali verità; e venne il lor tempo: e quasi su tutti i troni di Europa apparvero degli eroi, che praticarono tutte le virtù del Vangelo nella loro perfezione; i quali se con una mano amministravano la giustizia e pugnavano per essa; stendevano l'altra al soccorso de' poveri, nuovi loro fratelli carissimi, fino a nutricarli e servirli personalmente, in essi mirando Cristo, che si mise nella persona di tutti i poveri, e fino ad incurvare le loro regie spalle sotto il prezioso peso di miseri infermi abbandonati da tutti come troppo stomachevoli in sulle vie.
Quando la Chiesa ebbe per tal modo ammaestrati nella teoria e nella pratica del Vangelo i principi non meno che i popoli, allora non parlò più loro in separato: chiamò per così dire la buona madre gli uni in presenza degli altri, e tenne con esso loro questo ragionamento: O principi, miei figliuoli, voi già siete illuminati dalla luce del Vangelo; volete voi conformarvi ad esso in ogni cosa? — Lo vogliamo. — E bene, vi rammenta che il Vangelo vi dice, come non il caso, ma Iddio colla sua benigna providenza ha voi costituiti capi del suo popolo cristiano; acciocchè gli conserviate la pace, gli amininistriate la giustizia, e sopra tutto gli manteniate e proteggiate il bene che è per lui il massimo di tutti, la sua religione: volete voi altro? — È giusto; non altro: noi porremo la gloria nostra in governare il popolo di Dio giustamente e pacificamente, e in difendere la Chiesa di Cristo, madre nostra. — Giurate dunque tutto ciò, giuratelo nelle mie mani, in presenza de' vostri popoli. — Lo giuriamo. — Ma che sicurtà date voi del vostro giuramento? Non è egli secondo l'equità, che il vostro popolo, acciocchè abbia tutta la confidenza in voi, come in altrettante immagini di Cristo, s'abbia altresì qualche pegno e sicurtà di quello che oggi voi gli promettete, acciocchè non possa avvenir mai che il popolo cristiano sia governato da principi o infedeli o ribelll alla Chiesa? — Troppo ragionevole: che Iddio mandi sopra di noi tutte le sciagure, se noi manchiamo ai nostri giuramenti. — Dichiarato adunque; che sareste anche contenti di discendere dal trono, se vi allontanaste dall'ubbidienza della Chiesa? dichiarate che voi sareste indegni di portare una corona cristiana, la quale fa vicario di Cristo solo Re de' secoli colui che la porta, se diveniste inimici della sua Chiesa; e che perciò siete contenti che il giuramento di fedeltà non obblighi più i vostri sudditi dall'istante che foste precipitati in tale enormità? — Sì, sì, lo dichiariamo; siamo contenti di tutto ciò: conosciamo giusto che i figliuoli della Chiesa non sieno governati che da altri figliuoli devoti alla medesima Chiesa, perocchè se un principe non è che un ministro di Cristo, incaricato del bene de' fedeli, egli non è più tale quando infierisce contro Cristo medesimo. — Orsù, principi e sudditi, miei cari figli, toccate adunque con pure mani questo sacrosanto volume del Vangelo: i mutui giuramenti onde oggi vi stringete, stiano a perpetua memoria quali leggi fondamentali e immutabili de' regni cristiani: saranno essi fonti inesausti di pura felicità, finchè vengano religiosamente osservati: maledizione e sventura a chi primo gli infrange.
Questo non è un sogno: è un fatto realissimo: è la costituzione de' regni cristiani, nata nel medio evo, in quel tempo in cui lo spirito del Vangelo era pervenuto a dominare e sottomettere a sè le più alte cime della società. Que' principi penetrati dalla dottrina di Cristo, si sentivano più che mai ferventi per essa, e avrebbero voluto ogni cosa patire, prima di rinunziarvi: perciò sicuri di sè stessi, non temevano di pronunziare de' giuramenti, che trovavano tanto equi, tanto umani, e di voler che con essi si legassero anche i loro discendenti, come con fortunatissimi legami. L'equità e la carità verso i loro popoli, che lavati nelle acque di uno stesso battesimo, consideravano come proprii fratelli, oggetti venerabili e sacri, confidati alle loro mani dal re de' regi; e il zelo ardente della fede prevalse sulla ambizione, sull'amore della propria potenza; e per la gloria di questa fede, pel vero bene de' popoli, furono assai contenti di tramandare a' loro successori un imperio meno assoluto quanto alla forma, ma più nobile perchè più giusto, più pietoso, e consacrato anch'egli dalla Religione; accrescendo così di dignità morale, e con essa di stabilità e di consistenza quegli scettri che si abbassavano sotto a una legge eterna di amore di giustizia, il servire alla quale è veramente e solamente regnare. Questa costituzione cristiana de' regni, parte fu scritta, parte non iscritta, ma fu sempre consentita da tutti, e altre volte non v'avea principe, non popolo, che la mettesse in dubbio: perchè tutti concordi, tutti religiosi, non aveano cagione di farlo: era un bene comune: a tutti premeva di mantenerla. Talora ella si riduceva a leggi più speciali, più precise: tali erano quelle che presiedevano all'Impero romano, e al regno di Germania: veggiamolo nel fatto che abbiamo alle mani di Enrico.
88.
Quando Enrico, minacciato di esser deposto per sempre da’ Signori tedeschi assembrati a Tribur, venne al Papa nel castello di Canossa, impetrando l'assoluzione della scomunica, per muoverlo a consentirgliela senza dilazione, addusse, che presto spirava l'anno da che era stato annodato colla scomunica, e l'urgenza in cui perciò lo mettevano «le leggi palatine secondo le quali, se il re fosse stato un anno ed un giorno fuori della comunione della Chiesa, era dichiarato indegno del posto di re e decaduto ipso facto dal trono, senza potervi più essere ristabilito (1); il che mosse il santo Pontefice a concedergli l'assoluzione; ingannato dagli atti di esterno pentimento che seppe simulare quell'infelice monarca.
Or come in Germania era fissato il tempo di un anno e di un giorno di scomunica per decadere dal regno; così presso tutti i troni cristiani s'avea per certo e consentito dalle parti interessate, che l'eresia e l'infedeltà privava del regno, e i giuramenti di fedeltà dati da' sudditi non erano fatti che sotto condizione che il principe rimanesse nella fede cristiana cattolica (2).
(2) Enrico riconobbe questa condizione annessa ai regni dei principi cristiani come veniente dalla tradizione della Chiesa, anche in una lettera che scrisse a Gregorio VII, nella quale dice cosi: Me quoque, licet indignas inter Christianos sum, ad regnum vocatus, te teste, quem sanctorum Patrum traditio soli Deo judicandum docuit, nec pro aliquo crimine NISI A FIDE (quod absit) exorbitaverim, deponendum asseruit.
S. Tommaso, che è quello scrittore che ha raccolto la tradizione ecclesiastica con più estensione e sicurezza di ogni altro, e le cui decisioni sono considerate como voci della Chiesa, sostiene che questa «legge costitutiva» de' regni cristiani, cioè che un re cattolico facendosi eretico sia immantinente decaduto dal suo trono, risulta e nasce dalla stessa costituzione della Chiesa fatta da Gesù Cristo, e non puramente da una convenzione espressa, o sottintesa, stretta fra i principi e i popoli cristiani colla mediazione della Chiesa (s. II, II, XIII, 2). Egli è però certo, che fino che questa convenzione di fatto non fu seguita, fino che la dottrina cioè non è stata consentita e ricevuta per buona e giusta non meno dall'opinione de' popoli che da quella de' principi, non era venuto ancora il tempo nel quale i Capi delia Chiesa potessero esercitare questo loro diritto sui fedeli cristlani; il che non hanno considerato bastevolmente coloro, che si maravigliavano del non trovare ne' priml secoli delta Chiesa l'uso di questa potestà, e di ciò inferiscono ch'ella sia abusiva. Prima la Chiesa dovea operare la riforma dell'Individuo umano, poi dovea riformare la società: riformata questa, poteva applicare alla medesima le leggi volute dal Cristianesimo.
89.
Dopo di ciò egli è evidente, che la deposizione di un cristiano principe dipendeva da una causa, la decisione della quale appartiene al foro della Chiesa; perciocchè alla Chiesa s'appartiene il decidere della fede, e il ritenere o il rigettare dal suo seno i fedeli di ogni condizione; e oltracciò, essendo stata la Chiesa quella che, divenuta madre comune, aveva con una convenzione di amore ravvicinati e raggiunti i principi ai popoli, e dato al mondo lo spettacolo nuovo e commovente che quelli e questi si stringessero fraternamente le destre; conveniva che ella sola la Chiesa, depositaria del sacro patto, ne fosse altresì l'interprete, e nel caso di violazione, prima che le parti rivendicassero per via di fatto i violati diritti, ella ne dichiarasse la violazione.
Prima che queste cristiane convenzioni fra i popoli e i loro capi fossero strette; la sovranità era, come dicevamo, assoluta «di diritto divino (1); perocchè i fatti appartengono al diritto divino, come quelli che sono ordinati dalla Providenza: in quello stato la Chiesa non riconobbe mai il caso possibile che i sudditi cristiani si sottraessero dall'ubbidienza del loro sovrano. Ma quando i sovrani stessi, porgendo l'orecchio alle voci della equità e della carità, nobilitarono le loro corone, le fecero brillare di una luce celeste col sottometterle al Vangelo, e col volere che dai principj del Vangelo dipendessero; quando essi amarono di essere, anzichè i padroni di uomini schiavi, i ministri e i vicarj di Gesù Cristo per lo bene di uomini liberi; quando essi promisero, giurarono di voler esser tali, e si posero da se stessi nella felice necessità di essere figliuoli riverenti alla Chiesa di Gesù Cristo; allora la sovranità divenne per cosl dire «di diritto umano-ecclesiastico», e la Chiesa riconobbe darsi il caso, in cui i sudditi potessero venire sciolti da' loro giuramenti di fedeltà.
Ma come una tale trasmutazione nella società non avvenne di tratto, ma insensibilmente, come dicevamo, e senza che occhio umano, per così dire, se n'accorgesse; ed offerendosi alla Chiesa l'occasione di pronunciare un sì rilevante giudizio per la prima volta al tempo di Gregorio VII; non è a stupire, se il passo di questo S. Pontefice sembrasse a molti cosa nuova, e di questa novità prendessero cagione di calunniarlo. Quelli però che lo calunniarono allora, n'avevano ben donde; e la Chiesa avea esercitato assai prima una giurisdizione che dipendeva dagli stessi principj di diritto pubblico cristiano, senza trovare la minima opposizione, senza che nessuno se ne fosse maravigliato, perchè essi erano atti non di rigore, ma di favore, e non contrariavano de' vizj potenti ed ostinati.
90.
Ma oltracciò quelli che s'oppongono alla condotta tenuta dalla Chiesa con Enrico IV, fanno argomento delle loro interminabili ed amare declamazioni i mali che ridondarono per sì lungo tempo nella società dalla lotta della Chiesa coll'impero. Io vorrei pregar costor in primo luogo, che sapesser vedere appunto in questi mali una delle ragioni per le quali la Chiesa s'astenne prima del secolo di Gregorio VII da simili estremità (1); e però non volessero più far militare questo essersi la Chiesa astenuta da simili pericolosi atti fino al secolo XI, il più corrotto di tutti, e nel quale non potè più sostenere il delitto, come una ragione contro alla giurisdizione della medesima. Di poi vorrei chiamarli a considerare freddamente la questione «se il passo di Gregorio era di tal natura da cagionare necessariamente tutti que' mali che ne seguirono».
91.
Quella lotta terribile non fu già a vero dire fra il Sacerdozio e l'impero, come volgarmente si suol credere, ma fu una lotta, fatta «a nome del Sacerdozio e dell'impero»: fu più tosto il Sacerdozio diviso in due parti l'una delle quali combatteva per la Chiesa, ed era la Chiesa, l'altra combatteva per sè contro la Chiesa, e si copriva col colore dello zelo pe' diritti dell'impero. I nobili, come pure il popolo, erano concordi dalla parte del Papa (1); ma contro il Papa erano molti Vescovi ricchi e possenti. La ragione è manifesta: il Papa non aveva punto intimato guerra al re, che amava con affetto paterno, e molto meno alla sua corona, e a nessuno de' suoi diritti; che alcuno non ha mai voluto usurpargliene; ma la guerra il Papa l'avea intimata contro il Clero simoniaco e dissoluto: credendosi obbligato in coscienza di sterminare, anche a costo del proprio sangue, questi vizj oggimai tanto cresciuti, che avrebbero sterminata essi la Chiesa, se fossero stati più a lungo risparmiati (2).
Intimoriti pertanto dalla integrità e santità di quest'uomo sollevato da Dio alla Cattedra apostolica per francheggiare il popolo d'Israello come un altro Sansone, tutti i cherici dissoluti, e quanti avevano comperato a sommo prezzo da Enrico i Vescovati, potenti per Signorie e per influenza nel governo dello Stato, si sollevarono di comune accordo, si strinsero in una lega formidabile per l'odio della virtù, la più potente delle passioni, usarono tutte le arti che può suggerire una malizia la più consumata (3), e per segno di riunione diedero il grido «dover tutti difendere i sacri diritti del proprio sovrano». Ma che diritto del proprio sovrano pretendevano difendere questi Vescovi? Forse quello di essere simoniaco, e protettore impudente del concubinato del clero? Perocchè qual altro diritto del re Enrico veniva attaccato? Ebbe mai Gregorio VII intavolato la minima pretesa sopra qualche altro diritto del suo regno? Dimandò altro, se non che cessasse dal mercanteggiare le sedi vescovili, e dal prostituirle a persone infami? Fu certamente per cessare la totale e imminente rovina della Chiesa, che, non valendo gli altri mezzi, e rendendosi l'imperatore, sedotto appunto dalle perfide suggestioni de' prelati suoi compagni di dissolutezza, sempre peggiore, egli lo scomunicò.
Ma non solo il Clero corrotto trascinò Enrico nel fondo di tanti mali (4), egli ancor vel mantenne, e impedi che la lotta avesse fine. Era naturale: la guerra non può finire, se non vinto il nemico, e l'unico nimico era la corruzione di questo clero aulico.
Supponiamo che Enrico avesse dato orecchio alle paterne e giustissime voci del Capo della Chiesa; o che riconciliato la prima volta col Pontefice nel castello di Canossa, non fosse stato dai Vescovi iniqui, che si servivano di lui a scudo di sè e de' proprj vizj, travolto ne' suoi antichi sregolamenti. Tutta la procella sarebbesi tosto abbonacciata: il re, come era stato assoluto senza dilazione dalla scomunica, così sarebbe rimasto in perfetta pace colla Chiesa: egli avrebbe conservato il suo regno, e il pio Pontefice, stringendolosi al seno colle viscere le più paterne, l' avrebbe bagnato colle copiose lagrime della pura sua gioja. Ma se la pretesa lotta fra il sacerdozio l'impero fosse così subito nel suo nascer finita, come di sua natura dovea, che ne sarebbe avvenuto de' prelati intrusi, simoniaci, concubinarj? Essi ne sentivano bene le conseguenze: sentivano che sarebbe stato de' loro vizj: che della loro vita ribalda e sfrenata: che de' ricchissimi benefizj caramente da lor comperati: che delle loro donne: che della grazia del principe loro complice ravveduto. Ciò tutto spiega, e mostra ragione più chiara del sole per la quale una tal gente andasse nelle disperazioni all'udire Enrico riconciliato col Papa; e gli estremi mezzi adoperasse a farlo ricadere in precipizio, rompendola di nuovo così col Pontefice e colla Chiesa (5).
(2) Ecco come un Ugone Flaviniacense espose la vera cagione della così detta lotta fra il Sacerdozio e l'Impero: OB HANC IGITUR CAUSAM, quia scilicet sanctam Dei Ecclesiam castam esse volebat (Gregorins), liberam, atque catholicam; quia de sanctuario Dei simoniacam, et Neophytorum hæresim, et fædam libidinosæ contagionis pollutionem volebat expellere; membra diaboli cæperunt in eum insurgere, et usque ad sanguinem præsumpserunt in eum manus injicere, et ut eum morte vel exilio confunderent, multis eum modis conati sunt dejicere. Sic surrexit inter regnum et Sacerdotium contentio, accrevit solito gravior sanctæ Dei Ecclesiæ tributatio (In Chron. Virdunensi). Si vegga nel Fleury l'articolo intitolato: «Ribellione de' Cherici concubinarj». Lib. LXII, XII. Tutti i Vescovi che erano dalla parte dell'imperatore e ne sommovevano l'animo contro gli avvisi del Papa, erano scomunicati già prima per simonia, per eresia, per iscostumatezze, e per altre scelleraggini d'ogni guisa: erano quelli a cui Enrico stesso avea venduto i benefizj ecclesiastici. Che petto non facea bisogno in un Papa che avea da governare la Chiesa con un tal Clero, e che ardiva intraprenderne la riforma! ed essendo le potestà del secolo avvolte negli stessi vizi, e maneggiate dalla parte di esso Clero la più corrotta!
(3) Non pure la brutale violenza, ma l'arte della calunnia, del sofisma, e di ogni genere di fina menzogna fu esaurita contro Gregorio VII da' cherici, le cui ribalderie egli voleva correggere, e che stavano intorno a Enrico vestiti da suoi fautori, consiglieri, e ministri. — L'arcivescovo di Ravenna Gulberto che fu poi anti-papa, non avea ommesso di falsificare il decreto di Nicolò II, e facendolo girare attorno, volea far credere che l'elezione de' Papi era stata rimessa al tutto nelle mani dell'imperatore, e con simiglianti finzioni s'ingannò gran gente, si confuse la questione, si protrasse il desiderio, ed ecco i veri autori de' torbidi!
(4) Fino dalla prima gioventù prevalsero presso Enrico I cherici più scostumati, e dovettero da lui ritirarsi un S. Annone ed altri uomini probi, perchè non adulatori e fautori delle sue male tendenze. Brunone nella Storia della guerra Sassone attribuisce l'essersi dato giù Enrico nel fondo di tutti i vizj più infami, alia famigliarità sua col vescovo di Brema Adalberto: Hac igitur, dice, Episcopi non episcopali doctrinâ, rex in nequitia confortatus ivit per libidinum præcipitia sicut equus et mulus, et qui multorum rex erat populorum, thronum posuit in se libidini cunctorum reginæ vitiorum etc. Enrico stesso in un momento di ravvedimento, vero o finto, scrivendo a Gregorio la confessione de' suoi falli, ne accagiona in parte i suoi tristi consiglieri: Heu criminosi nos, gli scrive, et infelices! partim pueritiæ blandientis instinctione, partim potestativæ nostræ et imperiosæ potentiæ libertate, partim eorum, quorum seductiles nimium secuti sumus consilia, seductoria deceptione, peccavimus in cælum et coram vobis, et jam digni non sumus vocatione vestræ filiationis. Non solum enim nos res ecclesiasticas invasimus, verum quoque indignis quibuslibet et simoniaco felle amaricatis et non per ostium sed aliunde ingredientibus Ecclesias ipsas vendidimus, et non eas, ut oportuit, defendimus etc. (Vid. t. 1 Constitut. Imperial. Goldasti).
(5) Quando Enrico ottenne da Gregorio VII nel castello di Canossa l'assoluzione della scomunica, allora i Vescovi del suo partito furono desolati del vedere abbandonata la loro causa dall'imperatore; e Ruberto di Bamberga, Uldalrico di Costreim, ed altri primarj consiglieri delle sue scelleratezze, de' quali il Papa, nell'assolvere il re, avea messo per condizione l'allontanamento dalla corte, e dalla reale persona, con altri Vescovi lombardi dello stesso taglio, fecero tanto rumore, minacciando ribellione, tutto per zelo, com'essi ostentavano, della regla dignità disonorata da Enrico nell'umiliarsi in tal modo sotto il Pontefice; che travolsero Enrico dal suo buon proposito, e il fecero tornare al vomito. Era singolare la logica di questi prelati! La dignità reale era disonorata perché s'era lasciata correggere de' suoi vizj dal Papa: perciò intendevano di gastigare essi il re et quidem per via di fatto!
92.
Si vuole un'altra prova, che non erano i diritti dell'impero l'oggetto di quegli infelicissimi e sì lunghi contrasti? Richiamisi alla mente quanto avvenne mezzo secolo dopo fra Enrico V e Pasquale II. Questo immortale Pontefice ha fatto sentire un linguaggio, che nella bocca di qualsiasi Papa dell'antichità non si sarebbe potuto trovare nè più santo nè più elevato: e mostrò col suo contegno, come nella sede di Pietro non è venuto mai meno lo spirito dell'apostolato, e come il Vangelo di Gesù Cristo eterno non ha il jeri e l'oggi. Io credo di dover recare le proprie parole del componimento con Enrico V che questo gran Papa propose: conciossiachè esse sono un monumento luminosissimo, il quale prova non essersi potato giammai spegnere nella Chiesa, nè manco ne' secoli più miserandi, quell'altezza di pensiero che solleva il sacerdozio cristiano su tutte le altezze e su tutte le dovizie transitorie della terra, e il fa possente della sola parola di Dio. Nello stesso tempo questo brano di Pasquale II può dimostrare quanto i sommi Pontefici abbiano conosciuto intimamente quel vero che noi continuamente diciamo, la servitù e la corruzione del Clero scaturire dall'implicarsi questo ne' negozj secolari. Il Papa in somma con un atto di magnanimità senza esempio propone, che il Clero rinunzii ai feudi e a tutte le grandezze secolari, e che in cambio di questo abbandono gli sia restituita intera la sua libertà: proposizione sublime, trovandosi la Chiesa in quello stato, e di cui non fu fatto dagli scrittori delle ecclesiastiche istorie il conto dovuto; a cui resta ancora di render giustizia; e le meditazioni degli avvenire gliela renderanno, facendol brillare come uno de' fatti più luminosi della storia della Chiesa. Sebbene, tanta sublimità e bellezza della proposta di Pasquale, degna degli Apostoli, rendevala appunto agli occhi de' suoi contemporanei strana, assurda: il Clero di Germania in udendola inorridì, si rivoltò contro il Papa, e rivoltò l'imperatore che pur l'avea da parte sua accettata e giurata: nè altro poteva aspettarsene. Ecco di nuovo l'affascinamento del Clero prodotto da' beni temporali impedire per la terza volta, almeno, la pace fra il sacerdozio e l'impero: e l'impero togliersi all'ubbidienza della Chiesa per farsi ubbidiente e servo del Clero corrotto, lusingato e invanito del fumo di una vana adulazione, con cui questo genere di Clero, che non ha nè dignità nè libertà da vendere, sempre lo si guadagna. L'impero è dunque un puro pretesto, e accessorio nella gran lotta: il Clero corrotto giunge scaltramente a involgere l'impero nella sua propria causa, e combatte per sè a nome de' diritti dell'impero, e col braccio di questo. Ma udiamo pure Pasquale.
Egli scrive all'imperatore in questa forma: «È sancito dalle istituzioni della divina legge, ed è proibito da' sacri canoni, che i sacerdoti si occupino di cure secolari, nè vadano alla corte, se non forse per intercedere a favore di condannati o di altri a cui venga fatta ingiustizia. — Ma nelle parti del vostro regno i Vescovi e gli Abati sono a tale da cure secolaresche occupati, che non possono a meno di frequentare assiduamente la corte e di esercitare la milizia; — e i ministri dell'altare son divenuti ministri di stato, avendo ricevuto, dai re le città, i ducati, i marchesatl, le zecche, le castella, ed altre cose pertinenti al servizio del regno. E di qui è prevalso un costume nella Chiesa, che i Vescovi eletti non ricevessero più la consecrazione, se prima per mano del re non fossero investiti (1). Talora anco ne vengono investiti altri, vivendo tuttavia i Vescovi: Ora da questi mali e da altri senza numero, che ben sovente accadevano per cagione di quell'investitura, furono scossi i nostri predecessori di felice memoria Gregorio VII e Urbano II, e ragunando frequenti Concilii di Vescovi, dannarono quelle investiture fatte per mano laicale; e se v'avessero Cherici che tenessero per così fatto mezzo le Chiese, stimarono doversi essi deporre, e quelli che gli ebbero investiti, scomunicarsi, a tenore del canon apostolico che dice così: Se un Vescovo, facendo uso delle potestà del secolo, ottenne con tal mezzo una Chiesa, sia deposto, e scomunicati quelli che con esso comunicano. — Per le quali cose noi comandiamo che sieno rimessi a te, o re Enrico figlio carissimo, e allo stato que' diritti regali che manifestamente allo stato appartenevano ne' tempi di Carlo, di Lodovico, di Ottone e degli altri principi tuoi predecessori. E interdiciamo e proibiamo sotto il rigore dell'anatema, che quinci innanzi nessuno de' Vescovi o degli Abati presenti o futuri invadano i regali diritti, cioè le città, i ducati, le marche, le contee, le zecche, le imposte, le avvocazie, i diritti de' Centurioni, e tribunali regi con loro pertinenze, la milizia e i castelli. — Decretiamo poi che le Chiese rimangano libere colle loro oblazioni e possedimenti ereditarj che al regno manifestamente non appartenevano, come tu nel giorno della tua coronazione hai promesso all'Onnipotente Signore nel cospetto di tutta Chiesa» (2).
È forse questo il linguaggio degli usurpatori? Tanta generosità, tanto abbandono di potenza temporale legittimamente acquistata dalla Chiesa pe' servigi prestati allo stato in molti secoli, è forse una prova dell'ambizione de' Papi? della loro avidità! (3) Ma qual ricambio si esige dalla potestà secolare per rinunziare a sì vasti diritti? Ci cova qualche fine secondario sotto? È egli questo un gioco della politica della Corte romana? Iddio giudichi fra quelli che così opinano, e Roma. I Papi non dimandano ai re che la LIBERTA' della Chiesa oppressa fino alla estinzione: oso dire, non hanno dimandato mai altro: qui termina tutta la loro ambizione e la loro avidità (4). Ma pur troppo è appunto questa libertà, e l'esistenza della Chiesa che dispiace: e il domandarla e rivendicarla è il solo torto de' Papi in queste lotte, che non si perdona. S'empia adunque il mondo delle grida: insulto alla maestà de' troni! ambizioso usurpamento de' loro diritti! Tale è lo spirito d'ingiustizia e di profonda menzogna che ha presieduto alle declamazioni contro questi Romani Pontefici, e si può anche dire alla stampa del secolo scorso: tale la cagione messa al nudo di quel zelo affettato per la dignità dei monarchi in tempi che tutto si fa per disperderti dalla faccia della terra!! e i monarchi soli non se ne accorgono???
(2) Divinæ legis institutionibus sancitum est, et sacris Canonibus interdictum, ne Sacerdotes curis sæcularibus occupentur, neve ad comitatum, nisi pro damnatis eruendis, atque pro aliis qui injuriam patiuntur, accedant. — In vestri autem regni partibus, Episcopi vel Abbates adeo curis sæcularibus occupantur, ut comitatum assidue frequentare, et militiam exercere cogantur. — Ministri vero Altaris, ministri Curiæ facti sunt, quia civitates, ducatus, marchionatus, monetas, turres, et cætera ad regni servitium pertinentia, a regibus acceperunt. Unde etiam mos Ecclesiæ inolevit, ut electi Episcopi nullo modo consecrationem acciperent, nisi per manum regiam investirentur. Aliquando etiam vivis Episcopis investiti sunt. His et aliis plurimis malis, quæ per investituram plerumque contigerant, prædecessores nostri Gregorius VII et Urbanuus II felicis recordationis Pontifices excitati, collectis frequenter episcopalibus Conciliis, investituras illas manu laica damnaverunt, et si qui Clericorum per eam tennissent Ecclesias, deponendos, datores quoque communione privandos percensuerunt, juxta illud Apostolicorum Canounm Capitulum, quod ita se habet: Si quis Episcopus sæculi potestatibus usus, Ecclesiam per ipsas obtineat, deponatur, et segregentur omnes qui illi communicant. Tibi itaque, fili carissime Henrice rex, et regno regalia illa ilimittenda præcipimus, quæ ad regnum manifeste pertinebant tempore Caroli, Ludovici, Ottonis, et cæterorum prædecessorum tuorum. Interdicimus etiam et sub anathematis districtione prohibenius, ne qui Episcoporum seu Abbatorum, præsentium vel futurorum, eadem regalia invadant, id est, civitates, ducatus, marchias, comitatus, monetas, telonium, advocatias, jura centurionum, et curtes quæ regi erant, cum pertinentiis suis, militiam et castra. — Porro Ecclesias cum oblationibus et hæreditariis possessionibus, quæ ad regnum manifeste non pertinebant, liberas manere decrevimus, sicut in die coronationis tuæ omnipotenti Domino in conspectu totius Ecclesiæ promisisti». Ep. XXII.
(3) Altri accuseranno il magnaniino Pontefice di non aver con ciò bastevolmente sostenuti i diritti della Chiesa, abbandonando alla cupidigia altrui i beni temporali della medesima. Mi si perdoni una osservazione a questo proposito, che mi prendo la libertà di sottomettere al giudizio di quelli che veggono meglio di me. «Parmi che la ricchezza e il potere temporale entrato nel Clero non solo abbia prodotto in una parte del medesimo un'aperta corruzione; ma che generalmente altresì abbia igenerato una soverchia confidenza ne' mezzi umani pel vantaggio della religione». Dubito perciò non forse in altri casi questi beni sieno stati difesl con troppo di forza, come spiegherò meglio in appresso; quando, secondo lo spirito ecclesiastico dell'antichità, «è meglio abbandonarli ove la difesa loro giunga a tale da dover produrre un pericolo di maggior male spirituale»; perciocchè i beni temporall non sono di un assoluto bisogno alla Chiesa, come è la sua libertà e santità; e perciò non meritano un'assoluta e incondizionata difesa.
Chi vuol vedere di quanto disinteresse fossero i sentimenti di S. Agostino non solo relativamente alla sua persona, ma ben anco a' beni della sua Chiesa, legga i sermoni ch'egli teneva al suo popolo, e in particolare il CCCXVI. In questo, fra l'altre cose dice: «Chi vuol privare i figliuoli suoi per lasciare il suo alla Chiesa, cerchi un altro che non sia Agostino a ricevere il suo dono; o credo più tosto, se a Dio piace, che non potrà egli ritrovarlo;» le quali ultime parole mostrano, che questo sentimento era comune a' Vescovi del suo tempo. E sogginuge: «Quanto non fu lodata l'azione di Aurelio Vescovo di Cartagine! Un uomo che non avea figlinoli, e non ne sperava, lasciò tutti gli averi suoi alla Chiesa, riserbandosene l'usufrutto. Gll sopraggiunsero de' figliuoll, e il Vescovo gli restituì quanto gli avea lasciato, quando meno se l'aspettava. Poteva non restituirlo secondo il mondo, ma non secondo Dio».
Parimente con che larghezza S. Ambroglo scrive: Quid igitur non humiliter respousum a nobis est? Si tributum petit (imperator) non negamus. Agri Ecclesiæ solvunt tributum: Si agros desiderat imperator, potestatem habet vindicandorum, nemo nostrum intervenit. De Basilicis tradendis, n. 33.
A questo proposito de' tributi aggiungerò ancora che talora si mise troppa premura a sostenere l'esenzione da' tributi a favore dei beni ecclesiastici. Questo privilegio, quando i beni della Chiesa sono molti, ha in sè qualche cosa di sommamente odioso e contro l'equità. Oso dire di più; egli fu anzi di danno che di vantaggio alla Chiesa anche nell'ordine temporale; perocchè in gran parte egli fu cagione che s'inventò quella terribile parola delle mani morte, e che si disse, come fa il Barbosa, Regnorum utilitas postulat ut bona stabilia sint in commercio hominum non privilegiatorum ET EXEMPTORUM. Lib. II, de Pensionibus, Vol. XXVI, n. 19.
Un componimento equo sarebbe stato «che lo stato rinunzij alla regalia per riguardo a tutti que' beni che non sono veri e originarii, e i beni della Chiesa paghino il tributo come tutti gli altri».
(4) Pasquale II ben conosceva, essere le suggestioni de' tristi che intorbidavano la quistione; e perciò scriveva così al re d'Inghilterra: «Fra queste contraddizioni deh non ti lasciare introdur nell'animo, re, da nessuno una persuasione profana, quasi che noi volessimo diminuir qualche cosa della tua potestà, o anche solo vindicare a noi una maggiore influenza nella promozione dei Vescovi. Anzi tu lasci la tua pretensione per amor di Dio, la quale è manifestamente contro di Dio, nè tu puoi stando con Dio esercitaria, nè noi, salva la nostra salute e la tua, concederla; del resto qualsiasi altra cosa tu ci dimanderai, cui noi possiamo secondo Dio concederti; e noi la ti accorderemo con sommo piacere, e daremo mano con propensione via maggiore a tutto ciò che ridonderà a tuo onore e a tua elevazione. Nè riputare che s'addebiliti il nerbo della tua potestà, desistendo tu da cotesta profana usurpazione: che anzi tu regnerai perciò appunto con più efficacia, con più saldezza, con più onoranza: perchè nel tuo regno regnerà la divina autorità». Queste ultime parole di Pasquale sono pur belle ed osservabili anche perchè indicano un fatto notato da un profondo pensatore de' tempi nostri, cioè «che i Papi sebbene si sieno opposti ai sovrani quando questi volevano opprimere la Chiesa, tuttavia non li hanno mai avviliti, ed anzi il sottomettersi di questi all'autorità della Chiesa ha conferito qualche cosa di sacro alla sovranità e quasi un riflesso di divino splendore». Le parole di Pasquale al re d'Inghilterra battono qui appunto: Nec existimes quod potestatis tuæ columen infirmetur si ab hac profana usurpatione desistas. Imo tunc validius, tunc robustius, tunc honorɑbilius regnabis,CUM IN REGNO TUO DIVINA REGNABIT AUCTORITAS. (Presso Eadmero. Lib. III Historia Novorum). Potrebbesi aggiungere non regnar altri che solo colui che serve a Dio, alla giustizia, alla verità!
93.
La proposizione che sostengo, cioè «la così detta lotta del sacerdozio e dell'impero non essere stata altramente se non una lotta fra il Clero depravato ricusante la riforma, e la Chiesa che pur riformarlo volea», luce della luce più manifesta ad ogni passo della storia di quella contesa: basta aprire a caso i cronisti di que' tempi; piglisi pure qualsivoglia senza eccezione di partito e di opinione, e in qualsiasi pagina l'occhio s'imbatta, io son per dire che subito esso si scontrerà in prove evidenti della verità che affermo; il che rende sorprendente la distrazione degli storici moderni, che tolse loro di considerare una verità così palmare e scritta in tutti i monumenti di quella età, dirò così, a caratteri di lagrime e di sangue. Sarebbero inutili adunque altre prove, quando prove sono le intere storie. Ma la sopra indicata distrazione degli scrittori infilosofati mi muove ad aggiungere pur un fatto, che per quanto sia manifesto il vero, egli nondimeno è stato così oscurato ed obliterato, che a molti l'udirlo parrà novità; e ciò che sa di nuovo, merita di esser comprovato con diligenza pel rispetto debito alle pubbliche opinioni. E il fatto che io vo' qui recare sarà fuori del contrasto cogl'imperatori di Germania, acciocchè si vegga, come il vero da me sostenuto sia universale di tutte le lotte ch'ebbero in quel tempo i Papi co' principi; sarà cioè quanto passo fra Pasquale II e il primo Enrico re d'Inghilterra.
Enrico, come ogni altro principe di quel tempo, facea alto e basso de' vescovati. Il Papa l'avvisò che erano cosa sacra; che non si potea farne mercato; che la Chiesa dovea conferire le sedi; che doveano sortirsi a successori degli Apostoli i chiamati da Cristo per mezzo delle canoniche elezioni: il re ripugnava: andare e venir lettere, ambascerie (1): Pasquale immobile come scoglio; S. Anselmo allora primato d'Inghilterra, con lui. Questo santo Arcivescovo avea già sofferto troppe persecuzioni ed esiglj per la libertà da Guglielmo immediato predecessore di Enrico: questi richiamatolo dal bando per politica, accoltolo con onoranza: ma nol potutolo corrompere, nè aver mai da lui l'omaggio de' Vescovi investiti da mano regia. A finire il dissidio con Anselmo, nuova ambasciata è spedita al Pontefice, tre Vescovi pel re, e due monaci pel primate. Ritornano senza nulla ottenuto. In presenza de' Vescovi e de' nobili assembrati dal re sono lette le lettere del Papa ad Anselmo piene di dignità e di costanza (2): la causa par finita, il re finalmente arrendesi. Ma che? qui appunto, nello stringere della pace, in sul restituirsi alla Chiesa i sacri suoi diritti violati, sono i tre Vescovi nunzi al Papa quelli che surgono a intorbidare ogni cosa: essi con una impudente e appena credibile menzogna rivoltano il re di nuovo nel reo partito, e mantengono la schiavitù della Chiesa. L'impostura smascherata poscia e punita di scomunica fu questa. Essi asserirono, il Papa aver loro parlato segretamente, dando licenza al re di fare quello che proibiva nelle sue lettere, e non averlo egli voluto mettere in iscrittura, acciocchè gli altri principi non togliessero occasione di volerne il medesimo (3). In vano i due monaci compagni di ambasceria protestano, negano il fatto: vilipenderli, opprimerli. Così perì allora ogni speranza di concordia, e non fu ostinazione del re, ma nequizia di Vescovi adulatori, simoniaci, infamemente perduti.
Egli è dunque una evidente ingiustizia degli storici moderni l'abbandonar che fanno il merito della questione, per trattenersi in un punto accessorio di procedura, quando dimenticano la causa per la quale si combatteva, e tutti sono occupati de' combattenti. I combattenti o i capi de' combattenti erano i Papi ed i Sovrani; ma la causa per la quale si combatteva era quella del Clero, pugnando i primi per volerlo restituire all'antica virtù e dignità, i secondi per mantenergli i vizj: sicchè i principi non erano, per così dire, che condottieri al soldo della feccia del ceto ecclesiastico, il quale sotto il loro scudo, siccome fa sempre, cercava anche allora l'impunità.
(2) Queste lettere di Pasquale ad Anselmo dicevano: «Egli è ben noto alla tua sapienza con che efficacia, robustezza e severità abblano i Padri nostri combattuto ne' preteriti tempi coutro quella VELENOSA RADICE DI PRAVITA' SIMONIACA, l'investitura. In tempo di Urbano, signore e predecessore nostro di una memoria degna in Cristo di riverenza, fu raccolto presso Bari un venerabil Concilio di Vescovi ed Abati venutivi da varie parti, e in esso la tua Religione e Noi stessi siamo Intervenuti, come quelli ch'erano allora con noi ben si ricordano, e contro quella peste fu pubblicata la sentenza di scomunicazione. E noi pure, che abbiamo lo stesso spirito de' Padri nostri, lo stesso sentiamo, e le stesse cose testifichiamo». Questa lettera ha la data degli 11 dicembre dell'anno 1102.
(3) Ecco quello che Pasquale rispose come ebbe udita l'infame menzogna de' tre Vescovi cortigiani: «Noi chiamiamo in testimonio contro l'anima nostra Gesù che sсruta le reni e i cuori, se dall'istante che abbiamo pigliato la cura di questa santa Sede giammai un così immane delitto ci sia nè pur in mente disceso. E guardici Iddio, che non ne veniam mai di soppiatto infetti, a tale che una cosa pronta abbiamo in bocca, e un'altra nascosta nel cuore; quando contro a' mendacl profeti fu vibrata l'imprecazione: «Disperda il Signore tutte le labbra dolose». Che se pur tacendo sofferissimo che la Chiesa venisse macchiata col fiele dell'amarezza, e colla radice della empietà, in che maniera potremmo noi scusarci innanzi all'eterno Giudice, mentre il Signore in ammaestramento de' Sacerdoti ha detto al Profeta; «Ho posto Te a speculatore sulla Casa d'Israele»? Non ben custodisce la città colui che posto nella rocca, mentre non bada, espone la città ad a esser presa da' nemici. Ora se una mano laica dà il segno del pastorale uffizio la verga, e il segnacolo della fede l'anello, che fanno oggimai nella Chiesa i Pontefici? L'onore della Chiesa è a terra, il vigore della disciplina soluto, ogni cristiana religion conculcata, ove noi sofferiamo che la temerità de' laici presuma di far ciò, che noi sappiamo esser a' soli Sacerdoti dovuto. No, non è de' lalci tradir la Chiesa, nè cosa da figli macchiare d'adulterio la madre — poichè ai laici appartiene difendere la Chiesa e non tradirla. In vero Ozia tirando a sè illecitamente l'ufficio di Sacerdote, fu percosso di lebbra. Anche i figliuoll d'Aronne imponendo sull'altare un fuoco straniero, furon consunti dalle fiamme divine ecc.». E seguita a provare l'Illiceità che il principe conferisca a suo libito i vescovati, scomunicando in fine gl'impostori e quelli che erano stati intanto dai re investiti delle sedi episcopali.
94.
Che dunque? Conveniva che il Capo della Chiesa si lasciasse impaurire dalla forza bruta di cui disponeva il Clero corrotto? Conveniva che l'animo de' successori di San Pietro venisse meno considerando la difficoltà dell'impresa? O che all'aspetto de' mali che sarebbero nati dalla invincibile caparbietà degli ecclesiastici ricusanti gli avvisi e le leggi salutari, si fossero ritratti dal provvedere alla salute della Chiesa da Dio loro affidata e già venuta nell'estremo pericolo! Potcva essere una tale viltà d'animo degna de' sovrani Pontefici? O ∙non dovevano questi con tanto maggiore grandezza d'animo e spirito di sacrificio accingersi a quell'opera, che la fede nella parola di Cristo loro diceva dover essere in fine di certissimo riuscimento?
D'altro lato, quando mai si operò una grande riforma sulla terra, senza grandi scompigli? Quando si distrusscro degli abusi universalmente invalsi ed inveterati, senza ostacoli e contraddizioni? Un popolo ha egli mai racquistato la perduta dignità senza sacrifizj? S'è mai resa felice una nazione, se non in passando per grandi sventure? sostenendo le prove più dure? E la cattolica Chiesa, questa comunanza di popoli, avvilita, schiava, si pretenderà che potesse farsi risorgere dal profondo dell'abbiezione, e ridivenire libera, senza una grande scossa, una grande sociale agitazione? Non sanno dunque ciò che si dicano quelle testicciuole che con tanta confidenza di se stesse tolgono pur a sindacare quei grandi, i quali furono destinati dalla Providenza i primarj conduttori delle cristiane nazioni, e da essa incaricati della riformazione della umanità.
95.
Io interrogo degli storici i più nemici de' Pontefici, degli scrittori protestanti; ne dimando Hume e Robertson; e questi non possono a meno di riconoscere il fatto, che «il risorgimento della umana società venuta all'estrema degradazione, non pur della Chiesa, coincide coll'epoca del Pontificato di Gregorio VII (1)». Bastava un occhio non infetto dal colore di passione, ad accorgersi che questa coincidenza non è casuale, e che ella si spiega mediante quegli atti umani e sublimi del Pontefice, contro i quali essi tanto declamano, e che pure, considerati nel pieno de' loro effetti, sono indubitatamente ridondati non meno in pro della Chiesa che della civil società, la causa delle quali è associata, o piuttosto una ed indivisibile. Ma il nostro argomento non riguarda che la libertà della Chiesa nelle elezioni de' Vescovi (2), e perciò restringiamoci pure a queste sole.
(2) Ricerca utlie insieme e profonda sarebbe «l'esame de' sentimenti di giustizia, di equità e di umanità che Gregorio VII ispirò nella società imbarbarita, e le utill conseguenze che ne provennero». Per esempio, in un Concilio tenuto in Roma egli ebbe cura di fare una legge in favore de' naufraghi, ordinando: «che a qualsivoglia spiaggia approdassero, fosse rispettato il loro infortunio, e la persona e la roba de' naufraghi nessuno di toccar si attentasse» — ut quicunque naufragum quemlibet et illius bona invenerit, secure tam eum quam omnia sua dimittat (Concil. IV Rom. sub Gregor. VII). Questa è una di quelle leggi d'umanità che passarono nel diritto pubblico comune di Europa.
96.
Il grido di libertà mandato da Gregorio riscosse la Chiesa di Dio da quella specie di assopimento da cui s'era lasciata prendere; parve un grido nuovo, dilettevole, utile: la fede, la giustizia, la dignità della Chiesa, come faville spente si riavvivarono a quel soffio in tutti i petti; e le Chiese particolari, i prelati quanti ne rimanevano di santi nella Chiesa, risposero all'appello (1), si arruolarono al segno della causa comune, ripeterono le antiche dichiarazioni e proteste contro le usurpazioni secolari, in iscritti e in canoni, i quali sì nulli o radi apparivano nel secolo precedente (2).
Manifestamente l'opera fu guidata da Dio. E qual umano consiglio poteva soccorrere in tanto estremo della Chiesa? Onde trovare un uomo quasi direi singolare nelle storie, e dopo trovatolo, collocarlo sulla sedia apostolica, che a un mondo vecchio e marcito osasse di comandare una piena riforma, che affrontasse tutte le potenze, e i nemici intestini, che in pochi anni con undici concilj colpisse tutti i disordini più solenni e più inveterati, e ne ripurgasse la Chiesa, e che lasciasse finalmente in eredità a' suoi successori delle massime rese da lui evidenti e precise, che uniche poteano reggere il governo combattuto della Chiesa? Onde, se non per divino consiglio, poteva ordinarsi altresì quella lunga serie di Pontefici che succedettero al settimo Gregorio, i quali furono un Vittore III, un Urbano II, un Pasquale II, un Gelasio II, e un Calisto II, partecipi dello spirito di fortezza e di rettitudine di quel grande, in cui come in padre e in maestro comune tutti risguardavano (3), i quali continuassero la grand'opera dell'affrancamento delle elezioni, e dell'appuramento de' costumi, senza che pur un solo smentisse se stesso, o mutasse la via sicura che trovava tracciata dinanzi a se (4)? Nè meno ci voleva: chè fu solo una continuazione di sforzi, una quasi ostinata perseveranza nelle stesse massime, più durevole della vita di un solo uomo, un'infaticabile, coraggiosa predicazione della verità fatta con apostolico petto da molti Pontefici seguiti, che parevano un Pontefice stesso vivente in tutti immortale, com'era uno stesso il pontificato, che potè rompere i pregiudizj, dominare le passioni, e far penetrare fin negli animi de' sovrani la forza lenta della ragione, e piegarli finalmente sotto Cristo, come avvenne quando rinunziarono solennemente alle loro usurpazioni il 1122 a Wormazia, e l'anno seguente nell'ecumenico Concilio di Laterano, quarantanove anni appunto dopo che Gregorio VII avea anatematizzato la prima volta l'abuso delle investiture! E chi altri se non la divina Providenza mise finalmente il perfezionamento e il suggello alla grand'opera, quando per un abbattimento d'imprevedute circostanze e casi condusse Ottone IV nel mille duecento e nove, Federico II nel 1213, e nel 1220; e finalmente Rodolfo I nel 1275 a rinunciare agli abusivi diritti di regalia, di spoglio, e di deporto, che ancora impacciavano non poco la libertà della Chiesa?
(2) Ecco alcuni canoni di Concilj tenuti dopo che Gregorio innalzò il vessillo della riforma e della libertà, ancora prima che spirasse il secolo XI.
Il Concilio di Clermont nell'anno 1095 fece i due Canoni, 15. Nullus ecclesiasticum aliquem honorem a manu laicorum accipiat — 18. Nullus presbyter capellanus alicujus laici esse possit, nisi concessione sui Episcopi.
Il Concilio di Nîmes dell'anno seguente 1096 fece il Canone 8. Clericus vel Monacus, qui ecclesiasticum de manu laici susceperit beneficium, quia non intravit per ostium, sed ascendit aliunde sicut fur et latro, ab eodem separetur officio.
Il Concilio di Tours dell'anno stesso 1096, can. 6, Nullus laicus det vel adimat Presbyterum Ecclesiæ sine consensu Præsulis.
(3) Nella Professione di fede fatta da Pasquale II nel Concilio di Laterano l'anno 1112, dice quel Pontefice: che abbracciava i decreti de' Pontefici suoi predecessori, et præcipue decreta Domini mei Papa Gregorii VII, et beatæ memoriæ Papæ Urbani: quæ ipsi laudavernut, laudo; quæ ipsi tenuerunt, teneo; quæ confirmaverunt, confirmo; quæ damnaveruut, damno; quæ repulerunt, repello; quæ interdixerunt, interdico; quæ prohibuerunt, prohibeo in omnibus, et per omnia, et in iis semper perseverabo.
(4) Tutti questi Pontefici, anche quelli fra essi che poco regnarono, combatterono con gran fortezza e magnanimità per la libertà delle elezioni, tennero de' concilii, fecero de' decreti. Essendo impossibile esporre tutte le loro azioni, riferirò qui solamente alcuni de' principali decreti da essi pubblicati.
Vittore III, sebbene non vivesse che due anni, tenne però un Concilio a Benevento nel 1087, ove pubblicò il seguente decreto: «Stabiliamo altresì, che se quinci innanzi taluno riceverà di mano di laica persona un vescovato o un'abbazia, egli non s'abbia in modo alcuno in conto di Veseovo o di Abate, nè si renda a lui come a Vescovo o ad Abate riverenza. Di più, noi interdiciamo a costui il gremio del Beato Pietro, e l'ingresso della Chiesa fino a che pentito non abbandoni il posto che ha ricevuto con sì grave delitto di ambizione e d'inobbedienza, che è idolatrica scelleratezza. Simigliantemente stabiliamo degl'inferiori gradi e dignità della Chiesa. Ancora, se qualche imperatore, re, duca, principe, conte, od altra qualsivoglia potestà secolare presumerà di dare il vescovato, ad altra dignità eccleslastica qualunque, sappia d'essere stretto col vincolo della sentenza medesima. Conciossiachè i trecento e diciotto Padri del Concilio di Nicea hanno scomunicati i venditori e compratori di tal fatta, giudicando che sia anatema e quegli che dà e quegli che riceve».
Urbano II vindicò la stessa libertà delle elezioni in tre Concilj che tenne, a Melfi, a Clermont, e a Roma, gli anni 1089, 1095, e 1099. Ecco due Canoni del secondo di questi Concilj.
1.º «La Chiesa cattolica sia casta nella fede, e libera da ogni servitù secolare».
2.º «I Vescovi, gli Abbati, o altri del Clero non ricevano alcuna ecclesiastica dignità dalla mano de' principi, e di qualsivoglia altra laica persona».
Pasquale II oppose all'abuso della schiavitù delle elezioni vescovili i decreti di otto Concilj da lui celebrati, cinque in Roma, gli anni 1102, 1105, 1110, 1112, 1116, gli altri tre a Guastalla, a Trozes, e a Benevento, gli anni 1106, 1107, 1108. Egli è incredibile con quanta magnanimità, equità e dolcezza questo Pasquale II combattè per la libertà delle elezioni, la munì, la vendicò. Nel Concilio di Guastalla si parla in modo, che apparisce come gli sforzi de' Papi cominciavano già a raccogliere qualche frutto nella riforma della Chiesa. Eccone un brano: «Già è gran tempo, che da uomini perversi, tanto chericl quanto laici, la Chiesa cattolica veniva conculcata; di che nacquero ne' tempi nostri molti seismi ed eresie. Ora poi per grazia divina venuti meno gli autori di cotale nequizia, ella risorge ad ingenua libertà. Laonde provveder conviene, acciocchè le cagioni di tali scismi rimangano pienamente distrutte. Il perchè consentendo noi alle costituzioni de' padri nostri, proibiamo al tutto che si facciano le investiture da' laici. Che se v'avrà alcuno violatore del presente decreto, siccome reo d'ingiuria nella madre sua, se Cherico sarà rigettato dalla partecipazione della sua dignità, se laico, sarà rispinto da' limitari della Chiesa».
Gelasio II vessato, scacciato da Roma, perseguitato come i suoi predecessori difese virilmente per la vita la causa stessa.
Calisto II, al quale riuscì dopo incredibili sforzi di conchiuder la pace, dimettendo Enrico V le investiture, prima le avea con solenne decreto condannate nel Concilio di Relms numeroso di 420 Padri. E gioverà qui riferire le parole del Vescovo di Chalon nunzio del Papa all'Imperatore. Sottoscritti i patti in presenza di molti testimonj, negava l'imperatore audacemente d'aver promesso cosa alcuna. Il nunzio, dopo convintolo di mala fede colla scritta di suo pugno, e tutti i testimonj presenti che deponevano contro a lui, gli prese a parlare in una forma da fargli ben chiaro conoscere il vero stato della questione: «Sire, gli disse, quanto a noi, tu ci troverai puntualmente fedeli in tutte le nostre promesse. Poichè nostro Signore il Papa non attenta già di diminulre in cosa alcuna la condizione dell'Imperio o la corona del regno, come alcunl seminatori di discordia vengono straparlando. Anzi dinunzia egli a tutti pubblicamente che a te debbano servire per ogni maniera in prestar la milizia e tutti gli altri servigi, ne' quali furono soliti di servire a te e a' tuoi antecessori. Che se tu giudichi diminuirsi la condizione del tuo regno con questo che tu non possa più d'ora in avanti vendere i vescovati, egli è tal giudizio sì falso, che anzi avresti dovuto considerar ciò come un aumento e un vantaggio del regno tuo, e come tale sperarlo, giacchè si tratta che tu per amore di Dio quelle cose abbandoni, le quall appunto al Signore Iddio sono contrarie». Ecco quello di che unicamente si trattava: si possono sfidare tutti i sofisti moderni a provare che il Papa volesse nulla di più.
97.
Si può dire che la Chiesa; e la Santa Sede che la guidava, avesse pienamente trionfato colle promesse giurate da Rodolfo in Losanna, e tutto prometteva che la libertà delle elezioni oggimai fosse stabilita per sempre, e che indi si dovesse attendere il rifiorimento universale del gregge di Gesù Cristo.
Ma fu allora che l'inimico dell'uman genere trovò un nuovo e più sottil mezzo d'intorbidare la pace e la prosperità della Chiesa, e questo fu, debbo dirlo? le smoderate Riserve. La prevalenza che la Santa Sede avea acquistata con un trionfo così giusto e così puro sopra le potenze del secolo, la affidò di tanto; le sue necessità quasi ve la costrinsero, ed altre cause più deplorabili entrarono in parte di sì grave mutazione di disciplina. Non già che la Santa Sede non abbia diritto di riserbare le elezioni a sè, ove uno straordinario bisogno l'esiga: non manca a quella Sede mai il diritto, diciamolo ancora, di salvare la Chiesa, ma furono le riserve ordinarie e universali che sollevarono contro essa tutti gl'interessi. Le querele cominciarono quasi a un tempo colle riserve, e già nel secolo XIII, per far tacere gl'Inglesi, Gregorio IX dovea promettere che non conferirebbe più benefizj di patronato secolare (1). Poco dopo si richiedeva al Concilio di Lione un provvedimento (2); e non ottenutolo, da per tutto venne meno il rispetto dovuto alla madre di tutte le Chiese, e atti ostili uscirono contro di essa. In Inghilterra Eduardo III annullava le provisioni pontificie (3). In Francia il Clero gallicano faceva decreti da se stesso, coi quali imponeva leggi al Papa, e Carlo VI nel 1406 gli abbracciava que' decreti come leggi dello Stato. Se il Concilio di Costanza, pressato da tutte parti a dar di piglio alle riserve pontificie, se ne rattenne per un cotal resto di riverenza verso il supremo Gerarca, succedette ben presto quello di Basilea più impaziente e più ardito, e ne fece man bassa: e i decreti di Basilea contro le riserve, le grazie aspettative e le annate, si accolsero come piovuti dal Cielo dalla Francia che li avea provocati, e nel 1438 passarono nella troppo famosa prammatica sanzione. La Germania ne imita l'esempio tosto dopo nel 1439: e poco appresso cedendo sempre più i sommi Pontefici, si compongono le discordie coi concordati di Eugenio IV e di Nicolò V degli anni 1446 e 1448 (4). L'abuso questa volta era dalla parte della Chiesa: dobbiamo confessarlo coi sommi Pontefici stessi, che ne convennero ingenuamente. E così l'affare delle riserve andò a finire in modo, che la Sede apostolica per cagione di esse fu tanto umiliata, quanto era stata prima gloriosamente innalzata pel trionfo da lei riportato nell'affare delle investiture.
(2) Ann. 1245.
(3) Ann. 1343.
(4) Il primo di questi due concordati fu conchiuso a Francfort, e il secondo in Aschaffenburg sotto Federico III.
98.
Ma ciò che v'ha di più deplorabile, sono le conseguenze funestissime che lasciò questo affare nella Chiesa anche dopo che fu in qualche modo terminato. La guerra delle investiture era stata più procellosa, è vero; ma le ferite sue erano di una natura più benigna, e più facili ad essere rammarginate. Roma brillava, in quel suo combattimento, di tutto lo splendore della giustizia, della magnanimità e del disinteresse, e la sola forza bruta, la sola scostumatezza e la menzogna era contro di lei (1). Non così nell'affare delle riserve. A tutte le nazioni, alle Chiese, a' principi, in quest'ultimo affare parve non vedere attivo in Roma che un basso interesse. Ciò non irritava tanto gli animi, quanto li disgustava; ed è assai men dannosa l'ira, che il dispregio; è assai men perdita quella de' beni temporali esposti alla violenza della persecuzione, che quella della propria morale dignità. Pur troppo la Providenza divina, che volea ripurgare dalla cupidigia quella prima Sede cui non abbandona giammai, dovette farle subire la prova più amara e la più rigorosa. Ella permise che quella cupidigia fosse vinta per le vie della violenza, dell'odio e del dispregio: e pur troppo ella non cede giammai se non al peso della forza che l'opprime. Ma la sconfitta di Roma lasciò negli animi impresse disposizioni a lei sì contrarie, che la Chiesa di Gesù Cristo ne rimase oltremodo indebolita. Questa circostanza fu quella che sommamente favorì le eresie del secolo XVI: queste trovarono i principi allassati e illanguiditi nella stima e nell'amore della santa Sede, perchè di lei scandalezzati, però non disposti a sostenerla; se non anco lieti di vedere brulicare degli audaci ribelli di mezzo al Clero stesso contro i Papi, che intonassero libertà da di sotto al giogo vecchio e nojoso. Quella libertà intanto che veniva intonata, era licenza: e diceva di più che i principi non potessero intendere allora: era l'indipendenza della ragione naturale da ogni rivelazione positiva: era quel razionalismo fatale che, come un germe di morte, venne sviluppandosi gli anni vegnenti nella gran pianta dell'incredulità, la quale aduggiò la terra, mutò i costumi sociali, scrollò i troni, e rese pensosa l'umanità su' suoi futuri destini. La rivoluzione di Francia e d'Europa rimonta a sì alti principj.
99.
Un'altra conseguenza dell'affare delle riscrve oltre a ogni dire funesta, fu, come abbiamo accennato, la nominazione de' Vescovi ceduta a' principi secolari (1), colla quale venne scemata la libertà delle elezioni, che era pure costata sì magnanimi sforzi, sì lunghi pericoli, sì estremi travagli a un Gregorio VII, e per de' secoli a' suoi invitti successori. Diremo che nel Concordato di Bologna del 1516, per conservare alcuni vantaggi economici, Roma abbia ceduto una parte di questa preziosa libertà? Nol diremo noi giammai; nè ci scapperà dalle labbra una parola di biasimo sopra un atto che fece con grande maturità di consiglio Leone X, e che udirono leggere gli orecchi de' Padri di un Concilio generale (2), Ma chi ci impedirà però di deplorare le tristissime circostanze de' tempi, che resero, siccome un minor male, necessaria una sì onerosa convenzione? Chi ci terrà dal lagrimare la dura sorte della sapienza di un tanto Pontefice, e di un tanto Concilio, a cui toccò di dover pure abbandonar di nuovo al potere laicale una gran parte di quella preziosa libertà delle elezioni, per rivendicare la quale dei secoli interi di agitazioni e di atroci discordie in tutta la Chiesa e in tutto il mondo erano stati riputati bene impiegati?
(2) È fino lepida questa frase di Natale Alessandro parlando delle elezioni: Jus plebis in Reges Christianissimos ECCLESIÆ GALLICANÆ LIBERTATIBUS et antiquo more ab Ecclesia tacite saltem approbato transfusum est. (Hist. Eccles. In sæc. 1 Dissert. VIII). Belle libertà quelle che assudditano la Chiesa di Dio a' principi temporali! Si dovrebbero ben con ragione chiamare «la servitù della Chiesa Gallicana».
100.
Se la potenza di fatto de' Romani Pontefici avea toccato, come dicevamo, il suo sommo, dopo composto l'affare delle investiture; era all'opposto fino allora venuta cadendo la potenza de' principi temporali. La nobiltà, coll'occasione appunto di quelle discordie, erasi sollevata contro di essi, e qua e colà s'era affrancata del tutto, formando in Europa de' nuovi e minori principati. Ma dall'epoca della pace ristabilita, mentre la potenza papale, ritornando indietro dal suo apogeo, per così dire, cominciò a decadere e decadde con quel mezzo stesso col quale secondo le viste umane pareva volesse crescer vie più, cioè colle riserve ed altre funzioni che a sè veniva traendo, le quali empivanla d'oro; le potenze temporali all'incontro mettevano a profitto quel tempo di riposo a riparare le loro perdite, e niente trascuravano di quanto potesse aumentare la loro possa ed autorità. Nel secolo XV finalmente, un principe crudele, e che non conosceva ostacolo di onestà, Luigi XI, insegnò in Francia a tutti i principi dell'Europa ad abbassare con forti colpi e crudeli la nobiltà, e rendere il dominio reale assoluto; e tale politica fu in sostanza ricevuta da tutte le corti, sebbene non con ardimento uguale di aperta tirannia; e fu continuata con perseveranza, fino che Francesco I e Carlo V finirono di porre le basi della grand'opera, che dava alla sovranità in Europa una nuova forma e natura. Con questi ultimi sovrani ebbero a trattare i Pontefici del secolo XVI; e il risultato di tali trattative si fu, che convenne abbandonar loro di bel nuovo una porzione della libertà delle elezioni, cioè la nomina alle sedi vescovili, riserbata alla santa Sede la sola conferma. Questo modo di disciplina, che è in sostanza se non le riserve stesse divise fra i sovrani ed i Pontefici? E questa disciplina è quella che vige tuttavia, e che va affondando incessantemente una delle più acerbe e lamentevoli piaghe della crocifissa Sposa di Cristo.
101.
E non tutti il veggono: egli pare che non essendo ceduta al potere temporale che la sola nominazione, riserbata al Pontefice la conferma, quella non troppo pregiudichi alla ecclesiastica libertà.
Ma questa ragione che si fa militare a favore della presente disciplina, sarebbesi ella riputata per altro, in tempi migliori, che per un cotal velo che ricuopre e non toglie la piaga, e, se mi si permette il dirlo, per una delusione diplomatica?
lo ne dubito fortemente. Veggiamo qual'era la maniera di pensare della Chiesa circa le elezioni prima di quest'ultimo stato della disciplina; e cerchiamo d'inferirne il giudizio che farebbero gli antichi prelati, della nominazione de' Vescovi abbandonata in mano della laica potestà.
In quel tempo in cui il poter laicale veniva crescendo nella sua costante impresa d'invadere le elezioni, e con esse la libertà della Chiesa, cioè nel secolo IX (e nel susseguente, l'usurpazione giunse al suo colmo); un passo di questa progressiva invasione fu di esigere, che l'elezione non si facesse se non dopo dimandatone ed ottenutone il permesso a' principi, come abbiamo veduto. Direbbesi, diplomaticamente parlando, ciò non toccare la libera elezione. Pure, che ne parve alla Chiesa d'allora? Ebbe a dirittura tale pretensione de' sovrani, qual violazione di sua libertà. L'Arcivescovo Incmaro ed altri prelati di quel tempo, vedemmo quanto s'opposero robustamente a un tal ceppo messo alle Chiese in quella occasione dichiarando che «il dover una diocesi prima di passare all'elezione del suo pastore dimandarne licenza al principe, lo considerano siccome una necessità di eleggere quello che al principe ne piacesse». Così stimavasi allora un tale attentato. Or poi che avrebbero detto i prelati di quella età, se in vece che del chiedere puramente la licenza di eleggere, si fosse trattato che il principe stesso nominasse a dirittura la persona da eleggersi? Non avrebbero temuto ancor più, che la cosa andasse a finire, così che per Vescovi s'avessero quelli che al solo principe ne piacesse d'imporre alle Chiese? E che la conferma pontificia riuscisse una formalità, la quale non si ricuserebbe giammai solo che la persona eletta fosse immune da pubblici delitti? E basta questa immunità da delitti pubblici, perchè la Diocesi abbia quel Vescovo che più le conviene? che più desidera? E se i desiderj delle Chiese non sono consultati, se esse non sono udite, che libertà ecclesiastica rimane, o almeno a che pro la libertà rimane?
102.
Un altro passo che diede in quel secolo il potere laicale, che stava in ascendere nella sua influenza sulle elezioni, si furono le regie preghiere. Che più innocente di una semplice preghiera? sforza essa? non possono gli elettori non udirla? Or bene. Che ne parve allora alla Chiesa? Il celebre S. Ivone di Chartres, quel Vescovo così amante della buona armonia fra lo Stato e la Chiesa (1), così conciliatore, riputava la preghiera regia un annientamento della ecclesiastica libertà (2), e con lui fortemente protestavano contro di quella i più intelligenti e santi prelati di quel secolo IX. Ma or si consideri: è egli più il solo manifestare un suo desiderio, come faceva allora il principe agli elettori, in favore di una persona, o il nominare a dirittura una persona di suo piacere? E se quella semplice manifestazione del desiderio sovrano avevasi per un attentato contro alla elezione canonica, or dov'è andata questa libera elezione, quando i principi nominano i Vescovi? e i Pontefici altro far non possono in ogni caso, che negarne la conferma? La qual conferma forse in tutti i casi possono liberamente ricusarla i Pontefici? No; ma primieramente non mai altro che allora quando il nominato abbia sopra, come dicevasi, un grave delitto; e non sempre nè pure allora; ma quando questo delitto sia potuto pervenire fino agli orecchi del Capo della Chiesa; non basta, di più è uopo che questo delitto sia provato sufficientemente. Nè questo è ancor tutto: conviene che il Pontefice, con negare la confermazione, non tema per avventura d'irritar troppo il monarca, non tema di far nascere un male assai maggiore nella Chiesa e questo dipende dal temperamento de' principi, dalla loro religione e più ancora da' ministri che li dirigono. E quanto non dee mai poter esser facile ad alcun principe l'incutere questo timore nell'animo del Pontefice? massime in tempi d'incredulità, di freddezza, di ostilità universale contro la Sede apostolica? Dove riman dunque ne' tempi nostri una verace libertà, e non di forma solamente, nelle elezioni de' Vescovi? Che avrebbe detto adunque di un tale stato della Chiesa l'ecclesiastica antichità?
(2) Si veggano le lettere LXVII, LXVIII e CXXVI di questo gran Vescovo. Egli nella lettera CII dice a dirittura, che non licet regibus, sicut sanxit octava Synodus, quam romana Ecclesia commendat et veneratur, ELECTIONIBUS EPISCOPORUM SE IMMISCERE.
103.
Si pare, che io non misuro la libertà che rimane in questi tempi alla Chiesa, colle massime de' primi sccoli: ml contento di chiamare a confronto il modo di pensare de' primi prelati del secolo IX, secolo di sonno per così dire, in cui il Clero snervato era già pressochè assuefatto alla servitù dei sovrani. E tuttavia in quel secolo si conosceva ancora che cos'era libertà, e in che consistesse. Ora poi veggiamo qual fosse il pensare del secolo susseguente, nel quale la Chiesa scosse il giogo obbrobrioso dalle sue spalle, e in cui santissimi e fortissimi Papi resero la libertà ecclesiastica lucente siccome il sole. Veggiamo che direbbero que' grandi Pontefici dello stato nostro, in cui non si fanno, in gran parte delle nazioni cattoliche, altre elezioni vescovili, che quelle che i sovrani da sè fanno; e se miseri o felici se ne riputerebbero. Basteranno due fatti.
L'orribile persecuzione di Enrico V contro Pasquale II, il carcere, le ignominie, gli stenti, la prossima morte, le stragi della città e del territorio romano, gli sforzamenti, i rubamenti, l'infelicità de' buoni senza schermo in preda a sfrenatezza di barbare milizie non guidate ma incitate dall'ira di uno spergiuro imperatore, che poterono ottenere finalmente dal magnanimo Pontefice? Un privilegio d'investire i Vescovi delle rendite episcopali colla verga e coll'anello; ma a condizione che questi Vescovi fossero prima eletti canonicamente, liberamente, senza simonia, senza a violenza (1)», e apposte altre condizioni ancora che ristringevano il privilegio. E parve ad Enrico d'averla spuntata, carpendo all'oppresso Pontefice un privilegio di tal natura. E pure il privilegio non conferiva punto nè poco facoltà all'imperatore d'ingerirsi nelle elezioni nè nella ordinazione, e solo quella di acconsentirvi, e di mettere l'eletto in possesso del vescovato. Or che perciò? Tutta la Chiesa parve si sollevasse contro Pasquale, acclamasse aver egli diminuita l'ecclesiastica libertà, e minacciava uno scisma. E perchè? per aver conceduto al re solo di fare una cerimonia poco conveniente, quella cioè d'investire il Vescovo colla verga e coll'anello, segni della episcopale giurisdizione. E pure il re protestava che non intendeva dare con quella cerimonia al Vescovo se non il possesso de' beni temporali (2): ma non s'appagò di questo la Chiesa: conciossiachè il bastone e l'anello erano veramente simboli di qualche cosa di più, e l'investitura tenea seco la necessità dell'assenso del principe, acciocchè l'eletto entrasse Vescovo: indi d'ogni parte Concilii, prelati, assemblee di Cardinali contro la concessione strappata al Papa, e fin minacciossi di torsi dall'ubbidienza di quel Pontefice santissimo. Per acquetare tanto subbollimento di animi non ci volle meno dell'eroica umiltà del Pontefice. Egli riconobbe d'aver trapassato i limiti del dovere: raccolse un Concilio nella Basilica di Laterano, vi si presentò come reo, accusò se stesso, depose le insegne pontificie, dichiarò esser pronto di rinunziare al pontificato per dare soddisfazione alla Chiesa, e commise la propria correzione al giudizio de' Padrí. E «quello scritto, egli disse, che io feci senza il consiglio o le sottoscrizioni de' fratelli, stretto da grave necessità, non per cagion della vita, della salute e gloria mia, ma per sole le strettezze della Chiesa, nel quale nessuna condizione o promessa ci obbliga, siccome io lo conosco per mal fatto, così per mal fatto lo confesso, e desidero al tutto, col divino ajuto, di correggerlo: e il modo di una tal correzione io lo rimetto al consiglio e al giudizio de' miei fratelli qui convenuti; acciocchè non nasca forse per ragion d'esso in avvenire qualche danno alla Chiesa, o qualche pregiudizio all'anima mia». Il Concilio, esaminato l'affare, pronunciò poscia questa sentenza: «Quel privilegio, che non è privilegio, nè dee dirsi tale, che fu estorto dalla violenza del re Enrico per la liberazione degl'imprigionati e della Chiesa, dal Signore Pasquale Papa; Noi tutti congregati in questo Concilio col Signore Papa medesimo lo condanniamo di canonica censura, e coll'ecclesiastica autorità, per giudizio dello Spirito Santo, e lo dichiariamo irrito, e del tutto il cassiamo, e sotto pena di scomunica sentenziamo che non abbia nè molto nè poco di autorità e di efficacia». E di una simigliante sentenza si dà la seguente ragione: «Per questo egli è condannato, che in esso privilegio si contiene che quegli che è canonicamente eletto dal Clero e dal popolo, da nessuno sia consecrato prima che dal re non venga investito. Il che è contro lo Spirito Santo, e l'istituzione de' Canoni (3)».
In tal modo que' Padri, e tutta la Chiesa d'allora non giudicava tollerabil cosa, che un Vescovo, sebbene eletto legittimamente dal Clero e dal popolo, avesse bisogno dell'assenso e dell'investitura del principe per dover essere consecrato. Or che ne sarebbe loro paruto, se Pasquale avesse anzi distrutta la libera elezione canonica, privilegiando l'imperatore di tanto, che solo un suo nominato potesse essere consecrato Vescovo? O non avrebbero stimate troppo più deplorabili di quelle in cui si trovava Pasquale (4), le circostanze del secolo XVI, nelle quali un Pontefice era condotto a tal termine di stimare minor male alla Chiesa di Dio il concedere che i Vescovi venissero nominati da un principe secolare, che non patirsi le conseguenze di un tale rifiuto? lo m'astengo da sopraggiungere altre riflessioni a questi fatti, ma credo che pur meritino una profonda meditazione.
(2) Non Ecclesiæ jura, non officia quælibet, sed regalia sola se dare assereret (Henricus). Così attesta Pietro Diacono Lib. IV Chronici Cassinensis, Cap. XLII.
(3) Et hoc ideo damnatum est, quod in eo Privilegio continetur quod electus canonice a Clero et populo, a nemine consecretur nisi prius a rege investiatur. Quod est contra Spiritum Sanctum et canonicam institutionem. Doppio era il difetto che si trovava in quel privilegio: 1.° che il Vescovo non potendo prendere il governo della sua Diocesi senza l'assenso del re, e quindi potendo esser negato dal re per capriccio o per volontà di nuocer alla Chiesa; questa venia indi inceppata nell'uso del suo ministero, che per autorità ricevuta da Gesù Cristo ha diritto di esercitare in tutto il mondo liberamente; e però Innocenzo II diceva che al dissenso del re conveniva badare ove fosse motivato sopra giuste ragioni e giuridicamente provate, e non altramente; 2.º che quella parola investitura conteneva un equivoco; giacchè «investire un Vescovo» pareva significare conferirgli la giurisdizion vescovile; il che era certo eresia, l'attribuirlo alla laica potestà, e contro lo Spirito Santo. Ai che si potrebbe aggiunger per 3.º, che il mettere un Vescovo in possesso de' beni liberi del vescovato, è ingiustizia e soperchieria se vuol farlo il re di propria autorità, e non per un privilegio accordatogli dalla Chiesa che è proprietaria de' beni suoi. All'incontro giustizia era, che il re per propria autorità investisse il Vescovo de' beni feudali; giacchè in proprietà diretta di questi beni rimane sempre al principe, e il feudatario non ne ha che il dominio utile. Ma queste due specie di beni si confusero insieme dalla giurisprudenza di quel tempo, come abbiamo osservato; e tutti i beni della Chiesa si fecero passare per feudall: il che non avvenne tanto per l'avidità personale de' regnanti, quanto per la natura di que' governi, sotto i quali le proprietà tutte non erano egualmente difese, ma meglio delle altre eran le regie: dal qual vantaggio dei beni feudali sopra gli altri trassero l'origine i feudi oblati.
(4) Questo Pontefice condannò se stesso in un altro Concilio tenuto nella Basilica Laterana l'anno 1116. Quanto non sono commoventi le circostanze ch'egli descrive narrando come fosse indotto a quella condiscendenza verso di Enrico! e quanta umiltà e dignità insieme non ispirano! «Dopo che, dice, il Signore ebbe fatto quel che gli piacque col suo, e dato me e il popolo romano in mano del re, io vedeva farsi ogni giorno, senza posa, rapine, incendi, stragi, adulterj. Tali e somiglianti malori io pur desiderava di rimuovere dalla Chiesa e dal Popol di Dio: e ciò che feci, per la liberazione il feci del popol di Dio: Il feci da uomo, perocchè sono polvere e cenere. Confesso di aver male operato; e deh voi tutti innalzate suppliche a Dio per me, che mi perdoni. E quello sgraziato scritto, che fu fatto nelle tende militari, e che a sua ignominia dicesi un sacrilegio, io il danno sotto un perpetuo anatema, acciocchè a niuno riesca mai di grata ricordanza, e prego voi tutti di fare il medesimo». E tutti acclamarono: «Sia così, sia così». Ora sì triste eircostanze poterono ottenere da Pasquale tal cosa, che è certamente, se non erro, un niente verso la nominazione regia ceduta a' principi quattro secoli dopo.
104.
E si desuma il giudizio che avrebbe fatto la Chiesa che viveva nel secolo XII, della nomina regia, da un altro fatto avvenuto sotto Innocenzo II. Morto l'Arcivescovo di Burges, Luigi VII lasciava ampia libertà al Clero e popolo di quella Chiesa di eleggersi il suo Prelato; solo apponeva condizione, che non si volesse eleggere Pietro di Castra, e avea giurato di non volerlo Vescovo. L'elezione cadde nulladimeno su di lui. L'eletto fu a Roma, il Papa lo inaugurò, senza ammettere l'eccezione del re «e giudicando non vi fosse vera libertà di elezione ove il principe potesse eccettuare alcuno di suo volere, almeno se non provasse innanzi a un giudice ecclesiastico che all'eletto mancassero le condizioni necessarie per eleggersi, nel qual caso il re, come ogni altro fedele, doveasi ascoltare (1)». Or non trattavasi qui che di lasciaro al re l'esclusione di una persona, e questo ancora riputavasi da que' gravissimi Pontefici violazione della ecclesiastica libertà: perocchè la libertà è cosa dilicatissima, e riman veramente d'ogni poco vulnerata. Or che dunque al giudizio di un Innocenzo II sarebbe paruto, se trattato si fosse di dare al re non l'esclusione di una sola persona, in una sola diocesi, e per un solo caso accidentale; ma bensì la nominazione di tutti i Vescovi del suo regno per sempre? Dove sarebbe andata agli occhi suoi la libertà della Chiesa, per que' tempi ne' quali si fosse intavolato un tal progetto, ed avesse avuto luogo? Nè si faccia insulto alla memoria di que' sommi Pontefici che sì nobili e vere idee conservavano della libertà, di cui Gesù Cristo ha decorata la Chiesa sua (2), dicendo che il loro modo di pensare era esagerato, come prontissima è sempre a dire l'ignoranza e la cupidigia umana. Perocchè io mi appello a qualsivoglia de' più grandi e santi e discreti uomini che fiorissero nella Chiesa in questi tempi: io mi appello a un S. Bernardo, il cattolicismo del quale veniva recato a modello dallo stesso Napoleone; e il discretissimo Abate di Chiaravalle non la intendeva punto diversamente da Innocenzo II; e in supplicando a lui di voler condiscendere per una volta a Luigi VII; col lasciar eleggere alla Sede di Burges un altro Vescovo fuor di Pietro di Castra, non disconveniva però punto nè poco da' sentimenti del Pontefice. Perciocchè sebbene fosse lealissimo e liberissimo il sant'uomo nel modo di scrivere a Roma, tuttavia in questo negozio egli toglie ad intercedere pel re così scrivendo a' cardinali: «Di due cose noi non iscusiamo il re; dell'aver giurato illecitamente, e del perseverare nel suo giuramento ingiustamente. Ma ciò egli fa non di volontà, ma per verecondia. Perocchè egli reputa ignominioso (siccome ben sai) presso i Franchi non mantenere il giuramento, tuttochè abbiasi pubblicamente giurato male (quantunque niun savio dubiti che i giuramenti illeciti non han vigore). Ma nulladimeno confessiamo di non poterlo scusare nè anco in ciò: nè noi togliam punto a scusarlo, ma domandiamo perdono per lui. Considerate voi se mai possa scusarsi in qualche modo l'ira, l'età, la maestà. E si potrà, se voi vorrete che la misericordia sia esaltata sopra il giudicio; intantochè s'abbia qualche riguardo ad un re e fanciullo per forma, che per questa volta gli si perdoni con un cotale temperamento, che non abbia mai a presumer cotanto per l'avvenire. E appunto gli si perdoni, io vorrei dire, s'egli è possibile. Rimanendosi però salva in tutte le sue cose la libertà della Chiesa, e conservando la dovuta venerazione all'Arcivescovo consecrato dalla mano apostolica. Questo è quello che lo stesso re umilmente dimanda, questo di che tutta la nostra già troppo afflitta Chiesa supplichevolmente vi prega (3)». Non trovava adunque S. Bernardo che si potesse scusare un principe, il quale intervenisse nella elezione de' Vescovi coll'escludere pur una persona di quelle che potrebbero essere elette: e riconosce in ciò una ferita dell'ecclesiastica libertà. Or secondo questi principj, che sono inmutabili nella Chiesa di Dio, che cosa divengono le nomine regie? Il tempo nel quale esse sono introdotte si dovrà dire tempo di libertà e di servitù? Dovranno i figliuoli della Chiesa rallegrarsi, o piangere del loro secolo?
(2) Nè queste idee vennero mal meno, nè posson mancare nella Chiesa, perchè sono eterne come la verità. Per conoscere che nel secolo XVI i romani Pontefici non pensavano diversamente da tutti i secoli precedenti, basta osservare che Giulio II immediato predecessore di Leone X conferì talora de' Vescovati contro la volontà del re, come in fine del secolo precedente avea fatto Innocenzo VIII col vescovato di Angers. Senza entrare a vedere se ciò fu lodabile (il che a noi non ispetta indagare); certo però una tale condotta de' Pontefici dimostra quali sieno le idee vere e immutabili sulla libertà della Chiesa.
(3) Ep. CCXIX.
105.
Ma per conoscere via più la natura maligna di questa piaga della Chiesa, si consideri che colla nominazione regia si sono abbandonate tutte le massime più reverende che la Chiesa in tutti i secoli avea seguitate circa le elezioni, e delle quali s'era mostrata oltremodo gelosa. Si considerino queste grandi massime (perite in quanto al loro uso nella Chiesa l'anno 1516, ma vive però sempre nel desiderio), una ad una.
Massima inviolabile della Chiesa si fu che «a Vescovo venga eletto il migliore di quanti se ne possono avere»; e questa massima è giusta, evidente, conforme ad un'alta idea del vescovato. Non tiene la Chiesa, che aver vi possa una certa determinata dose di dottrina, di bontà, e di prudenza, la quale possa esser bastevole ad un tanto ufficio, sicchè il di più sia soverchio; ma anzi tutti i pregi di un uomo quantunque molti e grandi sieno, gli pajon poco a quel carico, che si diceva «pauroso ad omeri d'Angelo». Però non potendosi avere chi si adeguasse a tanta dignità, si voleva almeno eletto Vescovo il migliore di tutti fra quanti si potessero rinvenire (1).
Ora il concordato che stabilisce la nomina regia fu necessitato di sostituire all'antica un'altra massima, cioè che il nominato debba essere «un uomo grave, maestro in teologia o in diritto, e che almeno abbia ventisett'anni (2)». Non più dunque il migliore si richiede, ma un uom sufficiente. Vero è che il principe, a cui è rimessa la nomina, non è sciolto dall'obbligo di eleggere il migliore; ma qual garanzia ne ha la Chiesa? la Chiesa nol può rigettare, se non nel caso che «il nominato non sia uomo grave, e maestro in teologia, o dell'età prescritta». Qual garanzia ne ha la diocesi particolare alla quale è destinato? quando questa se lo eleggeva, ella se ne assicurava da se stessa; quando gli era dato da' Vescovi provinciali, o dal sommo Pontefice, era al fin sempre la Chiesa cattolica che ne faceva la scelta; ed ella sapeva, ella dovea sapere quello che le conveniva; in caso contrario faceva male a se stessa, nessuno le facea ingiuria. Ma venendole imposto, dee prenderselo, purchè egli sia sufficiente. E che vuol dire uomo grave e laureato in teologia? Che, vuol dire un uomo di ventisette anni? Quando anco il processo che ne fa la santa Sede avanti di confermarlo, fosse una garanzia alla Diocesi, che cosa garantirebbe questo processo? Che il vescovo è un uomo grave, è un laureato. E dee poter bastare ciò ad una Diocesi? ogni uomo grave ed ogni uom laureato sarà un Vescovo conveniente per essa? Ove anche mi astenga dal dimandare se sarà il più conveniente; quanta latitudine non lasciano queste parole di uomo grave, e di dottore, e di ventisett'anni? Quale e quanta gradazione fra uomini gravi? quanta diversità di dottrina fra quelli che hanno ricevuto l'alto onore della laurea? Ci fermiamo noi a parole, o guardiam le cose? Confidiamo nelle nostre Università? la dottrina delle quali è ella tutta piovuta dal cielo? sarà la dottrina di Salomone? è da per tutto buona, sicura? In fine adunque a che ci ridurremo, se non ad aver de' Vescovi, il cui pregio sarà negativo, cioè che saranno uomini a cui non si potrà trovare alcuna grave, pubblica macchia? L'ispezione della santa Sede certo non può andar più oltre, e se potesse e volesse, la sua battaglia co' principi sarebbe continua: il Vescovo adunque è finalmente eletto, non perchè in lui si accumull il maggior numero di pregi, ma perchè non v'è crimine, o a dir più veramente, accusa certa contro di lui. Ora una tale bontà negativa basta ella a formare non dirò un buon Vescovo, ma nè pure un buon cristiano?
Questa dottrina appartiene alla costante tradizione della Chiesa. Ecco il discorso che nel secolo IX il Visitatore, cioè quel Vescovo che venia mandato dal Metropolitano e dal principe a presiedere alle elezioni, faceva all'assemblea degli elettori: «Noi vi comandiamo d'ordine sovrano, e per quella fede che avete giurato di serbare a Dio e al signore imperator nostro Lodovico, e acciocchè voi non cadiate in quella gravissima sentenza di condannazione, sotto quel terribile anatema che ci chiama tutti dinnanzi al tribunale del giudice, che non vogliate nasconderci chi sia quegli che in questa congregazione voi conoscete PEL MIGLIORE, PEL PIÙ DOTTO, E PIÙ ORNATO DI BUONI COSTUMI — ut eum quem meliorem et doctiorem et bonis moribus ornatiorem in ista Congregatione conversari noveritis, nobis eum non celare dignemini». (Inter formulas promotionum Episcopalium).
(2) Queste sono le parole del Concordato.
107.
Un'altra massima inviolabile della Chiesa circa la elezione de' Prelati, fu sempre «che fosse eletto un Sacerdote conosciuto, amato e voluto da tutti quelli a cui egli dee comandare (1)»; il che è quanto dire da tutto il Clero e popolo della Diocesi a cui è destinato. Può avervi adunque una persona fornita di rari pregi, e non bastare ancora ad essere il Vescovo in una Diocesi, secondo le sante e antiche massime della Chiesa, o sia per esservi ignoto, o per non avvenirsi al carattere di quelli che debbon essere suoi sudditi, o per esservi mal voluto da loro. Una Chiesa è come una persona che ha confidenza in un ministro dell'altare, e non in un altro; e il suo desiderio di avere a Padre e Pastore colui in che ella ha più di confidenza, è ragionevole e buono; e perchè non sarà soddisfatto? Ora se il principe nomina il Vescovo, il comun voto resta le più volte inadempito. La massima adunque piena di prudenza e di carità, che la Chiesa ebbe sempre nella nominazione de' Vescovi, è sovvertita.
108.
Una terza massima invariabile nella Chiesa fu quella, che «a Vescovo si eleggesse un Sacerdote, che fu lungo tempo ascritto al Clero della Diocesi che dee governare, e non mandatovi nuovo da straniero paese (1)». Chi è vivuto e per così dire invecchiato nella Diocesi, conosce le cose, le persone, i bisogni ed i mezzi convenienti a soddisfarvi; è conosciuto e stimato pe' lunghi servigi da lui prestati; è già antico padre di quel popolo, antico confratello di quel Clero; ed oltre la luce delle sue virtù, il debito della gratitudine alle sue lunghe fatiche, e la stessa dolce consuetudine con lui, gli legano tutti gli animi, e glieli inchinano a riverenza. Or anche questa massima sì luminosa, sì evangelica, rimane soppiantata colla regia nominazione. Egli è ben naturale; il re che nomina, non può, o non vuole badare, o finalmente non bada a queste cose; e manda alla Diocesi le persone a lui ben volute, d'onde che sia, e non solo da fuor di Diocesi, ma da fuor di Provincia, ma fino d'altro clima e nazione. Ora uno straniero, fors'anco con altro linguaggio in bocca, fors'anco d'un paese abborrito per le rivalità nazionali, fors'anco non conosciuto per altra fama da quella che il dice favorito del principe, uom destro, e buon cortigiano, sarà egli questi il confidente, l'amico di tutti? sarà quel padre riverito da cui sono stati generati molti, e a cui molti si dieno ad essere rigenerati? Qui non si tratta di sapere se un popolo di santi potesse santificarsi anche sotto un tal Vescovo: piuttosto è a dire, che se si suppone un popol di santi, il Vescovo è inutile. Ma se si suppone il popol cristiano tale quale egli è, e lo si vuol ridurre a praticare il Vangelo, altri Pastorl e non cotali, ci bisognano. Se poi si voglia sbattezzare il mondo, seguiti a far così, e vedremo quanto a lungo i principi possano governare il mondo dopo averlo sbattezzato.
109.
Si dirà: un buon principe potrà da sè mantenere in qualche modo queste massime della sacra antichità, alle quali la Chiesa non può in alcun tempo rinunziare. Ma in tal caso perchè la Chiesa non ha fatto il patto che i principi nascano sempre buoni?
Di poi, ove anco il principe sia buono, si pretenderà da un laico, sparso in tante cure e in tante delizie quante gliene apportano il temporale governo e l'uso della corte, ch'egli sia un profondo teologo? Che conosca le massime più gravi e più profonde della ecclesiastica disciplina? che ne senta la suprema importanza? e che abbia uno zelo apostolico da preferirle ad ogni altro interesse? e da tenerle ferme contro la seduzione, l'adulazione, il raggiro, le passioni cupe, infaticabili, turbinose di tutti quelli che lo circondano? dal cui consiglio, e dal cui ministero dipende? E chi presumerà mai tanto di un povero mortale?
Diasi anche questo nuovo portento; egli non basta. Oltre saper le massime inviolabili della ecclesiastica disciplina, e volerle mantenere, egli dovrebbe poterlo. Ma a poterlo, converrebbe ch'egli conoscesse ogni Chiesa particolare, altrettanto come ogni Chiesa particolare conosce se stessa; dovrebbe trasformarsi egli in ogni Chiesa, dopo essersi trasformato nella Chiesa universale. E chi non sente l'impossibilità di ciò fare? Ma finalmente, senza andare più in lungo, basterà a illuminar la cosa un principio certissimo, confirmato dalla esperienza universale, e risultante dalla natura umana, e da quella delle cose, che è il seguente: «Ogni corpo o persona morale, in generale parlando, è la sola atta a giudicare quello che meglio gli convenga», perchè è illuminata dal proprio interesse, del quale non si dà scorta più sicura e più vigilante. Qualunque eccezione si voglia dare a questa legge, che presiede a tutte le corporazioni, a tutte le società, ella si troverà sempre vera in generale, e più vera che mai parlando della Chiesa, l'interesse della quale è spirituale e morale, e però diritto e semplice, coerente a se stesso, e pieno di luce. Or da ciò risulta, che se le Chiese ricevono da altri i loro Pastori, questi non potranno giammai essere loro dati con quella quasi infallibilità di giudizio, colla quale esse le chiese li potrebbero dare a se stesse, e se li sono dati per tanti secoli; e ciò è sufficiente a conoscere, che il loro diritto in tal modo riman pessundato; imperciocchè come si può negar al popolo di Dio il diritto di aver il miglior Pastore possibile?
La Chiesa che elegge il proprio Pastore ha un interesse solo, quello delle anime; il principe ne ha molti. È egli verisimile che il principe fra' suoi molti interessi, e fra i molti interessi de' suoi aderenti faccia dominare sempre nella nominazione de' Vescovi come supremo l'interesse della Chiesa? È egli possibile che nel suo animo il pensiero del ben della Chiesa sia continuamente presente e cosi forte da lottare con tutti gli altri pensieri e vincerli? Quale eroe, quale apostolo non sederebbe allora sul trono?
Il principe dovrebbe contentarsi che il Vescovo fosse un suddito fedele a tutte prove; ed è impossibile che nol sia, se sarà un uomo santo, pieno il petto dello spirito del Vangelo e della Chiesa. Ma egli non deve esigere nulla di più dal Vescovo; non dee esigere che il Vescovo sia un suo agente secreto, e se mi si permettesse di dirlo, un misero impiegato di polizia. Ciò snaturerebbe il carattere Vescovile, e violerebbe la massima fondamentale dell'Episcopato. «Niuno che militi a Dio, s'implica di negozj temporali»; massima sì delicata, che si viola fin co' pensieri. In somma v'ha differenza fra la fedeltà evangelica che nasce dalla coscienza e che ha per fondamento la rettitudine della giustizia, e la fedeltà politica che nasce da vincoli di umano interesse, e non intende alla giustizia, ma ha per fondamento l'utilità. Il Vescovo è l'uomo della giustizia, e dee poterlo essere liberamente; e il principe cristiano non deve istituire una speculazione nè politica nè economica sul suo sacro carattere. Ma pur quale è ła principal guida del principe, parlando di buona fede e in generale, se non la politica? E in tutti gli altri affari, fuori di quelli della Religione, potrebbe egli averne un'altra? Come adunque un tale e tanto affare, la nomina de' Vescovi, in cui niuna mira politica, ma solo una mira tutta pura e spirituale dovrebbe aver luogo, sarà egli bastevolmente assicurato, ove sia commesso alle mani di un uomo, cui le sue circostanze, le sue abitudini, l'educazione, gli esempi sforzano ad operar sempre politicamente? Dovremo aver tanta fiducia da riposarci tranquilli, non dubitando punto che appresso di lui gl'interessi della Religione non prevalgano sempre a quelli della politica? E che dico io, dicendo la politica? Non forse tal cosa che sempre è desta a trar da tutto vantaggio, che suol nutrirsi di ogni cibo, e distillare ne' suoi lambicchi tutto ciò che le venga alle mani? Ed ora il Vescovo eletto dalla politica che sarà? Lasciol pensare a chicchessia. Ha dunque bisogno la Chiesa di figli della politica?
110.
Fu un tempo, che guerra accanita si mosse dalla Chiesa alla simonia; della quale non si credeva che aver vi potesse vizio alla Chiesa o più dannoso o più obbrobrioso. Ma la simonia secreta non è ella meno per questo simonia? La simonia disguisata dalla politica è ella meno sozza e trista? La cancrena che non duole è ella manco mortale della piaga che duole e fa metter guai? E i fini temporali che si mescolano alle nominazioni de' Vescovi; e i mezzi destri pei quali ottener le sedi dal principe, sono forse altro che simonia? simonia raffinata, sì, decente, e fino modesta: non ributta colla sfacciataggine, non duole insomma: mal segno, dico io! la cancrena è fatta, e ci vuole il ferro.
Perchè mai il principe mette tanto impegno a tirare a sè le nomine de' Vescovi? è forse il bene della Chiesa che in ciò gli sta a cuore? Se questo fosse, egli è evidente che lascerebbe scegliere i Vescovi alla Chiesa stessa; perocchè è impossibile che egli presuma di poterli scegliere meglio di lei. È per aver ne' Vescovi semplicemente de' sudditi fedeli, secondo le massime del Vangelo, e secondo lo spirito della Chiesa? Se questo fosse, egli dovrebbe per ciò appunto lasciare alla Chiesa stessa l'eleggerli, giacchè più un Vescovo è degno di tal carattere, più anche è santo, più è uomo apostolico; e più è altresì fedele, di una fedeltà netta e cristiana. Badisi bene: dico fedele, anche a costo della propria vita; non dico adulatore, non dico cortigiano, non dico brigante, non dico ligio servilmente a tutti i voleri, i pensieri conosciuti, sospettati del re, del ministro, del Governo, cui pur a lui sovente toccherebbe d'illuminare e guidare col codice del Vangelo, di cui è l'interprete (1). Se non è questa la ragione per la quale il principe mette tanta importanza nell'aver in mano le nomine vescovili, egli è manifesto che cerca in esse un sostegno positivo, e non morale, ma politico della propria possanza, non divino, ma umano, un sostegno qualunque, non un sostegno puramente giusto. E non siamo con ciò nella simonia? Non è dunque simoniaca la causa, la radice delle nomine secolari ? La Chiesa non è con ciò snaturata? L'episcopale officio non è avvilito e guasto? Per vero, che se il sovrano temporale cercasse con pura intenzione il solo bene spirituale della Chiesa, quando anche toccasse a lui nominare il Vescovo, egli non vorrebbe punto fidarsi nè di sè stesso, nè de' ministri suoi; ma vorrebbe sì bene prendere a sua propria consigliera la Chiesa stessa, attenendosi fedelmente ai consigli della medesima (2).
(2) Una delle più forti ragioni per le quali la Chiesa non volle mai che dipendesse da' principi l'acquisto de' Vescovati, era perchè vedeva, ciò conceduto, rendersi inevitabile la simonia. Calisto II, nel Concilio di Reims, dove si trattò la concordia della Chiesa con Enrico, dichiarò che nulla ommetterebbe a sfrattare la simonla dalla Chiesa, quæ maxime, disse, per investituras contra Ecclesiam Dei innovata erat. Il sommo Pontefice Pasquale avea detto prima, che l'influenza laicale nel conferire i Vescovati era LA RADICE della simonia; e nel Concilio Lateranese del 1102 rinnovò la proibizione che niuno ricevesse da mani laicali nè Chiese, nè beni di Chiese: Hæc est enim, dice, simoniaca pravitatis RADIX, dum ad percipiendos honores Ecclesiæ, sæcularibus personis insipientes homines placere desiderant. Questo è un fatto che saltò agli occhi di tutti: i più santi Prelati della Chiesa non hanno cessato di deplorarlo. L'insigne Vescovo di Lucca S. Anselmo, chiama il dipendere i vescovati dalla volontà del principe, semenzajo di simonia; e non crede che potesse sussistere a lungo la Religione cristiana con una cotal disciplina. Quis enim non advertat, dice, hanc pestem seminarium esse simoniacæ hæreseos, ET TOTIUS CHRISTIANÆ RELIGIONIS LAMENTABILEM DESTRUCTIONEM? Nempe cum dignitas episcopalis a principe adipisci posse speratur, contemptis suis Episcopis et Clericis, Ecclesia Dei deseritur etc. (Lib. 11). Si voleva dunque distruggere non solo la simonia dalla Chiesa; ma anco la sua radice, anche la sua semente. E che? si perdonerà alla radice e alla semente perchè non si vede? perchè s'occulta sotterra? Tali assurdità vorrebbe persuaderci una giurisprudenza adulatrice; ma può essa durare una persuasione che non abbia il sodo della verità che la sostenga? Non può durare; perchè dee durare al mondo la Chiesa di Cristo.
111.
Ma io dico di più: il lasciare la Chiesa libera nella scelta de' suoi Pastori appartiene al vero interesse temporale del principe. Questo sembrerà un paradosso nel primo aspetto, e così l'hanno giudicato fin qui i politici volgari. Ma sollevandosi a considerazioni più elevate, facendo un calcolo degli interessi più esteso, più profondo, si termina ritrovando essere una verità di fatto, questo lieto principio: « Ciò che è giusto e conforme allo spirito della Religione cristiana, è anche più utile in generale al principe cristiano»; dico in generale, cioè supponendolo reso massima di stato. Applichiamo questo principio alla materia di cui trattiamo.
Un Vescovo che non è eletto dal principe, sarà un mediatore tra il principe e il popolo. Il principe può interamente contare su di lui, giacchè in tutti i tempi la Chiesa cattolica ha sempre inculcato ai sudditi la dottrina «che a loro non lice ribellarsi al proprio principe per qualsivoglia cagione». Il Pastore della Chiesa adunque più che sarà investito dello spirito ecclesiastico, più che sarà l'eletto della Chiesa stessa, e più altresì sarà costante nell'inculcare ai popoli la sommissione, l'ubbidienza, la sofferenza anche nelle più grandi oppressioni. Il popolo penderà dai labbri di lui che gl'insegna la mansuetudine e gliene dà l'esempio, in cui vede un uomo imparziale, un sacerdote di Cristo che non ha altro codice che il Vangelo. Ma se i Vescovi sono dati dal principe, se il popolo vede in essi altrettanti impiegati del sovrano, se li considera come parte interessata avente un medesimo interesse in solido col principe, come riceverà le loro parole? Esse perderanno tutta la forza morale; e questa forza della religione, che è pur tanta, non potrà più prestare al principe alcun servigio, giacchè quando un mediatore diventa parte, egli cessa con questo stesso d'essere mediatore. Il principe avrà bensì un sostegno politico nel Clero, in quanto è divenuto una sezione della nobiltà, in quanto conta nel suo seno de' forti proprietarj, ed ha per le sue ricchezze molte aderenze civili; ma la forza che è propria della Chiesa, la forza del Vangelo, e che è di un invincibile effetto, la forza che ha la giustizia ne' cuori degli uomini, la forza che ha Dio stesso, e che ha sottomesso il mondo, questa forza non esiste più in quei paesi dove i Vescovi son posti dai principi, e quindi il principe per avidità d'aver troppo, ha perduto il più. Bensì nasce da ciò un indicibile danno alla Religione, la quale è fatta odiosa al popolo, e partecipe di tutto l'odio che le fazioni politiche possono concitare contro i principi, e in tale stato tanto è lungi ch'ella possa sostenere il trono, che anzi non vale nè pure più a sostenere se stessa. Questo è ciò che abbiamo veduto avvenire in Francia a' giorni nostri. Quel Clero non ha potuto frenare il furore della ribellione di cui è stato la vittima insieme co' re di quella nazione, appunto per l'insolidarietà politica formatasi in quello Stato del Clero col principe, appunto perchè quel Clero fu l'eletto del principe stesso. Grande e spaventevole lezione! Era pur dotto, era pur pio, era pure eroico quel Clero intrepido che è caduto senza avvilirsi sotto la ghilliottina; e tuttavia nulla poteva in quella nazione per altro non insensitiva nè alle voci del cristianesimo, nè alla generosità della virtù. No, non bastarono tutte le doti più splendide: il Gallicanismo lo ha perduto: egli insegnava una Religione regia: egli aveva il peccato originale, poichè la voce del re lo costituiva: bastò questo perché fosse il segno di tutti gli obbrobrii e di tutte le amarezze di cui fu si abbondantemente abbeverato: quell' odio non fu odio del Clero, fu odio del re, che perseguitava anche nel Clero, e col Clero la Religione.
112.
Si faccia un'altra riflessione. Per un conquistatore, per un avventuriere che cerca di usurpare un trono, io intendo benissimo che potrà essere utile l'aver de' Vescovi che preferiscano i beni temporali alla Religione, e che vendano a lui le anime loro. Ma per un principe cristiano, riconosciuto per legittimo, io sostengo che non v'è altra utilità maggiore di quella di avere nel suo regno degli uomini spassionati, che sappiano dire a lui la verità, anche a costo d'incorrere nella sua disgrazia. Io sostengo, che per un principe cristiano non si dà utilità maggiore di quella di poter ben conoscere, e assicurarsi in che consista la giustizia, e in che consista il vero vantaggio della Religione cristiana. Ora, ciò posto, per aver sui troni della Chiesa di tali uomini integerrimi, non vi può essere sicuramente modo migliore, che il riceverli dalla Chiesa stessa, la quale ha lo spirito di Dio: quando forse non si pretenda che il governo secolare conosca ed abbia lo spirito di Dio, del Clero e della Chiesa. A tal segno io credo ciò vero, che se il principe volesse aver per Vescovi degli uomini al tutto leali, e liberi annunziatori della verità, e pur volesse e sapesse eleggerli egli stesso, dovrebbe, operando con avvedimento, non farlo che in occulto, cioè non facendo sapere a nessuno che l'elezione viene da lui, perchè il solo saperlo, basta acciocchè egli sia ingannato. Ma chi conosce il prezzo di quella modesta, ma però candida libertà evangelica, propria del carattere episcopale? Qual principe, o qual politica si leva tant'alto da potersi accorgere che quella libertà evangelica de' Vescovi impedirebbe il governo dello stato dal traboccare negli eccessi, sarebbe quella che varrebbe a trattenerlo indietro dall'orlo dell'abisso, in cui o l'inconsideratezza o le passioni de' governanti talora lo spingono? Quanti Stati sarebbero stati salvati dalle rivoluzioni e dall'anarchia, se questa preziosa libertà, vero aroma che dove si trova impedisce gli Stati cristiani dal corrompersi, fosse stata, secondo che ella si merita, apprezzata? Ma, come dicevo, in vece di calcolare il vantaggio di questo freno, che troverebbe l'ingiustizia e la passione degl'imperanti, tanto vantaggioso alla loro propria conservazione; si mette dalla inconsiderata prudenza del mondo per unico scopo della politica un cieco, illuminato, continuo aumento di potenza, e si considera come cosa antipolitica ogni limitazione messa al potere del governo; quasichè un potere dopo aver rimosso da sè ogni limite anche giusto, cioè dopo essere arrivato a poter liberamente operar tutto ciò che gli venga in mente, sia giusto o sia ingiusto, potesse sussistere; e non anzi trovasse la sua distruzione appunto in questa illimitazione di potenza. Un monarca pienamente assoluto, non potrebbe sussistere nè pure pochi giorni sul trono: e i limiti che sogna di distruggere nell'ordine del diritto, li trova raddoppiati e raggravati nell'ordine del fatto. Perciò fu osservato con avvedimento, «che quando i principi vollero scuotere d'addosso ogni soggezione alla Chiesa, essi si trovarono veri schiavi del popolo»: e questo solo spiega tutte le circostanze politiche de' nostri tempi. A dispetto delle tenebre che hanno sparse i sofisti nemici de' troni e insieme loro adulatori, e de' pregiudizj sistematici da' quali sono macchiati gli storici moderni che hanno parlato del secolo XI, io mi permetto di far qui una riflessione, e mi appello agli uomini più spassionati e più penetranti, che dicano se non è giusta, e la riflessione è la seguente: «Allo stesso imperatore Enrico IV, dico io, fu veramente giovevole anche nell'ordine temporale il Clero libero rappresentato da Gregorio VII, e in apparente opposizione con lui, mentre il Clero suo schiavo e adulatore fu la vera cagione della sua rovina». Strana affermazione; e pur facile a provarsi. Basta considerare che avvenne co' baroni Tedeschi. I signori Sassoni e Tedeschi indispettiti per le sue sfrenatezze ed estreme tirannidi, ribellandosi a lui, si lagnavano altamente della lentezza e moderazione del Papa, e minacciavano di eleggersi da sè soli un nuovo imperatore, senza aspettare il giudizio del Papa. Questi all'incontro era quegli che tirava in lungo, voleva accomodar le cose, e faceva realmente da mediatore fra il Sovrano e quei Signori, desiderando di protrarre a veder se forse Enrico rientrasse in ragione, nel qual caso prometteva anzi di sostenerlo. Se non che que' principi, menati a lungo e insofferenti, elessero, senza averne il consenso del Papa che sempre stava per la conciliazione, Rodolfo duca di Svevia, il che rese interminabile il litigio, e perdette Enrico. Ora, se Enrico si fosse tenuto al Papa, egli sarebbe stato uno de' più grandi imperatori, le dissensioni si sarebbero aggiustate appunto colla mediazione del Clero libero, che per la sua libertà era ascoltato, era atto a tale mediazione. Ma chi tolse all'incentro ad Enrico questo vantaggio? Chi lo condusse a si mal termine di morire detronizzato, ramingo, povero? Non altri che il suo Clero schiavo, a cui avea egli venduto i vescovati. Questo Clero fu che il consigliò ciecamente, non a mantenere una giusta autorità, ma ad appropriarsi ostinatamente una autorità senza freno di giustizia, un vano diritto di prepotenza che il mettesse in istato di fare così il male come il bene senza ostacolo; anzi un'autorità di far il male, giacchè quella di fare il bene da niuno gli era contesa. Questo Clero perdette dunque Enrico; un Clero fedele, non di fedeltà politica; ma di fedeltà evangelica, l'avrebbe salvato (1).
113.
Ora questa voglia di cercare nell' Episcopato un sostegno per fas et nefas, un mezzo, non che renda ai popoli riverita un'autorità giusta, ma che li faccia schiavi di un'autorità qualunque; questo principio, di cui è tanto difficile che si spogli il governo laicale, è quello appunto che il muove anche a nominare i Vescovi fatali alla Chiesa, i quali abbiano per avventura (ed oggidì non se ne può a meno), una cotale ecclesiastica apparenza, ma infatti non sieno liberi ministri di Dio, ma servi del principe vestiti da Vescovi. Perocchè la fedeltà che si cerca in essi nascendo da motivi umani, conviene aver persone le quali facciano molto conto de' beni umani, e conviene evitare diligentemente la nomina di quegli uomini eccelsi sopra tutte le cose terrene, i quali nelle ricchezze e nelle dignità che ricevono dalla mano del principe non ravvisano che una miseria loro sopravvenuta, ed un grave peso, a cui sommettono le spalle senza giubilo, ma con rassegnazione e per amore d'Iddio (1). Questi uomini evangelici, cui la verità fece liberi, sono anzi temuti dalla mondana politica, siccome scogli e impedimenti alle sue vane intraprese; e però la Chiesa ne vede sì rari risplendere (il contrario de' primi tempi) sulle sedie episcopali, e manca il mondo d'ingenui annunziatori dell'Evangelio, manca la giustizia eterna di maestri e di Sacerdoti, e mancano i principi di veramente fedeli amici e consiglieri.
E questa stessa ragione che il Vescovo dee poter essere uomo tale da render servigio leale al suo principe colla manifestazione della verità, ripruova quello che dicevo innanzi, non bastare all'episcopato degli spiriti mediocri. Troppa fortezza e troppa prudenza esige in tale ufficio. E troppa magnanimità ha comandato al Vescovo Colui che disse: «Il buon pastore dà la vita sua per le pecore (2)». Queste non sono parole di consiglio, ma di stretta obbligazione; e però quegli che sarebbe un uomo onesto nella vita comune, sulla cattedra vescovile non sarà più che un lupo, o un cane muto, come la Scrittura chiama i pastori che non sanno morire, o latrare. E qual re si fa coscienza di non nominare a Vescovo se non uomini che mostrino un petto sì integro e forte, che per non tacere all'uopo la verità, sappian morire?
(2) Jo. X, 11.
114.
Altri incomodi si aggiungono a tutti questi dalla regia nomina. I re ed i governi considerano i Vescovi come altrettanti impiegati politici, vengono guidati a sceglierli da quel sistema medesimo che prevale nel governo. Perocchè naturalmente si esige che tali Vescovi abbiano anch'essi abbracciate le stesse massime politiche. I Vescovi in questo stato di cose non possono più restarsi paghi e contenti dello studio delle eterne regole di verità e di giustizia, astenendosi dal prendere un partito nelle politiche dottrine, e contentandosi di mantenere e conservare la pace e l'amore fra gli uomini colle massime universali e divine del Vangelo. Quindi è inevitabile, ove la nominazione de' Vescovi si trovi in mano del potere laicale, che il sistema che presiede alla medesima sia variabile, come variano i principj de' gabinetti e i ministerj: che si scelgano perciò a Vescovi oggi uomini di un certo colore, e dimani uomini di un altro, senza che mai venga il tempo che si scelgano uomini candidi, e di nessun colore. Intanto a tutti gl'interessi ed alle stesse passioni private è provveduto con tali nomine, fuorchè al bene spirituale de' popoli, ed alla conservazione della Chiesa di Gesù Cristo.
115.
Io non entro ad esporre tutto ciò che avrebbe a temer la Chiesa e lo Stato medesimo dalla nomina di Vescovi, quando il sovrano sgraziatamente nascesse uno scimunito, diventasse un uomo empio, e inimico della Chiesa, o quando avesse al fianco de' ministri empj e alla Chiesa inimici. Troppo è noto che cosa è stato fatto in tali casi: come troppo è noto altresì con quanta facilità i principi sieno stati sempre ingannati dagli eretici avidi maestri di menzogna, di cortigianeria e di seduzione religiosa, dalla sottil malizia de' quali, che sempre formicolano per le corti, e in esse cercan fautori, non dico solo i mali principi, ma gli ottimi, e segnatamente quelli che del ben della Chiesa hanno più ardore, rimangano più miseramente irretiti e sedotti (1). L'eresia si mantella sotto il velo di pietà: e la teologia de' laici non è sì fina da doverla potere discoprire sì tosto: quella parla dolci parole, fomenta l'ambizione, è indulgente alle passioni molli, e nulla le costa il simulare e mentire. Quindi anche i principi ottimi nominano in tali tempi de' veri eretici che pur simulano dottrina cattolica, fino al tempo che resi forti, e già guastata la nazione, depongono anche le apparenze, traendosi la maschera dal volto. Tutte queste cose sono nelle storie recenti della Chiesa. Ma io parlerò di un pericolo ancor più tremendo perchè più occulto, o piuttosto di un male presente.
116.
Una infaticabile potenza lavora oggidì e da molto tempo in ogni angolo della terra, per diffondere i semi più velenosi di scisma nella Chiesa di Dio. Si è fabbricato pur troppo un sistema scismatico; ma lo scisma non si vede ancor punto, perocchè non si vede mai fino che non è scoppiato; e intanto i fautori (molti de' quali sono in buona fede) di questo sistema, parlano delle parole le più seduttrici ed insidiose negli orecchi di tutti i principi dell'Europa, e fanno loro sventuratamente credere, che quel sistema sia un baluardo necessario della loro autorità e potenza, ed enunciano il sistema contrario, che è il cattolicismo, colle accuse le più ingiuriose, spacciandolo siccome una pura umana invenzione, un maligno trovato dell'ambizione del capo della Chicsa. E come non resteranno sedotti i monarchi? Possono essi avere tanta penetrazione, tanta spassionatezza, tanto amore della verità, che formino un giudizio retto fra il sistema scismatico di cui parliamo, e la vera dottrina della Chiesa? Certo nol possono; e per essi a trovare il vero non ci ha altra via, che quella di serrare gli orecchi ai dottori particolari e senza missione, e aprirli ai pastori della Chiesa, ma ascoltando questi secondo il grado che viene loro assegnato dall'ordine gerarchico, credendo finalmente alle parole di Cristo, il quale ha detto, che la sua Chiesa l'ha edificata sopra di Pietro; parole che saranno d'inescusabile condanna a que' principi, i quali avranno preferito la voce di un altro maestro a quella del Capo della Chiesa. Pur troppo ogni principe ha i suoi teologi, pur troppo crede di essere giustificato dinanzi a Dio seguendo forse i consigli di qualche Vescovo del suo regno. Ma che? In qual circolo vizioso s'involge egli? Non è egli, che ha nominati questi Vescovi? Non è egli, che fa scelta di que' privati teologi? Or s'ella è così, come potrà assicurarsi di udir da essi la voce di Dio? Come saprà che è la Chiesa che gli parla? Questa Chiesa, se vuol udirla, dee essere la Chiesa libera, e non la Chiesa serva; deve esser la Chiesa nell'ordine della gerarchia, e non può essere un membro della Chiesa allorchè si trova in contraddizione col tutto. Altramente non vi sarà opinione, per quanto strana si voglia, che non si possa giustificare mediante il voto di teologi privati, o di Vescovi ligi al principe. Non così la verità viene a galla. Il principe non troverà ne' suoi consultori che se stesso, o i loro interessi. Intanto però il sistema scismatico di cui parlo è prevaluto pur troppo, e prevale universalmente. Or quale mezzo più sicuro di farlo prevalere più e più, della nominazione de' Vescovi nelle mani de' principi? Egli è evidente, che ove sieno i principi imbevuti di questo scismatico sistema, essi nominano a Vescovi persone, delle massime de' quali sieno prima bene assicurati. E perchè questo scisma sta coperto come fuoco sotto la cenere; egli è evidente che nè pure il papa, colla riserva della confermazione de' nominati a Vescovi può ovviare a questa secreta distruzione della Chiesa; e le ritrattazioni, le dichiarazioni, i giuramenti non sono che palliativi inetti: a chi non ha coscienza, a chi fa la professione di sedurre, d'ingannare, sono mezzi acconcissimi al loro fine. Non avesse mai l'esperienza comprovata questa triste verità! Ma quando tutto il regno non avrà che Vescovi di tal natura, lo scisma, ad ogni poca occasione che nasca, sarà già fatto e consumato, senza riparo, nè ostacolo alcuno. Se la Chiesa scismatica di Francia manifestatasi nell'occasione del concordato di Napoleone con Pio VII, fu la porzione minore della Chiesa di quella nazione, ciò si deve alla felice incongruenza di quel Clero singolare, il quale per un orgoglio nazionale mise le basi in Europa del sistema scismatico di cui parlo, e per un sentimento più retto di pietà, non fu fedele nella pratica alla sua vana teoria. E se quella piccola Chiesa scismatica non valse a turbare e conquassare tutta la Chiesa di quella nazione, e anco la Chiesa universale, come sarebbe avvenuto in altre circostanze, ciò fu unicamente per un tratto della divina Providenza, la quale permise che la politica di quell'uomo potente che dominava allora in Francia, e che tutto aveva a sè sottomesso con verga di ferro, fosse associata colla vera Chiesa e col sommo pontefice, rimanendo così impotente, ma non umiliata per questo, nè sommessa la scismatica fazione (1).
117.
Per quanti possano entrar disordini ed abusi nelle elezioni fatte dalle Diocesi o dalle provincie particolari, questi saranno sempre parziali, la corruzione che ne seguirà non si estenderà a tutta la nazione, non sarà fatta almeno dietro un sistema prestabilito, non sarà un principio di malizia infernale che regga tutte le elezioni e che influisca direttamente al pervertimento degli interi regni. Ma data la nomina ad un principe, che terribile potenza di fare il male non è messa nella volontà di un uomo solo! Data la nomina ad un gabinetto, che spaventevole potenza non viene con ciò costituita fuori della Chiesa, potenza che colla sua terribile azione sopravvive alle persone de' principi, durando altrettanto quanto appunto le massime adottate da' gabinetti!
Pur troppo lo scisma è già avanzato! secretamente son poste le prime pietre di lui per tutta l'Europa e son ben altro che le pietre, su cui s'innalza il tempio del Signore!
Ora ov'è, in circostanze così fatali per la Chiesa cattolica, chi non se ne dorma un sonno tranquillo! Tutto va bene, a giudizio de' prudenti di questo secolo. A giudizio d'altri ancor più prudenti, è necessario che i cattolici non abbiano la temerità di parlare: conviene osservare perfetto silenzio per non eccitare inquietudini e rumori disgustosi: e tutto quello che può recar turbazione, non è che imprudenza e temerità. Tale specie di prudenza è l'arma più terribile di que' che minano la Chiesa; essi la minano sordamente: e chi denunzia la loro mina, chi rivela il tradimento, sono i turbolenti, sono i perturbatori della società. Intanto la Chiesa geme, e con troppa ragione può dire le parole del Profeta «che nella pace la sua amarezza s'è fatta amarissima». Indi è, che se qualche voce, interrompendo il silenzio di morte, s'innalza a parlare de' mezzi di salute che restano alla Chiesa, mirate onde viene: essa esce da qualehe semplice fedele. Tutto al più sarà qualche povero sacerdote che ha tanto di coraggio. Ed erano due poveri sacerdoti, sia lode al vero, quelli che ultimamente, togliendo almen l'occasione da quella rivoluzione che in Francia rinnegò la Religione cattolica per religione dello Stato, osarono presentarsi supplichevoli ai Vescovi della loro religione, e sottopor loro queste riflessioni sulla nomina a' vescovati:
«Fin a tanto che», (dissero essi, rivolgendo il discorso a' Vescovi della loro nazione), «i capi della Religione sono uomini di sua scelta, essa Religione non ha nulla a temere. Nè la persecuzione, nè la fame la uccideranno; nè la persecuzione, nè la fame hanno fatto perire le Chiese d'Oriente, di Germania e d'Inghilterra; esse sono perite per l'intervento corruttore del potere nella formazione dell'episcopato: sia che i Vescovi abbiano venduto di loro piena volontà la propria indipendenza, sia che abbian forse ignorato fino a quale segno uomini liberi e credenti possano spingere la resistenza a delle sacrileghe volontà. Ora la vostra volta è venuta, o sacrate reliquie de' nostri Vescovi, la vostra volta è venuta di sostenere questo attacco sordo della autorità. Hanno già percorso coll'occhio le vostre teste incanutite nelle precedenti sventure; hanno contati i vostri anni, e si sono seco medesimi rallegrati: perciocchè certo è il tempo dell'uomo. Di mano in mano che voi vi spegnerete, collocheranno essi sulle vostre sedi de' preti onorati di loro confidenza, la presenza de' quali decimerà le vostre file, senza distruggere ancora l'unità. Un residuo di pudore sarà più tardi scancellato dai loro atti; l'ambizione sotterra stringerà degli orribili contratti; e l'ultimo di voi morendosi potrà discernere sotto l'altar maggiore della sua Cattedrale convinto che i suoi funerali sono i funerali di tutta la Chiesa di Francia».
118.
Che dunque? sarà la Chiesa abbandonata? Non resta dunque speranza che il cattolicismo risorga dall'oppressione? che sieno ritornate libere le elezioni vescovili, senza le quali la Chiesa non può sussistere? No, non ve n'ha: tutta la forza è dalla parte dello scisma; dalla parte della Chiesa non v'ha che debolezza. Nè i Vescovi, nè lo stesso sommo Pontefice può rimediare al male, considerate le circostanze presenti: non v'ha dunque un potere nelle mani dell'uomo, acconcio a tanta impresa. V'ha bensì la persuasione, v'ha la parola ´d'Iddio: ed ella dee essere intimata anche al mondo che la rifiuta; e gl'inviati del Signore che la intimano, hanno salvate, intimandola, le anime loro, che perderebbero tacendo. Ma non è nuovo questo stato della Chiesa: altre volte la Chiesa non vedeva speranze di sorte alcuna negli uomini, o piuttosto non le vede mai; chè la Providenza di sopra degli uomini, vuol riserbare ogni gloria a sè sola; e dee essere esaltato il solo Capo invisibile della Chiesa, Gesù Cristo. Egli trionferà quando i suoi nemici appunto credono d'aver consumato la loro vittoria, e quando a' suoi fedeli è venuto meno ogni soccorso, fuori di lui.
Fu particolarmente nella libertà delle elezioni, senza la quale la Chiesa perisce, che si vide sempre sopra tutti i pensamenti degli uomini risplendere l'onnipotente providenza di Colui che ha ricevuto dal Padre ogni potestà in cielo ed «in terra».
119.
Il popolo cristiano, e la nazione cristiana membro di questo popolo, ha una costituzione di diritto veramente divino, cioè di fatto; perocchè i fatti sono di diritto divino, giacchè è Dio, solo Dio il guidatore di tutti i fatti. Guai a chi la tocca questa costituzione! guai a quella nazione che ne infrange le leggi! i mali traboccheranno su di lei in sì gran copia, ch'essa non cesserà d'essere agitata e lacerata fino a tanto che non è ritornata indietro e non ha ristabilita la Costituzione di cui parliamo. Ecco quali sono le leggi semplici, universali, immutabili di questa costituzione.
Insiste essa su due perni, 1.º un diritto supremo, 2.º un fatto universale che è il risultato di tutti i fatti: cioè v'ha primieramente un potere supremamente legislatore, o, se più si vuole, un potere che annunzia le somme leggi, ed un potere che le sanziona; questi due poteri non si uniscono mai in una sola persona, ma essi appartengono sempre a persone diverse. Mi spiego.
Nel mezzo del popolo cristiano è posta una voce incessante che annunzia la legge evangelica, che è la giustizia completa. Questo ufficio è commesso alla Chiesa; esso è il potere legislatore o promulgatore delle leggi. Ma onde trae la sua sanzione? la sanzione dico non di un'altra vita, ma della presente? La Chiesa è inerme (intendo di armi materiali) e il carattere essenziale di lei si legge espresso nelle parole colle quali Cristo diede agli Apostoli la missione: «Ecco che io mando voi come agnelli nel mezzo dei lupi (1)». La sanzione temporale non è di sua natura nelle mani della Chiesa v'ha un altro potere: Iddio ha divisa la legge dalla sua sanzione. Commise l'annunziar quella alla Chiesa, e a sè solo ha riserbato il sanzionarla anche temporalmente, acciocchè nissun uomo possa gloriarsi, o dominare sui suoi simili: non la Chiesa, per la sua debolezza fisica; e meno ancora il governo temporale, perocchè la forza bruta non può esser cagione di gloria per l'uomo. E tuttavia Iddio non sanziona temporalmente la legge della Chiesa in generale co' miracoli: egli anzi ha per così dire organizzata nel suo popolo la sanzione della legge annunziata dalla Chiesa, cioè egli ha costituito il popolo de' credenti in cotal modo da trovarsi nella felice necessità di dover sanzionare egli medesimo la legge divina: così il potere che sanziona la legge l'ha ceduto al suo popolo: ciò che son per dire darà luce a questa affermazione, che non dee insospettire nessuno.
Nel popolo cristiano, cioè in ogni nazione che gli appartenga, appariscono sempre tre poteri di fatto: il poter supremo o governativo, il potere degli ottimati, o nobili, e il potere della plebe. Egli avviene che ove l'uno di questi tre poteri si rende colpevole, trovi una opposizione ed anco la sua punizione negli altri due, i quali allora si collegano insieme per difendere la giustizia contro il terzo potere che ne infrange le leggi. Ciò che dico avvenire, lo ripeto, non appartiene che al fatto storico, ed io mi astengo al tutto, in questa esposizione di ciò che avviene, da ogni questione di diritto. Perchè ciascun potere sia ritenuto in questa soggezione, che lo impedisce dal peccare impunito, è manifestamente necessario che due dei tre poteri sopra indicati sieno sempre più forti del terzo, perocchè allora solo la loro alleanza temporanea in favore della giustizia è la sanzione della giustizia medesima. Ora una tale sanzione tanto più sarà efficace, quanto i due poteri collegati riescano più forti del terzo lasciato a se stesso, e la giustizia rimarrà tanto più protetta ed assicurata. Perchè poi la colpa contro alla giustizia può cadere in ciascuno de' tre poteri, la migliore ripartizione della forza in favore della giustizia è indubitatamente quella «per la quale in qualunque caso la sanzione della giustizia contro il potere prevaricante riesca la massima possibile»: onde viene la conseguenza, che la ripartizione della forza più favorevole alla giustizia nel popolo cristiano, sia quella che stabilisce un perfetto equilibrio di forze fra i tre poteri, di modo che ciascun potere abbia un'eguale quantità di forza, avvenendo allora, che ogni prevaricazione dell'uno o dell'altro potere trovi contro di sè negli altri due una opposizione che lo soverchia di lunga mano, cioè che sta a lui come due ad uno. Il perchè se egli avvenga che l'uno de' tre poteri si renda più forte degli altri due insieme presi, allora v'è la tirannia, almeno in potenza: se avviene che due poteri si colleghino insieme a favore dell'ingiustizia, e in oppressione della minorità, cioè del terzo potere, vi è congiura contro lo Stato. Ma se tutti e tre i poteri sono congiurati contro la giustizia, ciò che non avverrebbe in oppressione di se stessi ma della Chiesa, allora è il tempo in cui quella nazione perde il cattolicismo, e più tardi esce anco dal cristianesimo. Queste sono le tre malattie radicali della società civile cristiana. A che poi sia riserbata una nazione staccata dalla Chiesa, e così sottratta al magisterio della verità, è difficile il dirlo: ella non appartiene più al popolo di Dio di cui parliamo; essa si è messa nell'ordine delle nazioni infedeli, o almeno dee terminare con mettervisi, e le nazioni infedeli sono soggette a de' mali loro proprj: essa riceve in sè qualche cosa di più funesto ancora delle nazioni infedeli, cioè una legge di degradazione che non ci lascia predire, ove la condurrebbe, se altre cause non perturbassero la sua azione infaticabile; perciocchè non v'è ancora nelle storie un esempio di nazione che abbia esauriti tutti i cangiamenti a cui una legge sì fatale incessantemente la impinge, e che venuta a certi estremi non sia tornata indietro impaurita, come da un abisso che vide spalancatosi innanzi, riavvicinandosi alla Chiesa cattolica, anche rientrando in essa. Lasciando perciò questo caso di morte per apostasia, e tornando agli altri due mali delle nazioni cristiane, la tirannia, e la congiura contro lo Stato, dico che la nazione cattolica affetta da questi due mali, non cesserà dall'essere agitata, fino a che non avrà espulso dal suo seno il germe del suo tristo malore, e non avrà ristabilito la legge della sua costituzione divina, consistente in trovarsi due dei tre poteri sempre più forti del terzo solo, quindi sempre atti a sanzionare in ogni caso la giustizia dal terzo violata.
120.
Ora di questa costituzione appunto, propria degli Stati cristiani, sempre usò la Providenza per francare le elezioni de' Vescovi, quando l'uno dei tre poteri attentò di usurparsele. Fu un tempo in cui la nobiltà impediva la libertà delle elezioni, tutto mettendo in opera per diventarne essa stessa l'arbitra. Allora la divina Providenza si servì de' sovrani d'accordo colla plebe per rivendicare alla Chiesa il suo diritto, e ritornar libere le elezioni (1). L'abuso altre volte fu nella plebe; e questo pure fu tolto venendo la Chiesa ajutata dai sovrani e dalla nobiltà (2). Immortali beneficj che i pii monarchi resero alla Chiesa, e de' quali la Chiesa fu e sarà memore fino alla fine de' secoli! Finalmente i Monarchi stessi invasero e tiranneggiarono orribilmente le elezioni, e ciò diede occasione alla grande lotta che cominciò ai tempi di Gregorio VII, nella quale la Chiesa fu rivendicata dalla nobiltà e dal popolo, contro l'usurpazione de' sovrani. Umiliati i sovrani, sollevò il capo di nuovo la nobiltà, ma più destramente s'impossesso delle elezioni non meno che delle sedi vescovili, conducendo le cose in modo, che escluso il popolo e la maggioranza del Clero, le elezioni dipendessero da' Capitoli cattedrali, i quali divennero uno scolo della nobiltà, salve sempre le dovute eccezioni. In questo mezzo però la sovranità di nuovo prese forza sulla nobiltà che si avviliva, e giunse a comprimerla, e finalmente a dominarla interamente. Allora i principi ottennero la nomina de' Vescovi, cioè, senza dubitazione alcuna, la influenza massima nelle elezioni vescovili; ma tale influenza fu legalizzata in forma di una protezione, fu usata con cautela ed esteriore decenza, fu ornata di tutto il buon gusto diplomatico. Intanto però lo scisma si fa sempre più irreparabile: e chi ne salverà la Chiesa? chi ne salverà il mondo? chi ne salverà i troni affaticati a preparare a se stessi le più miserande sciagure e le più strane peripezie? Di quale de' tre poteri rimane alla divina Providenza di far uso per sanzionare ancora una volta la legge della giustizia, e per restituire alla Chiesa quella piena libertà di esistere che non fu mai toccata da mano mortale impunemente? Uno sguardo solo sulla terra, e la risposta è fatta. La tremenda sanzione della Divina Providenza non è più nelle tenebre, non si fa indovinare. Ella è cominciata, e sonante in varj punti d'Europa e dell'universo. L'Inghilterra e l'Irlanda, gli Stati uniti, il Belgio hanno libertà di eleggere i Vescovi: a nessun prezzo la Providenza si rimarrà dal redimere alla Chiesa una tale libertà in tutte le nazioni della terra: ne stieno certi i monarchi. I popoli, si i popoli sono la verga di cui ella si serve. Le ribellioni sono esecrabili: e chi più le esecra della Chiesa? chi più le condanna? Ma quello che non fa la Chiesa, quello che non fanno i buoni; quello appunto il fa la potenza di Gesù Cristo che è Signore de' regi e de' popoli, che piega al suo volere le cose tutte, e che suol cavare sempre i beni da' mali. Egli userà anche il braccio de' malvagi al suo intendimento.
(2) Si veggono adunque due periodi negli attentati della noblltà e del poter supremo per insignorirsi delle elezioni: nel primo periodo si trattava di prenderle d'assalto con una usurpazione senza velo; nel secondo periodo si operò sottomano con arte, e si venne al fine per de' passi insensibili.
In Francia il poter supremo si unì col popolo a danno della libertà della Chiesa e contro la nobiltà, e perciò vi fu congiura contro lo Stato. Nell'adunanza de' comuni del 1615 il terz'ordine fu pel gallicanismo, e il sistema cattolico fu difeso dal Clero e dalla nobiltà: sicchè, come scrive Bartol. Graminond presidente del parlamento di Tolosa (lib. 1 hist. ad ann. 1615) il partito cattolico diceva Clerum et nobilitatem convenire in eandem sententiam, nec ideo contrariam opinionem valere quia ita populus censet: duorum vota et calculos uni prævalere.
Nel 1673 il Clero si dichiarò ancora nella stessa buona sentenza; ma nel 1682 contraddisse a' suoi padri. Il clero di nomina regia sotto un re dispotico come Luigi XIV fu regio: allora il gallicanismo prese tutte le forme più regolari e compì il suo trionfo.
Ma che valse questa congiura del potere supremo e del popolo contro lo Stato e la Chiesa? Valse al re la sua rovina. Annientata quasi la nobiltà, il re si trovò in presenza del popolo ch'egli stesso avea sollevato. Due poteri in presenza senza mediatore non possono a lungo sussistere Concordi: il popolo adunque cacciò il re, l'uccise. Che lezione! Che falsa politica non è quella che non pensa ad altro che a rendere il poter supremo illimitato e nulla più? Gli eccessi si toccano; e chi soverchiamente s'innalza, più miseramente si rovescia.
Singolare cosa è ad osservare, che il Card. Richelieu stette per la Chiesa contro il gallicanismo; e pure fu egli che ne preparò il trionfo, egli il più grande istrumento della depressione della nobiltà, e del regio assolutismo. Non vedeva dunque il grand'uomo la conseguenza di ciò che operava: e quanti altri mostrano pure di vedere assai, e sono veramente miopi ingannandosi allo stesso modo!
121.
Sì, lo scompiglio di tutta l'Europa, oso dire che è irreparabile, percchè non v'avrebbe che un solo mezzo di fuggirlo, quello di rimettere la Chiesa di Dio nella sua piena libertà, e nell'usare verso di essa tutta la sommissione e la giustizia. Ma questo mezzo è anche il solo che non si vede, è il solo che sciaguratamente si rifiuta. Tutto si tenta, tutto s'adopera, gli eserciti e le più prudenti negoziazioni; ma tutti questi mezzi sono simili a que' soccorsi estremi che colla più grande premura e vigilanza si prestano ad un moribondo, i quali assai ottengono quando riescono a prolungare per alcuni istanti i suoi mortali patimenti. Manca forse l'intelligenza? no, manca la fede: manca un sufficiente amore alla giustizia. Non si crede che la Providenza abbia un consiglio fisso nel governo degli eventi; non si crede che la Chiesa abbia una missione che vuol esser ad ogni costo adempiuta: l'uom si persuade di poter fare senza di lei; così l'incredulità toglie poi anche l'intelligenza, cioè rende inintelligibile il sacro universal grido de' popoli cristiani, quello di LIBERTA': i quali popoli dicono di ribellarsi per una cagione non vera; mentendo a se stessi; poichè della vera cagione, per la quale si sollevano, essi hanno una profonda coscienza, e ne manca loro l'espressione. Deh! s'impari, che i cristiani, essenzialmente liberi, non possono servire all'uomo, in cui non veggano Iddio, non possono servire che ad una condizione, di apprendere dal magisterio della Chiesa la legge evangelica di umiltà e di mansuetudine, e che la Chiesa schiava e spregiata non è più atta a loro insegnarla. Ah se queste verità s'intendessero! vi sarebbe forse ancor tempo!
V: Della piaga del piede sinistro: la servitù dei beni ecclesiastici.
122.
Dalle cose ragionate fin qui apparisce, che la caduta di Roma pagana, predetta dalle Scritture sotto il nome di Babilonia fu, nell'ordine dell'altissima Providenza, non solo un atto di giustizia vendicatrice del sangue de' Martiri ed estirpatrice delle ultime radici dell'idolatria; ma una disposizione altresì di quella divina politica con cui l'umanità vien governata dal Re de' regi, onde, disciolta l'antica e decrepita Società, se ne annodasse una novella figlia della Chiesa del l'Uomo-Dio, segnata in fronte di un carattere sacro, indelebile, che la rendesse come la sua genitrice, immortale, e insieme con lei si svolgesse in un progresso interminabile di sconosciuta e nuova civiltà. Ma la gloria, che da tant'opera dovea venire all'elemento divino della Chiesa di Cristo, conveniva che fosse temperata e quasi contrabilanciata dall'umiliazione che all'elemento umano della medesima Chiesa sarebbe conseguitato, acciocchè tutto il bene si attribuisse a Dio e al suo Cristo e non all'uomo. Laonde Iddio permise, che i barbarici conquistatori incaricati dall'alto consiglio della distruzion del Romano impero, e mossi, senza saperlo, a renderci discepoli della Chiesa, introducessero il Feudalismo che finì collo spegnere la libertà della stessa Chiesa, onde provennero tutti i suoi mali. Perocchè, a dir vero, l'affluenza delle ricchezze non sarebbe bastata a precipitare il Clero in quel fondo che noi vedemmo; nè tampoco avrebbero recato un effetto sì miserando i temporali dominii, se fossero stati indipendenti. Che anzi della sovranità si servì Iddio a mantenere inviolata la libertà della Sedia Apostolica, acciocchè almeno il Capo campasse salvo dalla universale servitù, e il capo libero poi rendesse a suo tempo libere anche le membra, il che è la grand'opera che resta ancora a compire a Roma.
123.
Sì, il feudalismo fu l'unica, o certo la principalissima fonte di tutti i mali; perocchè essendo egli un sistema misto di signoria profana e barbara, e insieme di servitù o vassallaggio a' principi temporali: in quant'è signoria, egli divise il Clero dal popolo (Piaga I), e spezzò in due parti, che chiamaronsi ingiuriosamente alto e basso Clero, sostituendo alla relazione di padre e figlio, che l'annodava, quella di signore e suddito che lo disnoda: onde la negletta educazione del Chericato (Piaga II), e quindi ancora entrata la divisione nell'alto Clero, cioè ne' Vescovi fra di loro, dimentichi della fraternità, memori della gelosia signorile sì per proprio conto che pel conto del principe, al cui vassallaggio appartenevano, rimanendo così ciascun Vescovo e separato dal popolo, e sequestrato dall'intero episcopato (Piaga III): in quant'è poi servitù, il feudalismo, assoggettati i Vescovi personalmente al Signor temporale come fedeli e uomini suoi, incatenò ignominiosamente la Chiesa tutte le cose sue al carro del laicale potere che la trascinò per tutte quelle balze e precipizj, nelle quali esso, in suo corso irregolare e fallace, va sovente rompendosi ed inabissandosi, e dopo mille avvilimenti e mille sciagure, spoglia a man salva de' ricevuti dominii, ella trovasi così sfinita di forze da non saper pure conservare e difendere a se stessa la nominazione de' proprii pastori (Piaga IV). E dico che il feudalismo asservò la Chiesa con tutte le cose sue, perchè i barbari regnatori, avvezzi a non riconoscere che vassalli, con questo loro istinto tutte le cose ecclesiastiche riguardarono; al che mirando i legisti adulatori, seppero ridurre a teoria di diritto il dispotismo barbarico, invalso di fatto, insegnando che «il principale tira a sè l'accessorio», e come principali dichiarando i feudi regi così inducendone, che dunque anche gli allodj, che le Chiese possedevano, come beni feudali si dovessero riguardare. Per tal guisa il feudalismo assorbì ogni cosa: non lasciò più libere nè le persone, nè lo cose delle Chiese.
124.
Lasciando dunque da parte il caso della sovranità, che non s'avverò se non nella sedia Romana, nè s'avrebbe potuto avverare in altre, almeno per lungo tempo, la quale essendo dominio libero non arreca ignominiosa servitù, dico che ciò che corrompe ed avvilisce il Clero non sono le ricchezze libere, ma le serve: fu la servitù degli ecclesiastici beni la deploranda cagione, onde la Chiesa non potè conservare le antiche sue massime intorno a' beni ecclesiastici, nè regolarne liberamente e col suo proprio spirito l'acquisto, l'amministrazione, e la dispensazione come si conveniva. E questa niancanza di convenevoli provvedimenti all'amministrazione e all'uso de' beni della Chiesa in conformità delle antiche massime e dell'ecclesiastico spirito è appunto la quinta piaga, che tuttavia affligge e martoria il suo mistico corpo.
125.
Il feudalismo in gran parte è caduto, e va via più dileguandosi in presenza dell'incivilimento delle nazioni, come le ombre si fuggono a' raggi della luce: la Chiesa non ha più feudi. Ma al feudalismo sopravvivono i suoi principj legali, le sue abitudini, il suo spirito: la politica de' governi s'ispira ad esso, i codici moderni hanno ereditato dal medio evo una si infausta eredità. Noi segnaliamo la cagione, perchè se ne considerino gli effetti.
126.
La Chiesa primitiva era povera, ma libera: la persecuzione non le toglieva la libertà del suo reggimento: nè pure lo spoglio violento de' suoi beni, pregiudicava punto alla sua vera libertà. Ella non aveva vassallaggio, non protezione, meno ancora tutela, o avvocazia: sotto queste infide e traditrici denominazioni s'introdusse la servitù de' beni ecclesiastici: da quell'ora fu impossibile alla Chiesa, come dicevamo, di mantenere le antiche sue massime intorno all'acquisto, al governo, e all'uso de' suoi beni materiali; o la dimenticanza di queste massime, che toglievano a tali beni tutto ciò che hanno di lusinghevole e di corruttore, l'addusse all'estremo pericolo: noi dobbiamo accennarne le principali.
127.
La prima massima, che riguardava l'acquisto de' beni, era che l'oblazione fosse spontanea. — «In qualunque casa entrerete, avea detto Cristo agli Apostoli, prima dite: pace a questa casa. — E nella stessa casa rimanetevi mangiando e beendo le cose che si trovano presso di quelli: poichè l'operaio è degno della sua mercede (1)». Le quali ultime parole furono norma agli Apostoli, ripetuta più volte da S. Paolo (2). Per esse Cristo imponeva ai fedeli l'obbligazione di mantenere gli operai evangelici, e dava a questi il diritto di esser mantenuti da loro. Era un vero precetto; ma l'esser precetto, non toglie la spontaneità dell'azione; che spontanea dovea essere pure la stessa adesione al Vangelo, e l'incorporazione al corpo de' fedeli. La spontaneità dell'umano operare non cessa se non allorquando s'aggiunge all'obbligazione altresì una coazione violenta. Ora Cristo non aggiunse altra sanzione che questa: «E chiunque non vi riceverà, nè ascolterà i vostri discorsi, uscendo fuora della casa o della città scuotete la polvere da' vostri piedi (3)». È rimesso alla divina giustizia il punire gli infrattori di quel precetto, secondo lo spirito di mansuetudine del divino Legislatore, il quale pure promette, a suo tempo, che saprà farlo (4). L'evento di Anania e di Saffira prova il medesimo: «Se tu l'avessi tenuto (il tuo campo), disse al primo S. Pietro, non ti rimaneva egli? e venduto non ne rimaneva in tue mani il prezzo (5)?» Parimente le collette ordinate da S. Paolo alle Chiese de' Galati e de' Corintj, per sopperire al bisogno de' Cristiani indigenti di Gerusalemme, sono rimesse allo spirito di carità e alla discrezione di ciascheduno: «ogni domenica ciascuno di voi metta da parte ciò che gli verrà bene (6)».
(2) 1 Cor. IX, 4, 13, 1 Timoth. V, 17, 18.
(3) Matth. X, 14.
(4) Ivi, 15.
(5) Act. V, 1, 11.
(6) 1 Cor. XVI, 2.
128.
Di più, il precetto dato da Cristo a' fedeli di mantenere il Clero, non s'estende oltre lo stretto bisogno, il che venia significato coll'espressione «di mangiare e di bere in qualsiasi casa in cui entrassero gli evangelici banditori» edentes et bibentes quæ apud illos sunt; onde Paolo attenendosi alla maniera di esprimersi usata da Cristo, scrive a' Corinti: «Forse non abbiamo noi la potestà di mangiare e di bere (1)»? Che se era lasciata a' fedeli tutta la spontaneità nel modo di somministrare il necessario sostentamento al primitivo Clero, di cui pure aveasi il precetto; quanto più rimanevano spontanee per loro natura quelle offerte che oltrepassassero questo limite del bisogno?
129.
Sulla fine del secondo, e al principio del terzo secolo Tertulliano ci fa conoscere, che questa bella spontaneità conservavasi. «Ciascuno, dic'egli nell'Apologetico, ogni mese, oppure quando vuole, e se può, mette a parte un po' di moneta, perocchè nessuno è forzato, ma la dà spontaneo. Questi sono come depositi della pietà (1)».
La qual massima ricomparisce più o meno spiegata in tutti i bei secoli della Chiesa, che voleva e raccomandava, che non solo i fedeli non fossero violentati alle oblazioni, ma nè pure indotti a prestarle con artifizj e lusinghe, e fino nel IX secolo vedesi il Concilio III di Chalon pubblicare de' canoni per mantenere illesa, anche contro questo abuso, la spontaneità de' doni che i fedeli alla Chiesa offerivano (2).
(2) V. il Tommasino P. III, L. 1, C. XXIII.
130.
La legge delle decime, che Iddio aveva assegnate nell'antico patto a' Leviti, non fu confermata da Cristo pel nuovo; e la ragione io credo esser questa, che non volendo l'Autor della grazia aggiungere alcun peso positivo oltre a quello che la natura delle cose esigeva, e la natura delle cose addimandando solamente che il Clero fossc mantenuto da' fedeli in cui prò travagliava, il che non segna alcuna misura determinata alla sovvenzione, potendo esser più o meno il bisognevole, secondo il numero degli operai, l'assegnare una determinata misura sarebbe stato un prescrivere talora più del bisogno, talora meno. Ma non avendo nè pure il Signore proibita tale oblazione, ma lasciata del tutto libera alla discrezione de' fedeli, questi fino da' primi secoli le offeriron spontanei, tenendo presente, specialmente quelli che veniano dalla sinagoga, l'antica disposizione (1). E ancora nel secolo VI, egli scmbra per insinuazione de' Vescovi più tenaci delle massime antiche, Giustiniano vietava che non che usarsi la forza a riscuoterle, nè pur vi s'adoperassero le pene ecclesiastiche (2).
Poteva bensì la Chiesa quel che era invalso per consuetudine ridurlo in precetto, siccome fece, prima in qualche luogo nel secolo VI (3), poscia universalmente, qualora ella trovasse esser questo il mezzo più conveniente o necessario per assicurare al Clero il suo sostentamento; ma la spontaneità dell'offerta cessava solo allorchè vi s'aggiungesse la sanzione del civile potere, la quale comparisce nel secolo VIII insieme col feudalismo (4).
(2) L. 39 Cod. De Episcop. et Cleric.
(3) Così si fece nel Concilio II di Macon dell'anno 585.
(4) In Capital. An. 779, 794, 801.
131.
E qui è da considerare, che il Vangelo introdusse nel mondo una nuova specie di diritti, che noi potremmo appellare diritti ecclesiastici. Prima non si conoscevano che diritti di stretta giustizia, ed azioni di beneficenza: i primi ammettevano la forza esterna e violenta, le seconde rimanevano al tutto libere. Fra queste due forme di morali operazioni, il divino Legislatore che riformò la terra, ne introdusse una terza, di cui è esempio appunto il diritto dato da lui a' sacri ministri di vivere dell'altare, al quale appose per tutta difesa la minaccia del celeste castigo; e tale natura hanno del pari le ecclesiastiche ordinazioni sancite da sole pene canoniche e spirituali: perocchè la massima pena che la Chiesa si abbia in proprio si è quella della separazione del disubbidiente e contumace dal corpo de' fedeli, e la privazione quindi de' beni della lor comunione. La qual guisa di pene, con cui la Chiesa mantiene i suoi ordini e i suoi diritti, rimaneasi del tutto incognita e straniera al temporale reggimento, come Cristo avea già insegnato in quelle parole: «I re delle genti li signoreggiano, e quelli che hanno su loro il potere si dieon elementi: ma voi non farete così (1)». Che dunque accadde allorchè i beni ecclesiastici non furono più liberi in man della Chiesa, ma divennero servi aggiogati dal poter temporale? Quello che ne dovea avvenire: il temporale potere vi aggiunse la forza, chè altra cosa egli non aveva nè conosceva, e talora egli credette in buona fede di fare al Clero con ciò un singolarissimo beneficio, et qui potestatem habent super eos, benefici vocantur.
132.
Certamente era giusto nè contrario allo spirito del Vangelo e della Chiesa, che le proprietà già acquistate da questa in virtù di spontanee donazioni, fossero dalla forza pubblica, siccome tutte l'altre, tutelate; perocchè elle acquistano, dopo la donazione, natura di diritti di stretta giustizia. Ma l'impiego della forza ripugna all'antica massima, trattandosi di costringere i fedeli a donazioni e ad offerte, come è il caso delle decime, delle primizie, e di simiglianti oblazioni; nè la primitiva spontanea natura di questa poteva perdersi per la consuetudine invalsa, nulla più essendo che uno de' tanti sofismi giuridici quello che pretende cangiare un donatore spontaneo in uno stretto debitore, unicamente perchè già da lungo tempo egli ha continuato a donare.
133.
In qual primo grado di servitù, a cui furon sommesse le oblazioni spontanee, diminuiva la carità fra i fedeli offeriritori ed il Clero, che non rimaneano più avvinti colle dolci relazioni di beneficante e beneficato, o meglio con quelle di scambievoli beneficanti, dando gli uni le cose temporali e l'altro le spirituali, secondo il concetto apostolico, Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est si nos carnalia vestra metamus? (1); alle quali primitive e naturali relazioni veniano surrogate quelle fredde ed odiose di debitore e di creditore, le quali d'una parte toglievano il merito e la dolcezza del dare, dall'altra la gratitudine del ricevere; e il Clero sicuro del viver suo, non poteva più esperimentare l'aumento e la dintinuzione delle offerte in ragione di sue fatiche.
134.
Ma un altro grado di servitù più funesta fu quella del confondersi le proprietà libere e liberamente donate alla Chiesa colle feudali, che assorbirono tutte l'altre, e fece nascere l'opinione che tutte le cose della Chiesa appartenessero al Signore infeudante, a cui le stesse persone di Chiesa servivano. La prova di questa servitù de' beni ecclesiastici è significata fino nel linguaggio di quel tempo, perocchè le Chiese si chiamarono mani morte, che significava una classe di servi (1), nè mai perì più l'ingiurioso vocabolo. Laonde il mal seme, dopo aver fruttati copertamente i più velenosi frutti nel Clero, produsse all'ultimo le spogliazioni moderne della Chiesa, e il più solenne decreto 2-4 novembre 1789, col quale l'Assemblea nazionale di Francia dichiarò beni della nazione tutte le ecclesiastiche proprietà; raccogliendo così la rivoluzione fatta a nome della civiltà l'eredità e le spoglie del Feudalismo.
135.
La seconda massima, che proteggeva la Chiesa dalla corruzione che da sè arrecar possono i beni terreni, si era che «questi si possedessero, si amministrassero e dispensassero in comune». — Così i primi fedeli deponevano il prezzo delle case e de' campi venduti ai piedi degli Apostoli, ed era dispensato a' fedeli, secondo il bisogno di ciascheduno, pro ut cuique opus erat (1), Qual carità non fomentava in quel primo tempo, qual'unione non adduceva tra fedeli, e tra fedeli e Clero questa comunanza di beni! «La moltitudine de' credenti avea un cuor solo ed un'anima sola; nè alcuno di essi diceva sue quelle cose che possedeva, ma tutte erano comuni (2)». Il dolee spettacolo che offeriva questa fraternità, non mai conosciuta, in Alessandria, indusse Filone, benchè ebreo, a scriverne un libro elogistico. In lei mirarono sempre i Santi come nel più bel tipo dell'evangelica dilezione si sa dalla storia quanto il Grisostomo ebbe desiderato di poterla introdurre fra il suo popolo di Costantinopoli: ell'era la perfezione di quanto narra Livio de' bei tempi di Roma; dove dice, che il censo privato era breve, largo il comune.
(2) Ivi, 32.
136.
La qual massima si conservò lungamente nel Clero. Di tutto l'avere della Chiesa erano depositarii i Vescovi successori degli Apostoli, i quali distribuivano, per lo più mensilmente, quanto era necessario a' Cherici che sotto di essi lavoravano nell'Evangelio; niun individuo aveva cos'alcuna in proprio. Quando Costantino nel 321 permise le disposizioni testamentarie a favor della Chiesa, così s'espresse: «Abbia ciascuno licenza di lasciar morendo i beni che egli stima al santissimo cattolico e venerabil Concilio della cattolica Chiesa (1)».
Più tardi fu anche espressamente proibito dalla Chiesa il concedere a un individuo del Clero qualche porzione di beni separandola dalla massa comune, come dimostra un rescritto del V secolo attribuito al santa Papa Gelasio; e ciò anco pel fine che i beni ecclesiastici fossero meglio amministrati e conservati (2). Dal quale spirito medesimo della Chiesa fu dettata la legge di Valentiniano vietante il lasciare legati o eredità agl'individui del Clero secolare o regolare (3), legge di cui non fecer lamento i santi uomini di quella età, come un Ambrogio, e un Girolamo, ma ben si dolsero degli ecclesiastici che, a loro smacco, l'avessero meritata. «Nè io mi lagno, dice Girolamo, della legge; si mi addoloro dell'averla noi meritata. Il cauterio è eccellente; ma a che m'avrò io la ferita di necessitarmi il cauterio? Sia erede, ma la madre de' figliuoli, cioè la Chiesa, sia erede del suo gregge quella che lo generò, lo nutri, lo pascette. Perchè ci tramettiamo noi tra la madre ed i figli? (4)». Così non volea il Santo che gl'individui del Clero o del monacato si tramettessero fra la Chiesa depositaria delle pie offerte, ed i suoi figliuoli a cui ella, secondo il bisogno, le compartiva. La quale unità dei beni comuni, dalla sapienza e carità vescovile col consiglio del Clero (5) amministrati, ei non è a dire quanto valesse a produrre ed a conservare l'unità saluberrima del Clero fra sè, e quella altresì del Clero col popolo.
(2) Gratianus, Cans. XII, C. XXIII — nec cuiquam Clerico pro portione sua aliquid solum Ecclesiæ putetis deputandum, ne per iucuriam et negligentiam minuatur: sed omnis pensionis summam ex omnibus pradiis rusticis urbanisque collectam ad Autistitem deferatis.
(3) L. Valentiniani 20. De Episcopis et Clericis Lib. XVI. Cod. Teod. Tit. 2 ad S. Damasum R. P.
(4) Ep. ad Nepotiauum. — S. Ambrogio del pari facendo menzione di questa legge di Valentiniano dice: Quod ego non ut querar, sed ut sciant quid non querar, comprehendi, malo enim nos pecunia minores esse, quam gratia. A cui poco appresso aggiunge altresì: «La possessione della Chiesa è lo spendio de' poveri. Numerino quanti captivi abbian le Chiese redenti, quanti alimenti agl'indigenti dati, quanti sussidii al vitto degli esuli somministrati». Epp. Cl. 1, ep. XVII.
(5) Etenim ea ætate, dice il Berardi, parlando di questo appuuto, quotiescumque negotium ecclesiasticum peragendum erot, Episcopus Cleri consilium, convocotu Synodo, expetebat. Graviniani Canones etc. De Gelasio C. XLVI.
137.
Ma quando, diffondendosi via più il Vangelo pe' paghi, fu uopo istituire Chiese nella campagna lontane dalle Cattedrali, convenne allora assegnare un fondo distinto alle medesime (1); il che si fece prima per via d'eccezione; e a' monasteri pure, a' Cherici benemeriti, e a' peregrini si assegnò qualche fondo da usufruire a tempo; come rilevasi da una disposizione di Papa Simmaco del secolo VI (2); onde si chiamaron precarj (3). Ma la detenzione, l'amministrazione, e l'uso de' beni ecclesiastici, andò sempre più perdendo la primitiva unità fino a sparpagliarsi ne' singoli benefizj di mano in mano che si sciolse la vita comune del Chericato, tanto desiderata dalla Chiesa, che con leggi frequenti e disposizioni canoniche la restaurò alcuna volta, ma non la potè in fine conservare. Ed or quale infausta cagione glielo impedì se non di nuovo il barbarissimo sistema del feudalismo?
(2) Gratianus, Causs. XVI, L. 1, C. LXI.
(3) Osserva un autore recente che il godimento d'una porzione di beni a' singoli non si facea a principio, se non dove mancavano le congregaziuni de' preti, car dans celle-ci, dice, la vie commune maintint encore quelque tems l'ancien état de choses, Walter, Manuel de Droit Ecclésiastique § 241.
138.
Il feudalismo involge una servità personale, ed è già per questo solo ripugnante al carattere ecclesiastico, che è quello della libertà. Ma oltracciò anche i beni del feudatario non pur diventano servi, ma di più acquistano una servitù speciale, conseguenza della servitù personale di colui che li gode; nuova ragione della sua intrinseca opposizione allo spirito della Chiesa, e dell'ecclesiastica condizione. E in vero, nella divina costituzione che Cristo lasciò alla Chiesa, la personalità de' ministri suoi scomparisce: essi non rappresentano se stessi, ma la Chiesa; è sempre tutto il corpo della Chiesa che opera per mezzo di essi e per la virtù del suo Capo in tutte le loro funzioni: gli organi non hanno alcuna personalità propria più che la abbia un piede, un braccio, o altro membro nel corpo umano. Di questa ammirabile costituzione adunque il fondamento è la perfetta mistica unità. Or come se le membra del corpo umano volessero ciascheduna essere e divenire una persona a parte, il corpo, perduta ogni sua bellezza e il suo ordine naturale, si cangerebbe in un mostro, o piuttosto non potrebbe più esistere; così è a dir della Chiesa. Ma questo è appunto quello che tentò di fare di essa il sistema feudale. Perocchè ogni vassallo non può rappresentare che se medesimo, e la persona a cui serve, e con essa le cose sue. Senza di che questo vassallaggio e servigio prestato al Signor temporale, ha un oggetto, un ufficio essenzialmente temporale e secolaresco. Fino a tanto che trattavasi di ricchezze libere, queste potevano avere una destinazione spirituale; e l'ebber sempre tutti i beni liberi della Chiesa: s'amministravano, si dispensavano in ispirito e in usi, di carità; per esse i sacri ministri si mantenevano, il culto divino si alimentava: le mani de' poveri, delle vedove, de' lebbrosi, degli schiavi, de' peregrini, de' miseri tutti erano gli scrigni preziosi, dove la Chiesa riponeva, sicuri dall'umana rapacità, i suoi tesori: col far tutto questo la madre de' fedeli non usciva dall'ecclesiastico ministero, che è pur ministero di carità materna, e di cristiana misericordia (1). Ma il vassallo; il servo che dee pensare al servigio del suo signore, e a questo servigio dee amministrare quel che possiede, ha già un altro scopo, essenzialmente diverso, non più ecclesiastico: egli non è più bonus miles Christi Jesu, s'è implicato ne' temporali negozj contro il precetto dell'Apostolo (2): non si vede più in lui la sola Chiesa, ma l'uomo isolato, un uomo come tutti gli altri, un cortigiano che agl'interessi e all'onore del suo signore servendo, dee tener corte, usare sfarzo e lusso nel suo proprio trattamento, mettersi fors'anco alla testa di gente armata: fare insomma il conte il barone per sè e pel signore, non più il vescovo ed il Prelato per la sua Chiesa, pel suo popolo da lui indiviso.
(2) Labora sicut bonus miles Christi IESU. Nemo militans Deo implicat se negotiis sæcularibus. II Timot. II, 3,4.
139.
E questa grande trasformazione, contro natura, delle persone di Chiesa stampò nelle menti de' Vescovi del medio evo il concetto della loro individualità, illanguidendo quello della unità del corpo dell'Episcopato e del Clero; disciolse i vincoli che rendevano così possente in Cristo per operar tutti i beni, e così splendido il maraviglioso corpo della Chiesa ne' suoi bei tempi: divise le diocesi come gli Stati e le signorie: e infine divise e minuzzò anche i beni ecclesiastici, che colla loro unione, o disgregazione rappresentano siccome effetti, e in parte formano siccome cause l'unità morale o la disgregazione delle persone, e li minuzzò fino a renderli amministrati e usufruiti quasi per intiero da' singoli Cherici: onde l'origine filosofica de' benefizj indicata dalla parola stessa; chè benefizio è parola del vocabolario feudale, chiamandosi benefizio da prima le terre di cui il principe concedea l'usufrutto a' suoi cortigiani e commensali in guiderdon di servigi.
140.
È da osservarsi che quando un'idea, una forma s'imprime altamente nella intelligenza e nella imaginazione degli uomini, e vi prevale, allora ella diventa norma, e modello, a cui si conformano tutte l'altre cogitazioni e tutte le maniere di operare che possono in sè ricevere quella forma, e quelle che non possono, altresì vi si subordinano, e vi si aggruppano intorno siccome ancelle da quella padroneggiate. Ora ne' primi tempi della Chiesa l'idea grande scolpita in tutte le menti cristiane era quella dell'unità: e però tutto ne' pensieri e nelle parole de' fedeli, e del Clero, nelle disposizioni ecclesiastiche, nelle scambievoli operazioni, nelle amministrazioni e nei beni che si possedevano luceva e dominava l'unità di Cristo. Il feudalisino fondavasi sopra un'idea tutt'opposta, cioè sull'idea della divisione, che procede da quella della individualità, e sull'idea dell' individualità che procede da quella della signoria: è un tal sistema prevalse negli ordini temporali, scolpì bel bello anche nelle menti degli ecclesiastici quell'idea appunto che gli serviva di fondamento, indi i guai della Chiesa.
141.
A' barbari, che conquistaron l'Europa, era norma l'idea della forza, della violenza, del personale valore, del dominio: la Chiesa insinuò poco a poco nelle rozze loro menti l'idea contraria, che le era propria. Quindi la lotta fra le due idee: e come quando sono a fronte l'una dell'altra due società dominate da due idee contrarie, queste, parte si combattono apertamente, ciascuna usando dell'armi proprie, parte tentano di conciliarsi e di fondersi; entrando l'una idea nel dominio dell'altra, benchè sempre conservino l'occulta opposizione che hanno per loro natura; così avvenne che i governi barbarici da una parte, opprimendo colla prepotenza la Chiesa, tentassero di soggiogarla e di conformarla del tutto al tenore della loro idea signorile, violenta, individuale, materiale, parte ricevessero, quasi senz'accorgersi, nel proprio seno l'idea contraria ministeriale, morale, unitaria, spirituale della Chiesa, onde il loro operare doppio e contradditorio, intessuto di atti di somma pietà e di benefizj alla Chiesa, e di atti empj di dispotismo e alla Chiesa nocevolissimi, secondo che all'una od all'altra delle due idee ubbidissero, o all'originale da loro arrecata, o all'acquisita dal magisterio della Chiesa; e avvenne pure il simigliante nel Clero, il quale parte colla parola evangelica ammaestrò e mansuefece quei violenti, introducendo nelle loro menti la propria idea unificatrice di carità, parte rimanendo vulnerato esso stesso nella gran lotta, accolse l'idea contraria, e quindi anche nell'operare del Clero la stessa contraddizione or di santissimi ed eroici esempj, e sforzi per conservare l'unità di Cristo, ed or di profani disordini, di vilissime condiscendenze, di tendenze individue, dissipatrici dell'unità e della cristiana ed ecclesiastica comunità. Perocchè la lotta delle due idee, e la contraddizione dell'operare sì negli ordini temporali che negli ecclesiastici è il carattere proprio del medio evo: il che solo spiega tutti gli eventi di quella età, e nominatamente gli urti fra l'impero e la Chiesa; chè non potendo questa perire, nè l'idea che la domina intieramente distruggersi, perchè passerà il Cielo e la terra, ma non la parola di Cristo; ogni qualvolta l'idea contraria alla Chiesa della dominazione temporale e violenta e della disunione prevale ed entra nel Clero fino a comprometterne l'esistenza; la Chiesa sorge da quell'ora come un gigante che si risveglia, e con nuova e non più usata vigoria atterra nell'estremo pericolo il suo nemico, lo scaccia dalle sue tende invase, e ristaura in se medesima e ne' suoi ministri quell'idea da cui la sua vita dipende (1).
142.
Or tutto questo ci spiega le vicende subite dai beņi ecclesiastici. I Signori del medio evo, operando secondo l'idea d'individualità e di signoria, non solo riguardarono come feudali anche i beni liberi della Chiesa, ma li invasero, ne disposero come fossero loro individuali, li dispensarono ai laici, li alienarono: le quali usurpazioni furono ampio fomite di discordia fra loro e la Chiesa, che con canoni conciliari, pontificie leggi, e pene canoniche guerreggiò un tanto abuso.
I Prelati, cioè quella parte di essi ligia al principe, nella quale l'idea di individualità erasi radicata insieme co' feudi; operando pure a tenore di questa, disposero in egual modo delle ecclesiastiche proprietà come fosser lor proprie: dimentichi che eran comuni, le alienarono, le infeudarono, le permutarono, le donarono agli stessi laici, le spesero negli sforzi, ne' lussi, nelle delizie, nelle milizie, nelle violenze: a cui pure s'oppose la Chiesa con innumerevoli canoni e decreti, rimanendone così vincolata soprammodo l'alienazione, l'amministrazione e la disposizione; e rendendosi sempre più slegato dai suoi Prelati il Clero inferiore, che la Chiesa dovette necessariamente proteggere, contro l'arbitrio e la crudeltà di quelli, con replicate e minute disposizioni: onde la lotta sì spesso accesa anche oggidì fra i Capitoli, e i Vescovi; e l'innamovibilità de' parochi, che toglie a' Prelati in gran parte il potere di rimediar prontamente agli scandali ed alle sciagure spirituali delle popolazioni.
143.
Ma perocchè il divino fondatore della Chiesa non volea che perisse il principio della comunione de' beni ecclesiastici, non solo rispetto al loro possesso, ma nè anco rispetto alla loro amministrazione ed al loro godimento; perciò egli suscitò in que' tempi e moltiplicò il Monachismo e l'Ordine religioso, il qual facesse espressa e pubblica professione d'un principio sì salutare: ed i fedeli, guidati da quell'istinto cristiano, che in essi mai non fallisce, mostraronsi da quell'ora più propensi a recare le loro oblazioni e i loro doni a quel Clero regolare che custodiva severamente la massima antica, anzi che al Clero secolare; onde quando dal Concilio III di Laterano (1179) fu intimata la restituzione delle decime alienate ai laici, questi per la maggior parte le rimisero a' Monasteri non più alle Chiese a cui erano appartenenti, il che fu in appresso permesso dagli stessi Pontefici, purchè s'aggiungesse l'assenso del Vescovo (1).
144.
Una terza e preziosa massima dell'antichità si era che «il Clero non usasse de' beni ecclesiastici se non il puro bisognevole al proprio sostentamento, impiegando il di più in opere pie, specialmente in sollievo degl'indigenti». — Cristo avea fondato l'apostolato sulla povertà e sull'abbandono alla provvidenza che avrebbe mossi i fedeli al sostentamento de' loro evangelizzatori. Egli n'avea dato il più sublime esempio: «Le volpi, potè egli dire, hanno delle buche, e gli uccelli del Ciclo de' nidi: ma il Figliuolo dell'uomo non ha dove posare il capo (1)»: tal condizione dichiarava a colui che il volea seguitare. E Pietro avea lasciato fin le povere reti per tener dietro al suo nudo Maestro. Pure il Collegio apostolico aveva una borsa, in cui si riponevano le oblazioni de' credenti; ma questa al tutto comune, esempio di ciò che dovea fare e fece poi la sua Chiesa. Quando il paralitico chiese elemosina, Pietro potè dirgli: Argentum et aurum non est mihi (2). Ma il bisognevole era assicurato agli Apostoli col diritto di vivere in quelle case de' fedeli che gli accoglievano, ed accogliendoli, assai più che non davano, ricevevano. L'Apostolo Paolo informava il suo discepolo Timoteo a questa dottrina scrivendogli: «La pietà è gran guadagno col sufficiente. Poichè nulla portammo noi in questo mondo, senza dubbio non possiamo nè portarne via bricciolo. Or avendo gli elementi, e da ricoprirci, a questo stiamo contenti (3)». Così l'entrare nel Clero, ne' bei tempi della Chiesa, equivaleva ad una professione di evangelica povertà (4). Allora questa parola di Clero secolare non era inventata, e comparve solo in quel decadimento dell'antica disciplina, quando parea che anche il secolo avesse il suo Clero. Lungo tempo durò la professione della povertà, qual ornamento del sacerdotal ministero, al quale quelli che venivano assunti, lasciavano per lo più il proprio avere, o a' poveri lo dispensavano; perocchè, come dice Isidoro di Pelusio, tum voluntaria paupertate gloriabuntur (5). A uomini così integri e disinteressati veniva poi affidata l'amministrazione e la dispensazione de' beni della Chiesa, come a depositarii dell'avere degl'indigenti. Giuliano Pomerio, dopo recati in esempio di povertà volontaria i due grandi Vescovi Paolino di Nola, ed Ilario di Arles, che da doviziosissimi che erano, s'eran fatti poverelli di Cristo, soggiunge: «Di che si può ben intendere, che uomini tali e tanti (i quali per essere a Cristo discepoli, rinunziarono tutte le cose che avevano), conscii che altro non sono i beni della Chiesa, se non il voto de' fedeli, le soddisfazioni de' peccati, e i patrimonii de' poveri; non li vendicarono già a privati usi, siccome fosser lor proprii, ma come cose loro affidate, a' poveri li divisero. Ciò che ha la Chiesa, ella lo ha comune con tutti coloro che nulla hanno: e però non dee dar nulla a quelli che hanno già il sufficiente del proprio: poichè dare a quelli che hanno già, egli non è che un gittare» (6). II perchè i chierici prendevano dalla massa comune il bisognevole a vivere, come quelli che si computavano nel numero de' poveri, a cui quella massa consideravasi appartenere: Così il Vescovo era il primo fra i poveri, e dispensandosi ai poveri quegli averi, era giusto che allo stesso titolo ne dispensasse una parte a se stesso (7), e a' Cherici inferiori. E questa massima nobilissima tanto era infissa negli animi, che si giudicava non convenevole che, se un Sacerdote ritenesse del suo, vivesse di quel della Chiesa; parendo ch'egli, non più povero, nè manco n'avesse diritto, e sottraesse indebitamente agli altri indigenti il fatto loro. Il che era consentaneo; e viene replicato dal citato scrittore del secolo, che fra altre cose dice così: «Coloro che, possedendo il suo, voglion tuttavia che qualche cosa gli venga dato, non senza lor grande peccato ricevon di quello, di cui doveva vivere il povero. Certo de' Cherici dice lo Spirito Santo: «Mangiano i peccati del mio popolo». Or siccome quelli che niente hanno di proprio, non i peccati ricevono, ma gli alimenti di cui mostrano aver bisogno; così i possidenti, non gli alimenti ricevono de' quali abbondano, ma si assumono gli altrui peccati. E così pure i poveri, se colle loro industrie e fatiche posson camparla, non presumono ricever quello che è dovuto al debile ed all'infermo; acciocchè la Chiesa, se tutti anche per nulla bisognosi ricevan di ciò, di cui ella può ministrare il necessario ai privi d'ogni sollievo, aggravata, non possa poi soccorrere quelli che deve. Ora coloro che servono alla Chiesa troppo carnalmente la pensano, se si avvisano di ricevere stipendj terreni (8), e non piuttosto eterni premj. — Che se qualche ministro della Chiesa non ha onde vivere, qui la Chiesa non gli dà mica un premio, ma gli presta il necessario; acciocchè in futuro riceva quel premio del suo travaglio, che già in questa vita, sulla speranza della promessa del Signore, con certezza attende. Ed anche quelli che (possedendo) non domandano gli sia dato alcun che quasi debito, e pure vivono a spese della Chiesa, non istà a me il definire con qual peccato ricevano, togliendo i cibi de' poveri; i quali dovendo ajutar la Chiesa delle loro facoltà, l'aggravano anzi co' loro dispendii, quasi vivessero nella Congregazione pel fine di non pascere alcuni poveri, di non albergare gli ospiti, o di non diminuire il proprio censo colle giornaliere spese» (9).
(2) Act. III, 6.
(3) I Tim. VI, 6-8.
(4) L'abbiamo espressamente da Giuliano Pomerio che scrive: Itaque Sacerdos, cui dispensationis cura commissa est, non solum sine cupiditate, sed etiam cum laude pietatis, accipit a populo dispensanda et fideliter dispensal accepta; QUI OMNIA SUA, AUT PAUPERIBUS DISTIBUIT, AUT ECCLESIAE REBUS ADJUNGIT, ET SE IN NUMERO PAUPERUM, PAUPERTATIS AMORE, CONSTITUIT; ita ut UNDE PAUPERIBUS SUBMINISTRAT, INDE ET IPSE TAMQUAM PAUPER VOLUNTARIUS VIVAT. De vita contemplativa L. II, C. XI.
(5) L. V, ep. 21.
(6) De Vita Contemplativa L. II, c. IX, dove merita segnatamente d'essere osservata quella sentenza: Quod habet Ecclesia cum omnibus nihil habentibus habet commune, come quella che dimostra l'opinione che allora s'avea dell'essere i beni della Chiesa non d'uso individuale, ma comune.
(7) Questa massima è anche registrata nel decreto di Graziano Can. XII, Q. II, cap. XXII, dove si riporta uno de' canoni apostolici, che dice: Ex his antem, quibus Episcopus indiget (SI TAMEN INDIGET) ad suas necessitates et peregrinorum fratrum usus et ipse percipiat, ut nihil ei possit omnino deesse.
(8) E però quanto meno benefizj, parola che rammenta un dono che fa il Signore a chi vuole, del suo?
(9) De vita Contempl. L. II, c. X.
145.
Gli abusi opposti a questa massima generosa avanti il medio evo non poteano essere che parziali, perocchè erano degli uomini e non dell'ecclesiastica dignità, che per la sua stessa indole li ripudiava; ma come potè più conservarsi in atto la massima stessa, in universale parlando, quando i beni della Chiesa, perdendo la primitiva loro natura, divennero feudali, e gli ecclesiastici più eminenti altrettanti feudatarii ? Da quell'ora la dispensazione de' beni prese un'altra legge, un'altra direzione: i beni in vece di scorrere all'ingiù nelle mani del povero, ristagnarono, o rifluirono all'insù nelle mani del signore: l'idea prima si smarrì o almeno si rese in molti inefficace, e sottentrò a quella l'idea della proprietà assoluta: i sacri depositi vennero depredati.
146.
Lo sparpagliamento altresì della massa comune in benefizj assegnati a' singoli Cherici, da una parte tolse a' Cherici, a' quali il Vescovo dava una quota de' beni sproporzionata alle loro fatiche ed al loro merito, che avessero uno stimolo anche umano all'adempimento de' loro sacri doveri, e li disunì dal Vescovo, dal quale, quanto a' loro proventi, divennero indipendenti (1); dall'altra l'esempio luminoso del mantenimento pubblico e ministeriale de' poveri per man della Chiesa cessò, e con quel temporale alimento si scemò pure ad essi l'alimento spirituale; chè allora e la Chiesa pigliavasi special cura di quel corpo d'indigenti che considerava per suo, col quale di continuo trattava, e il solo pascerlo a quel modo era già un'istruzione, uno stimolo alla gratitudine che gli facea conoscere, venerare ed amare la Chiesa doppiamente a lui madre. Di qui si dee ripetere la secolarizzazione, per così dire, delle opere di carità. Perocchè al difetto del Clero, venne supplito con istituti di carità separati, ne' quali di mano in mano prevalsero i laici: di che nell'ordine della provvidenza se n'ebbe il vantaggio che molti cristiani s'infervorarono nell'esercizio di tali opere sante; ma v'ebbe pure lo scapito che non essendo più quelle opere animate dall'ecclesiastico spirito e dall'ecclesiastica sapienza, si umanizzarono, perdettero il divino carattere che le sublimava e le ordinava alla salvezza dell'anime: e quest'è l'antica origine della moderna filantropia il qual bene perduto, nondimeno si recupererà allora che il Clero ritorni generoso e magnanimo. Perocchè in quel tempo desiderabile (che sembra però avvicinarsi) non vorranno più i laici dividersi e segregarsi dal Clero, da cui divisi, essi perdono ogni intendimento spirituale, e nelle materiali cose isteriliscono; ed allora la cooperazione acquistata dal laicato sarà utilissima e preziosissima, quando laici e Cherici, cessata ogni divisione, ritorneranno un solo corpo in Cristo, siccome un solo corpo fanno pure le membra col capo. La divisione adunque de' benefizj impedì l'afflusso spontaneo de' beni della Chiesa nelle mani de' bisognosi: perocchè il dovere dell'elemosina rimase diviso fra beneficiati, non più sopravvegliato da' Vescovi, e dalla loro sapienza regolato: i poveri cessarono da quell'ora di formare un corpo sacro siccome prima, dato in tutela alle Chiese.
147.
La quarta massima regolatrice de' beni ecclesiastici, e impeditrice ch'essi nocessero all'integrità del Clero, si era che «non solo que' beni dovessero adoperarsi in usi pii e caritatevoli di più, acciocchè s'allontanasse nella loro dispensazione l'arbitrio e la cupidigia, fossero altresì compartiti ad usi fissi e determinati». — Tostochè s'aumentarono i beni della Chiesa, e incominciarono a divenir gravi gli abusi, benchè accidentali e parziali; la Chiesa provvidamente accorse, e volle che alle sostanze ecclesiastiche si fissassero usi determinati, onde l'antica quadripartizione di esse: una parte pel Vescovo, un'altra pe' Cherici inferiori, la terza a' poveri, la quarta alla fabbrica delle Chiese e al mantenimento del culto. I Concilii di Agde del 506, e di Orleans del 511 prescrivono questa divisione, riferendosi a disposizioni ecclesiastiche più antiche. Gregorio Magnola richiama in molte sue lettere (1). E certo niente v'avea di più opportuno per rimuovere la corruzione, che addur potevano le ricchezze, di fissarne per via di leggi gli usi precisi ne' quali dovevano essere dispensate (2): perocchè l'abuso è inevitabile, se di una grande quantità di beni rimane l'uso ad arbitrio di colui, al quale è affidata: e la corruzione è rovina anche di molti monasteri a questa causa appunto sembra doversi attribuire, che possedendo enormi ricchezze, non v'avea legge sufficiente che ne determinasse gli scopi principali; onde si spendevano come meglio ne pareva agli Abati od altri siperiori, in cui balia si trovavano.
(2) Egli par cosa probabile, che non sempre la quadruplice partizione si dovesse intendere di parti uguali, ma la misura delle singole parti variasse, secondo i bisogni. Il che osserva Carlo Sebastiano Berardi, nella sua opera sopra il Decreto di Graziano, dove, riferito un canone di Gelasio Papa, soggiunge: In quo sone illud observondum est, quodriportitam illam ecclesiasticorum redituum distributionem non adeo rigide esse intelligendum, ut od proportionem quandam, ut vocant, geometricam, non ad arithmeticam rationem exigatur. Gratlani Canones etc. P. II, C. XLXI: De Gelasio.
148.
Ma quando entrò il feudalismo nel Santuario, come si potè oggimai più mantenere questa santissima dispensazione? Era dell'interesse del signore, e per dir meglio di quell'aristocrazia violenta a cui si riduce il feudalismo che i beni si accumulassero in mano delle grandi famiglie, in mano di pochi; il potere secolaresco si fondava su questo accumulamento: ripugnava dunque la dispersione de' beni, l'equa caritatevole e fraterna distribuzione: l'istituzione de' benefizj divenne necessaria per assicurare il sostentamento alla parte più debole del Clero, la quale sarebbe perita di fame e di miseria, se non si fosse cosi salvata dall'avidità rapace de' gran signori, fra' quali si computavano i Vescovi. Questi non appartenevano oggimai più alla plebe, come ne' primi tempi (perocchè gli antichi Vescovi, sebbene di casati talor ricchissimi e nobilissimi, si facevano, pure, coll'esser Vescovi, tutti del popolo, di cui professavano la povertà): appartenevano alla classe degli aristocrati invasori e dominatori. D'allora l'abuso divenne legge: i canoni della Chiesa furono elusi con innumerevoli cavilli di parole (1), quando non erano colle violenze e colle aperte infrazioni: la divisione quadripartita, la determinazione delle entrate ecclesiastiche ad usi fissi fu insopportabile: l'antica massima naufragò nella pratica е con essa il suo spirito.
149.
«Lo spirito di generosità, la facilità in dare, la difficoltà in ricevere era la quinta massima con cui si riparava la Chiesa dal pericolo delle ricchezze ne' secoli anteriori al feudalismo. — Ella teneva altamente scolpita la nobilissima, ed inaudita parola di Cristo: «è meglio il dare che il ricevere (1)»: questa predicava come una buona novella al mondo schiavo dell'egoismo: questa facea rilucere in tutti i suoi atti, in tutte le sue operazioni. I Vescovi consideravano siccome un peso molesto i beni temporali e le loro amministrazioni, e lo sopportavano indottivi soltanto dalla carità (2): non vi erano ancora leggi che rendessero oltremodo difficile l'alienazione de' beni ricevuti: si riceveva con gran riserbo, si donava con gran larghezza. S. Ambrogio ricusava le offerte o le eredità, se conosceva poter esse cadere a danno de' parenti poveri: Non quærit, scriveva egli, donum Deus de fame parentum, e aggiungeva Misericordia a domestico progredi debet pietatis officio (3): il che la Chiesa potea fare allora, quando il suo spirito era libero, non legato da mille vincoli, e specialmente dalla protezione, come la chiamano, de' principi secolari. Perchè un effetto di questa servitù della Chiesa sotto la forza è anche questo appunto, l'esserle impediti tali atti generosi, che si spesso facevano i suoi Vescovi antichi, e la facevano tanto risplendere. Di Aurelio e di Agostino e dei loro sentimenti in questo argomento ho già toccato. In uno de' sermoni che il gran Padre d'Ippona tenne al popolo, egli ebbe a difendersi contro la voce che correa: Episcopus Augustinus de bonitate sua donat totum, non suscipit (che bella accusa!), onde era che si lagnava, che per questa generosa larghezza del santissimo Vescovo, niuno donasse più alla Chiesa d'Ippona, niuno la facesse erede. Possidio, nella vita che di lui scrisse, racconta, che restituì una possessione ad uno de' maggiorenti ipponesi che, avendola già da più anni donata alla Chiesa con regolare istromento, poscia se n'era pentito e l'avea al buon Vescovo ridomandata pel figlio; e gliela restituì rifiutando anche una somma di danaro che aveagli mandata pe' poveri, non però senza avvertirlo del suo peccaminoso contegno: siccome pure narra, che accortosi Agostino, come fra il Clero inferiore alcuno invidiava al Vescovo, nelle cui mani erano le facoltà della Chiesa (4); egli ne tenne a dirittura ragionamento alla plebe di Dio, colla quale que' Vescovi ogni cosa comunicavano, esponendo «che egli avrebbe amato di vivere delle collette della plebe di Dio, piuttosto che sofferire la cura e il governo di quelle possessioni; e però che egli era pronto di cederle loro, acciocchè tutti i servi e ministri di Dio vivessero a quel modo, in cui si legge nel Testamento antico, gl'inservienti all'altare, aver di esso altare comparticipato. Ma i laici non vollero mai in ciò consentire (5)».
(2) «Mi è Iddio testimonio, scrive S. Agostino nella lett. CXXVI, che tutta la procurazione di tutte queste cose ecclesiastiche, di cui si crede che noi abbiamo la signoria, è tollerata non amata da me, per la servitù, che io debbo alla carità de' fratelli e al timor di Dio: di maniera che se io potessi farne senza, salvo il mio ufficio, lo bramerei».
(3) ln Luc. C. XVIII.
(4) L'umanità si trova sempre in tutti i tempi difettosa; ma ciò che noi vogliamo distinguere è l'errore parziale ed eccezionale da quello che è passato in consuetudine universale, guastando per poco lo stesso corpo sociale, ed abolendo le massime su cui si regge.
(5) Sed nunquam id laici suscipere voluerunt. Possid. In vita August.
150.
S. Giovanni Grisostomo, parlando al suo popolo, adduce altresì la ragione del perchè la Chiesa non continuò a vivere delle collette accidentali de' fedeli; ma accettò ben anco donazioni di cose stabili. Dice, che il Clero fu necessitato a ciò fare, non per sè, ma pel bisogno di provvedere a' miseri, diminuito essendosi ne' fedeli quel fervore della primitiva carità. «A cagione della vostra strettezza di mano, egli disse, ha la Chiesa bisogno di avere quello che ora si ha. Poichè se tutto si facesse in modo conforme alle leggi apostoliche, il provento di lei dovrebbe essere l'animo vostro, il quale certo sarebbe e una sicura dispensa, ed un tesoro non consumabile. Ma or che voi tesoreggiate sopra la terra, e tutto chiudete ne' vostri ripostigli, ed essa, la Chiesa, ha uopo di spendere e pe' ceti delle vedove, e pe' cori delle vergini, e per le venute degli ospiti, e per le afflizioni di quelli che debbono viaggiare lontano, e per le calamità di coloro che sono ne' ferri, e per le indigenze di altri che sono manchi e mutilati, e per altre cause ancora di tal fatta; che si può egli mai fare? (1)».
151.
Ora chi mai non deplorerà tanto cangiamento sopravvenuto ne' secoli di rovine e di barbarie che succedettero nella Chiesa, pel quale un Clero di così alti spiriti fornito, di tanta elevatezza liberalità e carità, giunse, al tutto diverso da sè medesimo e dalla sua propria natura, a meritare di venire stimmatizzato col verso:
«In cui usa avarizia il suo soperchio!»
Se ne considerino le due cause, l'una degli atti de' principi barbari, l'altra di quelle disposizioni che fu costretta di fare la Chiesa a propria difesa, per evitare un male maggiore.
152.
Avendo il feudalismo, come vedemmo, fatto cangiar natura a' beni ecclesiastici, e venendo questi frequentemente alienati, e concessi ai laici da' principi, e dagli stessi Prelati feudatari; la Chiesa dovette opporsi all'abuso colle sue leggi; e quindi cominciò la legislazione a prendere una tendenza tutto opposta alla massima antica, cioè ella fu volta da quell'ora «a facilitare alla Chiesa il più possibile l'acquisto e la conservazione de' beni temporali, e a difficultarne il più possibile l'alienazione». I legislatori sogliono accorrere colle loro disposizioni là dove l'abuso è maggiore, e nel caso nostro egli era estremo; ma ben sovente egli accade che tutto intesi a impedire l'abuso, essi facciano anche più che non bisogni; ovvero trasandino di considerare altri inconvenienti che nascono da quella stessa legislazione, altri beni che rimangono per essa impediti collo scemamento soverchio della libertà, o così leghino insieme coll'abuso anche l'ottimo uso; o finalmente accade ancora che quella legislazione, che avea per suo legittimo intento di sterminare l'abuso, sopravviva all'abuso già vinto, trovandosi quindi appresso l'umanità avvincolata e costretta da leggi prive di quella ragione, che quando vennero emanate le giustificava. Nel caso nostro egli era un gran male certamente, che gli ecclesiastici beni fossero frodati della loro destinazione, passassero in usi profani, si dessero a mercede di servigi e d'ufficj secolareschi, tradite così le pie intenzioni degli oblatori; ma egli era pure un grande e sommo bene, che i Vescovi, col consiglio del loro Clero, potessero rinunziare opportunamente le donazioni e le eredità che alla Chiesa offerivansi, potessero vendere le possessioni e distribuirle, senza troppe difficoltà e formalità, a tutti quelli che ne abbisognassero, venendo così la Chiesa in ajuto di tutti i mali di cui è aggravata l'umanità. La Chiesa è già ricca abbastanza, s'ella ha un tesoro di carità, e un esercizio amplissimo di beneficenza: la Chiesa è abbastanza felice se può dire con S. Ambrogio: Aurum Ecclesia habet, non ut servet, sed ut eroget, et subveniat in necessitatibus (1), Ora qual senso doloroso, qual danno agli stessi ben intesi interessi della Chiesa, quale scandalo non è il pensiero, l'opinione prevalente, che il Clero abbia le mani sempre aperte a ricevere, e sempre chiuse a dare? Certo la considerazione che tutto ciò che entra nell'arca della Chiesa, non ne esce forse più in perpetuo, ella è cosa che rattrista, che genera la disistima, suscita l'invidia, estingue la liberalità de' fedeli, produce la sospicione che vi si accumulino col proceder de' secoli que' tesori di cui abbisognano le famiglie per vivere, il commercio per fiorire: lo stato per difendersi: presta un appicco a' governi per intervenire nelle disposizioni degli ecclesiastici beni, detta loro le leggi disonorevoli di ammortizzazione, disamora e disunisce sempre più il popolo dal Clero e dalla Chiesa, occasiona l'incredulità, provoca le maldicenze e le calunnie degli empj, e finalmente arma il furore della moltitudine sommossa dai tristi, o la cupidigia de' potenti a rompere violentemente l'arca serrata per farne uscir l'oro, ad atterrare le porte chiavate del santuario per rapirne i tesori. Per me stimo assai più desiderabile, assai più utile alla Chiesa di Dio il non dare punto cagione a tutti questi mali, che non sia l'abbandonare di temporali dovizie, o l'impedire che qualche parte di essa venga, foss'anco inconsideratamente, alienata.
153.
Le ammonizioni, i canoni, le pene della Chiesa giunsero poco a poco ad ammansare i barbari conquistatori, e ad impedire che dissipassero a lor talento il patrimonio ecclesiastico. Ma è da avvertire che il secolare potere non nocque solo colla violenza, e colle depredazioni: nocque assai più colle sue stesse liberalità, nocque colle leggi civili dettate in ispirito secolaresco e profano a tutela e protezion della Chiesa e de' suoi beni. Il governo civile non ha il senso ecclesiastico ed ogni qualvolta mette mano nel santuario, ne raffredda e spegne col suo tocco lo spirito. Carlo Magno e Ottone I favorirono la Chiesa: e pure l'infelice regalo de' feudi (al quale non erano già unicamente mossi dalla devozione alla Chiesa, ma da quella politica che voleva ad un tempo scemar la potenza de' nobili e assudditarsi quella de' Vescovi) fu pur l'amo fatale, al quale il Clero fu preso. Da quell'ora il potere secolare s'ingerì sempre nella Chiesa; e le sue grazie, le sue carezze finirono col toglierle la libertà, che è l'aria di cui ella vive. Che può il governo temporale, se non ajutare la Chiesa colla forza bruta, unico mezzo suo naturale d'operazione? E bene, la forza è appunto d'un'indole direttamente opposta allo spirito della Chiesa: la Chiesa effigiata con in mano le catene, i fasci, le scuri qual personaggio non rende? Inorridisce la vista. Qual maschera crudele! Ella ributta non solo i cattivi, gli stessi buoni. Il temporale potere oltracciò nè conosce; nè serba i limiti della sua protezione: avvezzo al comando, comanda fin dove può: inetto a conoscere il vero ben della Chiesa, pretende esserne giudice, e ripone questo bene unicamente nel vantaggiarla negli ordini della terra: tratta l'amministrazione de' beni di lei, come fa de' suoi proprj, disconoscendo che quelli sono di tutt'altro genere: ne accumula il più che può, permette che ne sieno spesi il meno che può: arricchisce la Chiesa, se fa bisogno, anche di privilegj e d'immunità, di una protezione esagerata ed eccezionale, talora contro giustizia, riuscendo opposta all'uguaglianza civile, e sempre poi odiosa al popolo che non ne partecipa (1). Così la massima della facilità in dare, e della difficoltà in ricevere, che è connaturale alla Chiesa, diventa ad essa impossibile a praticarsi, quando i suoi beni non sono più liberi in sue mani, ma servi del laicale potere.
A render valide le alienazioni de' beni ecclesiastici si moltiplicarono le formalità, sopra quelle richieste a convalidare le alienazioni de' beni privati; e fra l'altre disposizioni si prolungarono gli anni della prescrizione: all'opposto alla validità d'un testamento in favor della Chiesa si diminuirono le formalità richieste per tutti gli altri testamenti: fu egli giusto? Considerate queste disposizioni come armi di difesa contro le frodi che abbondavano a usurpare quel della Chiesa assai più che a usurpare quel de' privati, esse non si possono riprendere. Considerate sotto un altro aspetto, alcune di tali disposizioni meritano altresì lode di giustizia, in quanto cioè emendavano le leggi civili, e preparavano la via a leggi più eque, di cui avrebbero un tempo goduto egualmente tutti i cittadini. Così le formalità richieste dalle leggi romane per la validità di un testamento erano, o certo eran divenute, eccessive. La Chiesa se ne richiamò per conto delle sostanze ecclesiastiche, e cosi mostrò la via alla riforma della legislazione in tal punto, e accrebbe con ciò la libertà di testare a tutti. Or poi, corretta la legislazione, egli è desiderabile che la Chiesa fra le nazioni incivilite non sia favorita d'alcun privilegio che migliori la sua condizione nell'ordine temporale; bastandole che le si lasci quel privilegio, o per meglio dire quel diritto sacro e invlolabile ch'ella si ha per natura, la libertà, la piena libertà non solo di ricevere e di amministrare da sè quanto spontaneamente le offeriscono o le hanno già offerto i fedeli, ma altresì di dare, di largheggiare secondo quello spirito di carità che l'anima e la informa.
154.
Nè solo in questo la Chiesa si mostrava d'indole eccelsa, ma ben anco «in amare che la dispensazione de' suoi beni apparisse agli occhi del pubblico», che è la sesta massima che ella poneva in atto ne' primi tempi. — Abbiam veduto che gli antichi Vescovi conferivano ogni cosa col loro popolo, e col loro Clero, questo facevano anche per ciò che riguardava i beni temporali. Oltracciò, i Sacerdoti e i Diaconi che gli amministravano doveano avere il suffragio della plebe cristiana, secondo la tradizione apostolica (1): esser persone a lei note, di piena sua confidenza. Con che delicato riserbo non propone S. Paolo a que' di Corinto ch'essi stessi eleggano quelli che dovessero portare le loro elemosine ai cristiani bisognosi di Gerusalemme! «Ogni domenica ciascuno metta da parte quello che stima, acciocchè quand'io sarò venuto non si facciano le collette. E quando sarò presente, allora manderò quelli che voi avrete stimati degni con lettere, a portare le vostre grazie a Gerusalemme. E se sarà conveniente che vada anch'io, verranno meco (2)». Egli era Vescovo e Apostolo; aveva tutto il potere: tuttavia non vuole egli stesso eleggere i portatori di quelle elemosine, ne lascia al popoło la scelta; omnia mihi licent, sed non omnia expediunt (3). Avrebbero forse dubitato della fedeltà dell'Apostolo? No; ma non basta in punto di temporali interessi, l'uomo santo s'astiene il più che può dall'ingerirsene: riserba il suo potere apostolico per le sole cose necessarie, del resto lascia libera la plebe: è naturale e giusta soddisfazione a questa, che possa fare anch'essa alcuna cosa, che vegga co' suoi occhi, che adoperi il suo giudizio, che s'interessi nel bene, vi ponga la mano ella stessa. Così S. Giovanni Grisostomo non temeva di offerirsi al suo popolo di rendergli ragione dell'uso che faceva. de' redditi della Chiesa: Sumus etiam parati vobis reddere rationem (4): e allo stesso modo, nello stesso spirito, procedevano tutti gli antichi Vescovi.
(2) 1 Cor. XVI, 2-4.
(3) Ibid. VI, 12.
(4) In Ep. ad Cor. Hom. XXI.
155.
Certo, che l'uso de' beni della Chiesa sia fatto a dovere non basta: che se ne renda conto a' soli governi nè pure è sufficiente alla soddisfazione del popolo cristiano che offerisce il fatto suo piamente alla Chiesa. Laonde, sarebbe alla Chiesa d'incredibile giovamento in prima, che a tutti i beni posseduti da lei, specialmente dagli Ordini religiosi, fossero, con sapienti leggi della Chiesa medesima, determinati colla maggior precisione possibile gli usi: a ciascun uso assegnata una congrua porzione: nè manchevole nè soverchia: si pubblicasse di poi un annuale rendiconto, sicché apparisse a tutto il mondo il ricevuto e lo speso in quegli usi con una estrema chiarezza, sicchè l'opinione de' fedeli di Dio potesse apporre una sanzione di pubblica stima o di biasimo all'impiego di tali rendite, e così ne sarebbero anco i governi informati, senza bisogno di altro. No, per fermo, non conviene, non è espediente che la giustizia e la carità, secondo la quale opera la Chiesa nell'amministrazione economica de' suoi beni temporali di qualunque specie, si resti sotto il moggio nascosta, anzi egli è più che mai desiderabile che risplenda siccome ardente face sul candelliere. Oh quanto ciò non concilierebbe a lei gli animi de' fedeli! Che istruzione, che esempio non potrebbe dar ella all'universo intero! E solamente allora la debolezza de' suoi ministri sostenuta dal giudizio pubblico si terrebbe lontana dal cedere all'umana tentazione. Perocchè l'uomo, quando non può peccare di nascosto, non pecca, od almeno non pecca a lungo. La quale felice necessità di dar conto di sè al pubblico de' fedeli, anzi alla società degli uomini, risveglierebbe le coscienze di molti, sonnacchiose per mancamento di stimoli sufficienti, e farebbe sentire il bisogno che i posti ecclesiastici non fossero occupati se non da valentuomini forniti di una perfetta e patente rettitudine, e d'una vera pietà.
156.
Finalmente accennerò una settima ed ultima massima: che «i beni della Chiesa vengano da lei stessa amministrati con ogni vigilanza e diligenza». — Questo ha sempre raccomandato la Chiesa a quelli a cui ne affidò l'amministrazione, dichiarando quelle sostanze esser di Dio e de' poveri, e avervi un cotal sacrilegio, se per incuria e pigrizia de' procuratori qualche parte se ne perdesse: ed è egli di tanto maggior momento questa massima, che trascurata, diede maggior appiglio a' governi di mettervi la mano e far tutto essi, onde la servitù della Chiesa e de' suoi beni si perpetua.
157.
Vero è che la Chiesa ora perseguitata, ora oppressa, sempre lottante col poter temporale amico e nemico, e oltracciò sempre intesa a cure troppo più gravi del ben delle anime, non ebbe mai tempo bastevole a ridurre l'anuministrazione de' suoi beni perfetta, a stabilir un sistema economico da tutte parti bene organato e difeso. Che se si considera quanto ha ricevuto la Chiesa, ne' vari secoli della sua vita, e quanto ell'ha perduto per difetto di questa vigilante ed industre amministrazione economica; egli è impossibile a dire, che cosa ora sarebbe la Chiesa, se i suoi beni temporali fossero stati sempre da' sugi ministri sapientemente amministrati. Ma la forza dello spirito umano è limitata, ed ella non arriva mai a compire due imprese diverse ad un tempo, sebbene legate fra loro: lo scopo spirituale della Chiesa doveva necessariamente assorbirne tutta, per poco, l'attenzione, e non poteva contemporaneamente esser guari sollecita del buono andamento della parte materiale, fino a tanto che la sua legislazione disciplinare più importante (quella che riguarda direttamente la salute dell'anime) non fosse stata prima a pieno stabilita, e che l'esperienza non avesse dimostrato il danno incalcolabile che dal negligere la parte materiale ridondava alla stessa parte spirituale. Or che a principio ciò non fosse possibile, nè pure fosse espediente, me ne persuade l'esempio di Cristo, che si contentò d'avere un amministratore infedele fra' suoi stessi Apostoli, acciocchè, parmi, servisse di documento che niente dovea distrarli dallo spirituale regime, nè pure il pericolo di temporali detrimenti. E qui farò fine concludendo, che da quanto fu ragionato risulta ad evidenza, che allorquando Pasquale II ebbe fatto la magnanima proposta di rinunziar ai feudi, il grand'uomo avea posto la scure alla radice della mala pianta, ma l'età avea una complessione troppo stemperata per sostenere un tanto rimedio.
158.
Quest'opera, incominciata nell'anno 1832 e compita nel seguente, dormiva nello studiolo dell'autore affatto dimentica, non parendo i tempi propizii a pubblicar quello ch'egli avea scritto più per alleviamento dell'animo suo afflitto del grave stato in cui vedeva la Chiesa di Dio, che non per altra cagione. Ma ora (1846) che il Capo invisibile della Chiesa collocò sulla sedia di Pietro un Pontefice che par destinato a rinnovare l'età nostra e a dare alla Chiesa quel novello impulso che dee spingere per nuove vie ad un corso quanto impreveduto altrettanto maraviglioso e glorioso; si ricorda l'autore di queste carte abbandonate, nè dubita più di affidarle alle mani di quegli amici che con esso lui dividevano in passato il dolore ed al presente le più liete speranze.