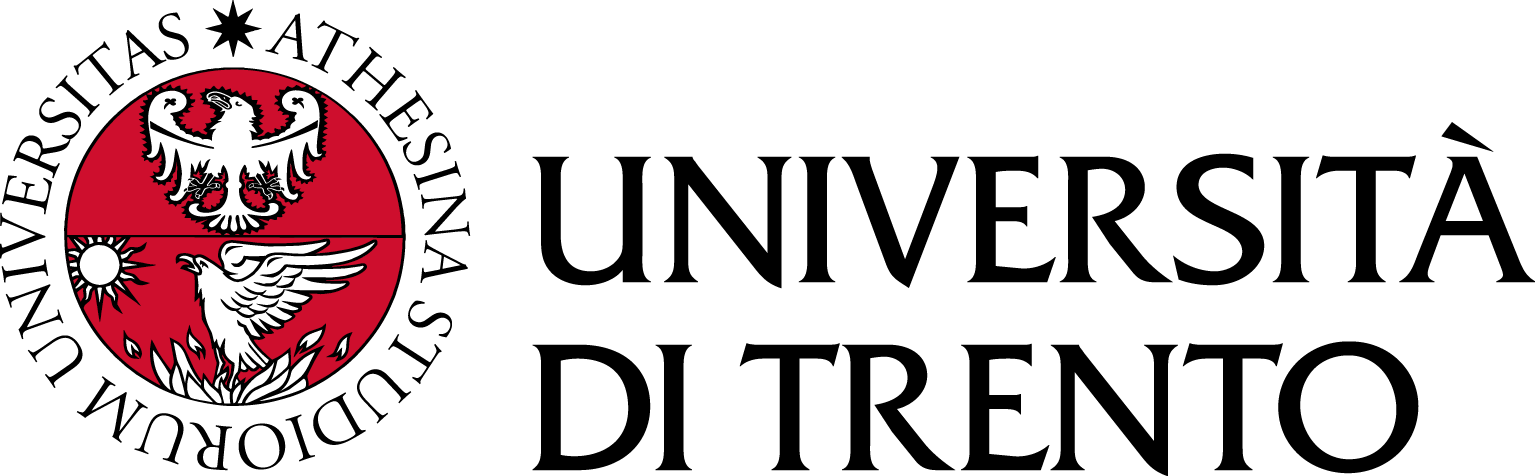Biografia
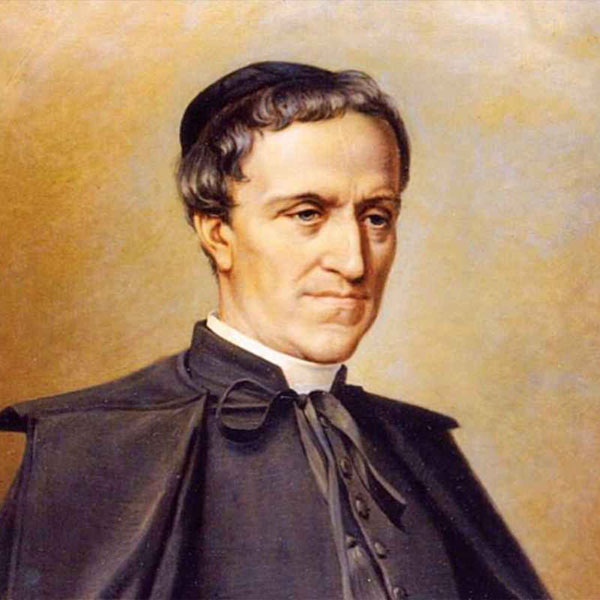
Di intelligenza precocissima, manifesta sin da bambino un singolare amore per lo studio e la ricerca, che può coltivare incoraggiato dal sostegno dello zio Ambrogio, artista e architetto, e dalla nutrita biblioteca di famiglia.
Compiuti gli studi ginnasiali, scopre nella filosofia, come scriverà egli stesso, «lo studio sommo, primo, fondamentale, principio e chiave di tutti gli altri». Maturata in lui la vocazione al sacerdozio, intraprende gli studi universitari di teologia a Padova, dove si reca il 22 novembre 1816. Vi rimarrà tre anni, dimorando presso la Basilica di S. Antonio e alternando lo studio alla preghiera, alla conversazione con gli amici – ivi conosce Niccolò Tommaseo, col quale instaura un’amicizia che durerà tutta la vita –, a frequenti visite a Venezia, all’acquisto appassionato di libri antichi e rari.
Ordinato presbitero a Chioggia il 21 aprile 1821, il giorno dopo, 22 aprile – Domenica di Pasqua – celebra la sua prima messa nella chiesa dell’ex convento di Santa Caterina a Venezia, da alcuni anni riorganizzato in Liceoconvito (dal 1865 sarà intitolato a Marco Foscarini) sotto la direzione dell’abate Antonio Maria Traversi, cui il Roveretano era legato da amicizia. Nel 1822 conclude gli studi universitari laureandosi in Sacra Teologia e Diritto Canonico con una tesi sulle Sibille.
Nell’aprile 1823 accompagna a Roma il Patriarca di Venezia Ladislao Pyrker, ed è personalmente incoraggiato da Papa Pio VII ad approfondire gli studi filosofici.
Nel febbraio 1826 Rosmini si reca a Milano, dove conosce Alessandro Manzoni. Tra i due nasce un sentimento di profonda ammirazione, che si consoliderà ulteriormente nel tempo.
Matura in quegli anni la convinzione della necessità di sanare il malessere della cultura del tempo attraverso l’elaborazione di una seria alternativa filosofica. Si ritira allora in riflessione al Monte Calvario di Domodossola, dal febbraio al novembre 1828, dove prende forma l’idea della fondazione dell’Istituto della Carità.
Recatosi a Roma, il 15 maggio 1829 vi è ricevuto dal Papa Pio VIII, che incoraggia il suo operato riconoscendone la vocazione allo studio e produzione testuale filosofica e teologica: «È volontà di Dio che voi vi occupiate nello scrivere libri: tale è la vostra vocazione. La Chiesa al presente ha gran bisogno di scrittori: dico, di scrittori solidi, di cui abbiamo somma scarsezza. Per influire utilmente sugli uomini, non rimane oggidì altro mezzo che quello di prenderli colla ragione, e per mezzo di questa condurli alla religione. Tenetevi certo, che voi potrete recare un vantaggio assai maggiore al prossimo occupandovi nello scrivere, che non esercitando qualunque altra opera del sacro ministero». Insieme il Papa manifesta approvazione per il suo progetto di fondazione dell’Istituto della Carità, e Rosmini, raccolta dalle parole del Pontefice la duplice missione, dà alle stampe a Roma nel 1830 le Massime di perfezione cristiana e il Nuovo Saggio sull’origine delle idee.
Negli anni successivi il neonato Istituto della Carità si diffonde in vari centri d’Italia e d’Europa mentre gli schietti sentimenti di italianità del Roveretano e il suo obbediente spirito di appartenenza alla Chiesa universale lo rendono sospetto agli occhi del governo austriaco, al punto che Radetzky arriva a definirlo “uomo di princìpi pericolosi”. Ciò lo indusse a spostare il centro delle sue attività dal Trentino e LombardoVeneto al Piemonte, in particolare a Domodossola e a Stresa.
Nel 1839 Papa Gregorio XVI approvava ufficialmente l’Istituto della Carità (oggi noto come Congregazione dei Padri Rosminiani) con la Lettera apostolica In sublimi, nella quale elogiava Rosmini come «Uomo fornito d’ingegno eccellente e singolare, dall’animo ornato di egregie doti, eccezionalmente illustre nella scienza delle cose divine ed umane, chiaro per esimia pietà, religione, virtù, probità, prudenza e integrità, splendente per meraviglioso amore e attaccamento alla religione cattolica e a questa Sede Apostolica».
Il diffondersi della fama di Rosmini e delle sue opere, che cominciano ad essere oggetto di studio negli ambienti accademici europei, gli frutta le prime controversie, tra cui spicca quella con Vincenzo Gioberti, e polemiche spesso manifestamente inquinate da invidie, gelosie ed avversione per l’apertura – per quanto prudente e criticamente distanziata – alla modernità filosofica che caratterizzava la riflessione del Roveretano.
Nell’agosto 1848 Rosmini viene inviato dal governo piemontese in missione diplomatica presso Papa Pio IX, per trattare un Concordato tra la Chiesa e il Regno e dar luogo ad una Confederazione degli Stati italiani sotto la presidenza del Pontefice. Pio IX, accolto con calore Rosmini, gli chiede di prepararsi a ricevere il cardinalato, con l’intenzione di nominarlo poi Segretario di Stato. La missione però fallisce, giacché la linea del governo piemontese vira verso la costituzione di una lega militare antiaustriaca, e Rosmini, considerato esaurito il suo compito, si dimette dall’incarico.
Nei mesi successivi, cresciute le tensioni a Roma, dopo l’assassinio di Pellegrino Rossi (15 novembre 1848) e i torbidi che ne seguono, Rosmini è proposto Presidente del Consiglio e Ministro dell’Istruzione dello Stato romano, ma egli rifiuta di porsi a capo di un governo che riconosce imposto al Papa dalla corrente democratica oltranzista. Seguito Pio IX nell’esilio di Gaeta, gli suggerisce ancora una politica costituzionale, ma a causa del prevalere nella Curia della linea intransigente, ne viene emarginato. L’iniziativa di alcuni prelati a lui avversari riesce a far condannare a sorpresa da parte della Congregazione dell’Indice (frettolosamente riunita a Napoli, in una seduta irregolare) le sue opere Delle cinque piaghe della Santa Chiesa e la Costituzione secondo la giustizia sociale (30 maggio 1849).
Sfuma così la prospettiva del cardinalato, e Rosmini ritorna con una serenità non compromessa dai rovesci di quegli anni a Stresa, dove è circondato dal sostegno affettuoso di amici quali il Manzoni. Ivi si concentra sulla direzione e consolidamento dell’Istituto della Carità e riprende un’intensa attività di scrittura, applicandosi in particolare all’ampia “Summa” del suo pensiero cui dà il titolo di Teosofia.
L’imperversare delle polemiche antirosminiane decide Papa Pio IX a costituire una Commissione esaminatrice degli scritti del Roveretano di cui sceglie personalmente i membri, che si esprime il 3 luglio 1854 con un decreto di riconoscimento netto e senza riserve dell’ortodossia dottrinale delle opere di Rosmini.
Dal settembre di quell’anno, una misteriosa e dolorosa malattia lo porta alla morte il 1° luglio 1855. Manzoni al capezzale, ne raccoglie quello che i discepoli recepiranno come il suo testamento spirituale, giacché alla domanda sconsolata dell’affezionatissimo amico, “che faremo senza di Voi?”, Rosmini risponde: “Adorare, tacere, godere”.
Più tardi l’autore di Promessi Sposi definirà il Roveretano «una delle cinque o sei più grandi intelligenze che l’umanità abbia prodotto nei secoli».
Rigenerare l’integrazione solidale di Filosofia e Teologia. Radici e motivazioni profonde della riflessione rosminiana
La riflessione filosofica e teologica di Rosmini prende forma in rapporto all’avvertita urgenza della ricomposizione del nesso solidale del pensiero filosofico occidentale con la teologia cristiana e la datità del depositum fidei che ne rappresenta il fondamento.
Preoccupato per l’ormai plurisecolare estraniazione della filosofia moderna dal pensiero cristiano, colta l’importanza fondamentale del fenomeno e le possibilità offerte dal suo tempo per una ricomposizione della frattura, Rosmini si spende soprattutto in direzione di un rinnovamento della filosofia cristiana, ponendosi seriamente in ascolto della modernità e anticipandone persino alcuni tra gli esiti più significativi cui ci è dato assistere ai nostri giorni. Ne viene una geniale riformulazione del pensiero filosofico generatosi nell’alveo della tradizione cristiana, saldamente ancorato alle linee agostiniana e tomista, che il Roveretano sa far convergere in una nuova sintesi, profonda e completa, al punto che – se guardiamo alle grandi proposte sistematiche filosoficoteologiche – è possibile, anzi, opportuno considerare Rosmini, dopo Agostino e Tommaso, il terzo grande pilastro nell’arco storico tracciato dal pensiero cristiano. Il suo sistema si erge infatti quale terzo grande assetto teoretico dell’integrazione filosoficoteologica che oltretutto riesce a porsi a sintesi delle linee platonica e aristotelica rappresentate rispettivamente dall’Ipponense e dall’Aquinate.
Rosmini avvertì una particolare spinta ad incidere positivamente nella cultura del tempo e a rispondere alle esigenze di una formazione integrale della persona umana, una formazione che potesse valorizzarla in tutte le dimensioni. Nella concretizzazione di questo preciso indirizzo egli fu coerente sin nella stessa fondazione dell’Istituto della Carità, avendolo concepito per la promozione della caritas nelle sue dimensioni materiale, spirituale e intellettuale.

Forma dell’intelletto e lume della ragione: l’Idea dell’essere
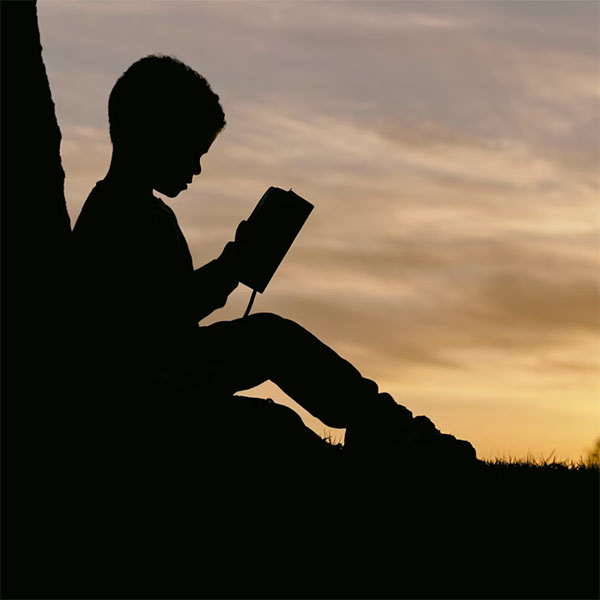
La preoccupazione di Rosmini di ristabilire un’integrazione solidale tra la riflessione filosofica e il sapere teologico si misura con il tratto percorso dalla modernità. Questa ha in particolare tracciato una rotta in deriva conseguente all’insorgere del principio di soggettività come baricentro del filosofare e, infine, dell’intero senso dell’essere – o del senso dell’Intero –, fino agli esiti soggettivistici del criticismo kantiano, ulteriormente radicalizzati con l’idealismo assoluto hegeliano.
Rispetto a tali esiti del percorso intrapreso dalla modernità, Rosmini è animato dalla preoccupazione fondamentale di tener fermo il piano veritativo dell’oggettività della conoscenza e della vita spirituale dell’uomo, contro il soggettivismo empiristico e riduzionista degli illuministi e degli idéologues e contro il soggettivismo assoluto kantiano e il suo coerente sviluppo nell’idealismo postkantiano e, in generale, gli esiti relativistici della piega assunta, sotto queste spinte, dalla cultura moderna.
Al tempo stesso, però, nella via imboccata dalla modernità filosofica egli non manca di avvertire la ragione di un’istanza profonda che merita di essere recepita. Questa consiste sostanzialmente in quello stesso principio di soggettività che del moderno rappresenta il nerbo, e che, fatto correttamente reagire sulla classicità della riflessione filosofica dell’Occidente nel suo sviluppo storico, può operare un riequilibrio dell’assetto gnoseologico della coscienza, talvolta sbilanciato in una comprensione oggettivistica della relazione intenzionale.
L’opera con la quale Rosmini presenta pubblicamente la propria proposta speculativa in forma organica ed estesa è il Nuovo Saggio sull’origine delle idee, pubblicato a Roma nel 1830. Accolta la nozione di un a priori nella coscienza – e, con ciò, la distinzione kantiana tra un a priori e un a posteriori nell’esperienza conoscitiva – Rosmini riduce la pluralità delle forme nelle quali Kant riteneva si articolasse alla sola idea dell’essere: «L’intendimento puro dell’uomo non è ristretto, non è limitato; ammettiamo in lui una sola forma che chiamiamo la forma della verità, la quale non restringe punto l’intendimento, non essendo ella forma particolare, ma bensì universale, categorica, cioè tale che abbraccia tutte le forme possibili» (Teodicea, 151). Ogni certezza estrinseca trova dunque fondamento ultimo nella certezza intrinseca consistente nella conoscenza intuitiva ed immediata della verità stessa: «Il principio ultimo della certezza riducesi ad un solo, cioè alla verità creduta dalla mente con un’intuizione immediata, per sé evidente, senza segni, senza argomenti di mezzo» (Nuovo Saggio, 1054). Tale intuizione immediata è l’idea dell’essere, che tanto pertiene alla soggettività pensante quanto è principio oggettivo costituente la stessa forma della soggettività razionale.
L’idea dell’essere è innata, inderivabile né dalle sensazioni (quali modificazioni soggettive, esse riguardano infatti le determinazioni empiriche degli enti), né dall’intelletto mediante l’astrazione (che procede, dall’esperienza del reale concreto, per via sottrattiva di determinazioni particolari e, al più, fa scoprire al fondo, ancora, l’idea dell’essere come presupposta); è semplice (non ha estensione né materialità), una, universale, necessaria, immutabile, eterna; essa non è idea di alcunché di determinato – non è neppure l’idea di Dio –, ma è l’idea universalissima dell’essere come possibile e indeterminato, e in ciò radice di ogni determinazione; essa è presupposta da ogni giudizio formulato dalla coscienza sugli enti reali, giacché è il principio stesso che incessantemente permette all’intelletto di riconoscere l’esistenza di ogni ente che cade nell’esperienza come ciò che è. Per questo motivo, l’idea dell’essere è implicita in ogni altra, giacché nell’idea di ogni ente vi è innanzitutto il suo essere qualcosa, oltreché tutte le determinazioni che lo specificano nella sua singolarità. L’idea dell’essere è, dunque, la forma e il lume della ragione.
Essa però non basta, da sé sola, a produrre la conoscenza degli enti reali, che necessitano di presentarsi in concreto entro, per così dire, questo fascio di luce, attraverso la sensazione.
La conoscenza dunque consiste, compiutamente, nella sintesi (1) dell’idea dell’essere quale forma con una (2) idea empirica derivante dalla sensazione o dal “sentimento fondamentale corporeo” quale materia che porge all’intelletto le determinazioni dell’essere reale e dall’idea dell’essere viene informata. Un (3) giudizio esprime la sintesi operata tra l’idea dell’essere e la sensazione o sentimento di sé. La conoscenza è perciò, a seconda dell’angolazione dalla quale la si consideri, la determinazione dell’essere possibile mediante la sintesi della stessa con un’idea particolare, vale a dire l’universalizzazione di un’idea particolare mediante la sintesi della stessa con l’idea dell’essere possibile.
Rosmini designa l’atto sintetico che dà luogo alla conoscenza come percezione intellettiva: percezione in quanto il soggetto coglie nell’orizzonte della sensibilità l’ente che lo modifica, intellettiva in quanto nel cadere entro il lume della ragione costituito dall’idea dell’essere, detto ente prende forma visibile all’intelletto nel profilo della propria singolarità determinandosi nel campo luminoso dell’essere indeterminato. Viene così a formarsi l’idea della res particolare. A partire dalle idee particolari, poi, mediante l’universalizzazione, che Rosmini tratta come una modalità dell’astrazione, l’intelletto ricava tutte le altre idee. Mediante l’universalizzazione, infatti, l’intelletto prescinde innanzitutto dalla sussistenza della cosa data in presenza e conosciuta nella sua concretezza e ne trae l’idea pura (consistente nella sola possibilità dell’esistere della cosa); prescindendo poi, con l’astrazione, da alcuni caratteri o determinazioni, mentre ne tiene altri per fermi, ricava le idee specifiche e generiche, per gradi di generalità crescenti, fino a trovarsi di fronte al puro essere, che appare però quale fondo già presupposto dall’intero processo e non il suo risultato, giacché l’essere non è un genere e non si può raggiungere per astrazione, cosicché in ciò Rosmini non perde la fondamentale lezione aristotelica e tiene ben salda la polivocità analogica dell’essere che la modernità sembra aver gradualmente smarrito lungo la china di una crescente comprensione univocista, originatasi dalla tarda Scolastica e ormai all’epoca del Roveretano già stabilizzata in forma monolitica.
Conseguenza rilevante della gnoseologia rosminiana è che la conoscenza che l’io ha di sé risulta tanto originaria e certa quanto la conoscenza che il soggetto ha di qualsiasi altro ente.
Decisivo in tal senso è il concetto, introdotto dal Roveretano, di (a) sentimento fondamentale corporeo. Questo consiste nella sensazione, unitaria e continuativa, della propria vita organica. L’anima, quale principio senziente, sente continuamente il corpo al quale è unita e, rispetto a questo stato di avvertimento costante che è il sentimento fondamentale, avverte l’azione dei corpi esterni come (b) modificazione del sentimento medesimo, insieme alla quale si dà la (c) percezione sensitiva del corpo come esterno, altresì designata da Rosmini sensazione extrasoggettiva, col che viene ad essere distinta dal sentimento fondamentale e dalla sua modificazione come complesso delle sensazioni soggettive (ab). Propriamente parlando, dunque, non il corpo sente, ma l’anima sente attraverso il corpo.
In rapporto a ciò, l’esistenza della realtà esterna alla coscienza perde il carattere problematico sul quale, a partire da Cartesio, la modernità si era avviluppata fino all’identificazione di ideale e reale teorizzata con l’idealismo assoluto di Hegel. Mediante il suaccennato processo di universalizzazione, infatti, a partire dall’idea dell’essere e in rapporto all’esperienza sensibile, l’intelletto trae i princìpi logici di identità e contraddizione, ma pure il principio di causalità.
Unità e Totalità: il sistema come enciclopedia delle scienze
Nel promuovere la rinascita di una vera filosofia, Rosmini ne addita i “due caratteri” essenziali nell’unità e nella totalità, e prospetta che con il primo la filosofia medesima «dia consistenza e pace alle cognizioni, col secondo dia quell’immenso pascolo allo spirito umano, del quale egli è famelico, e senza il quale non può reggere, e cader deve necessariamente, come ogni qual volta è sottratto all’uomo un bene essenziale al suo spirito, in una specie d’intellettuale frenesia. La prima verità, forma della ragione, essendo unica e semplicissima in se medesima, dà necessariamente la più perfetta unità a tutto quel sapere che da lei si deriva; e non essendovi alcun sapere che da lei non si derivi e non si parta, necessariamente ella abbraccia il tutto in una fecondità immensa, e quindi è subbietto di una filosofia che ha il carattere della totalità» (Nuovo Saggio, Pref., 7).
Le parole di Rosmini mostrano chiaramente come egli intenda con unità il sapere del fondamento, che permette di fondare, nella stabilità dell’essere, ogni dato di sapere, e con totalità il sapere del molteplice dell’essere nelle sue determinazioni fino alle pieghe più minute della realtà naturale, quale è disponibile alla presa dell’intelletto. Nel Cristianesimo, che condivide con l’autentica filosofia l’unico principio della Verità, egli riconosce la dottrina che più di qualsiasi altra «congiunge in sé medesima l’unità più perfetta colla totalità più assoluta» (11) e il motore del vero progresso di ogni attività e disciplina, giacché «le stesse scienze umane non prosperano felicemente e con progresso non interrotto se non quando sono fatte germogli di quel seme, e tralci di quella salda radice» (14).
Ora, per Rosmini il sapere dell’unità si dà in forza della capacità di concepire l’essere in universale che, come si è potuto vedere, costituisce lo stesso lume della ragione. Così la struttura logica della conoscenza della realtà a livelli di universalizzazione crescente, garantisce l’unità del sapere come notizia della totalità senza che questa comporti l’esaustività dell’assunzione a contenuto delle determinazioni dell’essere, il che rifletterebbe piuttosto l’intendimento hegeliano dell’enciclopedia: «Il sapere umano, in quanto si dispone ed ordina scientificamente, può essere rappresentato da una piramide a forma di tetraedro: la base sterminatamente grande è formata, quasi d’altrettante pietre, da’ veri particolari, i quali sono innumerevoli; sopra di questi corre un’altra serie fatta di un ordine di quei veri universali, che fra gli universali, sono i più prossimi ai particolari, e anche questi moltissimi, ma non quanti i primi: e se così di mano in mano si ascende agli altri strati o scaglioni superiori, ciascheduno di essi si trova contenere un minor numero di veri, ma di una potenzialità od universalità sempre maggiore, fino a che, pervenuti alla sommità, il numero stesso è scomparito nella unità, e la potenza dell’universalità è divenuta massima ed infinita nell’ultimo tetraedro che forma la cima della piramide. [...] posciacché l’apprensiva e la memorativa di ciascun uomo non s’estendono all’infinito, epperciò non possono abbracciare tutti i veri particolari; al conoscimento di molti di questi è da preferirsi di gran lunga il conoscimento di que’ pochi che li racchiudono tutti, e da’ quali altresì la mente può ricavare e dedurre, ogni qual volta le piaccia, gli altri, in maggiore o minor numero, secondo il tempo e le forze, ch’ella spende nell’opera della loro derivazione e deduzione» (Degli studi dell’autore, I, 8).
Rosmini si distanzia, dunque, dall’enciclopedismo idealistico del sistema hegeliano, votato all’ineseguibile progetto di un sapere assoluto dell’assoluto concepito nel segno di un’assolutizzazione dell’ideale, mentre, al lato opposto, prendeva forma in quegli stessi anni l’enciclopedismo materialistico del positivismo di Auguste Comte, che progettava una riorganizzazione delle scienze empiriche, dette “positive” – e di quelle soltanto come le uniche legittime, secondo gli orientamenti di quello che sarà poi denominato scientismo – su base matematica. Così, tra questo, che tracciava il proprio percorso nella totalizzazione del reale finito e diveniente, e il primo, che lo assorbiva tutto nell’ideale, Rosmini tiene una via media, in cui si compongono le dimensioni ideale e reale nella sintesi esistenzialepratica dell’esperienza, che carica di senso i vissuti di realtà nella luce dell’idealità della loro concepibilità di pensati.
Negli anni tra il Sistema filosofico (1844) e la Prefazione alle opere metafisiche (1846) Rosmini precisa progressivamente il senso dell’unità del sapere, proponendo dapprima una partizione gnoseologica delle scienze filosofiche in scienze d’intuizione, di percezione e di ragionamento; poi, per definire l’ambito della metafisica, delinea un’intersezione del primo schema con la partizione parallela della filosofia intera in scienze ideologiche, metafisiche e deontologiche, con le opportune collimazioni che vedono le seconde comprendere «le scienze di percezione e il primo ramo di quelle di ragionamento», ramo che a sua volta «abbraccia l’Ontologia in senso stretto e la Teologia naturale» (Pref. op. metafisiche, 20-21). Infine, rispetto alle «quattro che costituiscono il gruppo delle scienze metafisiche», Rosmini seleziona ulteriormente introducendo uno scarto rispetto alle formulazioni precedenti e «riducendo le tre ultime in una sola scienza che abbiamo intitolata Teosofia» (22).
Così Rosmini dapprima attribuisce all’ontologia la trattazione «dell’ente considerato in tutta la sua estensione come è all’uomo conosciuto» ovvero «nella sua essenza e nelle tre forme in cui è l’essenza dell’ente, la forma ideale, la forma reale e la forma morale» (Sistema filosofico, 166), poi riporta l’ontologia ad un’unità superiore saldandola alla teologia naturale ed alla cosmologia, quali parti dell’unica teoria dell’ente: «La dottrina dell’Essere supremo presenta tre trattazioni o parti ben distinte ma intimamente connesse: la prima […] ragiona dell’essere in universale, a quel modo che lo concepisce l’umana mente per via d’astrazione, e risponde a quella scienza che si suole chiamare Ontologia; la seconda tratta dell’Essere assoluto per via di ragionamento idealenegativo, e risponde alla Teologia Naturale; la terza è una cotale appendice, che disputa delle produzioni dell’Essere assoluto, e risponde alla Cosmologia. Al complesso di tutta questa dottrina noi diamo il titolo di Teosofia» (Pref. opp. metaf., 29).
L’organizzazione del campo disciplinare del sapere fa dunque capo alle tre forme dell’essere quali modi o forme “essenziali” che, come si è potuto vedere, esauriscono il campo della realtà in tutte le sue espressioni.

Un’enciclopedia in atto. L’Antropologia rosminiana
La riflessione antropologica di Rosmini mira innanzitutto a ricostituire quell’unità della persona che pare ormai sfaldarsi sotto le varie angolazioni prospettiche delle diverse discipline.
La gnoseologia rosminiana, che pone a fondamento di ogni esperienza conoscitiva il “sentimento” e l’“essere intuito”, somministra gli elementi essenziali per la costruzione dell’antropologia, giacché l’anima è essenzialmente sentimento, è il primo sentimento, il “principio” del sentire. Come tale, però, l’anima necessita di un “termine” del sentire medesimo, che va riconosciuto nel corpo al quale è unita, come la forma alla materia, a dar luogo ad un’unica sostanza: «del sentito e del senziente si compone un sentimento unico, che in quanto è primo e fondamentale, è un ente unico ed indistinto» (Psicologia, I, l. III, 251).
Il sentimento è la vita, di cui l’anima è il principio, che scorre nel corpo. L’anima è così definita «l’atto di un sentimento sostanziale» (Antropologia in servizio della scienza morale, 45), o «un’incessante produzione» (264) o attualità di sentimento, e nella sua funzione permanente di sentire il proprio corpo e coglierne le modificazioni, è paragonata ad «un arco sempre teso» (387). Dal suo legame naturale col corpo nasce quel sentimento uniforme, permanente e indistinto col quale l’animale sente sé stesso, e che quando nell’uomo si porta al piano della coscienza dà luogo alla consapevolezza dell’io. È il sentimento fondamentale corporeo, di cui si è già fatto cenno in sede gnoseologica e grazie al quale l’uomo è in grado di avvertire gli enti esterni come modificazioni di un tale stato permanente.
Il sentimento fondamentale soggettivo, unitamente all’essere ideale oggettivo intuito dall’intelletto, restituiscono la completezza dell’uomo, che si colloca dunque all’incrocio di soggettività e oggettività, senza che si possa dissolvere la prima nella seconda, né risolvere la seconda nella prima. Rosmini tende qui al riequilibrio dell’antropologia classica in ascolto delle istanze della modernità: l’uomo si trova a riconoscersi un soggetto sensitivointellettivo, che da un lato tende all’essere ideale quale suo termine intelligibile e dall’altro si porta all’essere reale quale suo termine sensibile. Ora, nell’applicazione dell’essere oggettivo, colto dall’intelletto, al soggetto, sorge la ragione, la cui funzione è di unire l’ideale e il reale, l’essere e il sentimento, conferendo unità stabile al soggetto uomo.
La percezione intellettiva fondamentale o primitiva è l’atto primo della ragione che realizza l’unione dell’ente intelligibile con il sentimento animale, e fa dell’uomo un soggetto (o principio) razionale: «Questa percezione primitiva e fondamentale di tutto il sentito (principio e termine) è il talamo, per così dire, dove il reale (sentimento animalespirituale) e l’essenza che s’intuisce nell’idea, formano una cosa; e questa cosa sola è l’uomo» (Psicol., 264). Questa identità fornisce a sua volta il fondamento dell’autocoscienza, che sorge nella riflessione sulla propria unità e continuità esperienziale e storica. Nella coscienza dell’io si coglie la presenza nell’uomo di «sentimenti spirituali, tali cioè che non terminino in alcuna estensione, né in alcuna materia» (131) e la cui origine va riconosciuta ancora nell’idea dell’essere.
Nell’assetto dell’unità duale dell’antropologia rosminiana viene a giustificarsi anche la sopravvivenza dell’anima alla dissoluzione dell’unità organica del corpo: «Il corpo dell’uomo, uno dei due termini, è un complesso di elementi organati nel più perfetto modo specifico, e così individuati. Ora le forze della natura possono disciogliere questa organizzazione; e quindi distruggere con essa il sentimento animale proprio dell’uomo. Ma sull’essere universale tutte le forze della natura nulla possono; perocché l’essere universale è impassibile, immutabile, eterno, né soggiace all’attività di alcun ente. Dunque quella virtù colla quale l’uomo intuisce l’essere universale non può perire. Ma questa virtù, questo primo atto è l’anima intellettiva: dunque l’anima intellettiva non può cessare d’esistere nella sua propria individualità, giacché ha la realità sua propria che la individua, il che volgarmente s’esprime dicendo che è immortale. L’anima intellettiva dell’uomo, quanto alla sua origine è dunque sorta nel seno dell’anima sensitiva, fu una virtù di lei; ma questa virtù divenne atto principale ed acquistò l’immortalità tostoché attinse l’essere in universale, perché quest’essere è al tutto imperibile, immodificabile, cosa eternale» (679).
L’equilibrio che Rosmini conferisce all’antropologia come bilanciamento di soggettività che si costituisce veramente tale solo in riferimento all’oggettività dell’essere, dà consistenza ad un altro profilo di equilibrio nell’antropologia delle facoltà, permettendo di riconoscere nell’uomo una sintesi circolare di passività e attività, identificate rispettivamente nell’intelletto e nella volontà. Queste sono in rapporto circolare perché la volontà è concepita come risposta del soggetto all’esperienza conoscitiva garantita dalla ricettività dell’intelletto.
Riconosciuto nella volontà il principio attivo supremo dell’uomo, incluso nella facoltà intellettiva, Rosmini definisce la persona umana dapprima «un soggetto animale, intellettivo, e volitivo» (Antrop. sc. mor., 34), presentando così, in estrema sintesi, le note dell’unità sostanziale nella sua identità organicocorporea cui ineriscono le facoltà nella compiutezza della circolarità attivopassiva. Una seconda definizione articola la prima in una più distesa esplicitazione di quanto racchiude, per cui l’uomo è detto «un soggetto animale dotato dell’intuizione dell’essere idealeindeterminato, e della percezione del proprio sentimento fondamentale corporeo, ed operante secondo l’animalità e l’intelligenza» (37).
Assunto infine il punto di osservazione più elevato – quello dell’espressione attiva del complesso intellettivo dell’uomo rappresentata dalla volontà – il Roveretano perviene, nello sviluppo avanzato della sua Antropologia, a una definizione compiuta: «un individuo sostanziale intelligente, in quanto contiene un principio attivo, supremo, ed incomunicabile» (832). E nella Teosofia, richiamata questa definizione, aggiunge: «La persona dunque è una relazione sussistente. Ci hanno dunque delle relazioni sussistenti, ogni qual volta: 1.º L’una almeno delle due entità, che si confrontano dalla mente, sussiste; 2.º E l’una non si può concepire sussistente, se insieme con esso lei non si pensa l’altra entità a cui la mente la pone a fronte. Ora, ogni qual volta la mente non può pensare che un’entità sussista in se stessa, senza che ella ricorra ad un’altra, e la pensi per via di confronto a questa; allora l’entità sussistente deve avere una connessione essenziale con quell’altra, e per questa connessione deve essere quello che è, o come tale deve sussistere» (Teos., 903). E già in una nota dell’Antropologia in servizio della scienza morale, Rosmini aveva affermato: «Il nome persona non significa né meramente una sostanza, né meramente una relazione, ma una relazione sostanziale, cioè una relazione che si trova nell’intrinseco ordine dell’essere di una sostanza» (Antrop. mor., 833).
In riferimento alla seconda definizione, nella triade che pone l’uomo come intuente - percipiente - operante, è riconoscibile il suo sussistere in rapporto all’essere nella pienezza esaustiva delle tre forme: egli, infatti, nella sua costituzione ontologica è descrivibile come «una potenza (principio senziente o sentimento sostanziale), il cui primo atto termina, al tempo stesso, in un corpo sentendolo, nell’essere ideale intuendolo, nel bene volendolo» (U. Muratore), col che troviamo il soggettouomo costituirsi in relazione all’essere reale, ideale e morale, a riprodurre in sé quel sintesismo delle forme dell’essere che esaurisce l’intero ed ha la sua radice ontologica profonda in Dio.
In dipendenza dall’ontologia assumendo a fulcro l’antropologia: la filosofia della prassi come fedeltà all’essere reale
In forza dell’unità e circolarità delle forme dell’essere, Rosmini può coerentemente sviluppare il complesso etico del suo sistema, comprendente la sfera morale propriamente detta, il diritto e la politica.
Il nesso tra ontologia ed etica si impernia in Rosmini sull’antropologia: «Essere e Bene sono il medesimo; se non che il Bene è l’Essere considerato nel suo ordine, il quale viene conosciuto dall’intelligenza, che conoscendolo ne trae diletto. Il Bene in una parola è l’essere sentito in rapporto con l’intelligenza, in quanto questa vede ciò che ogni natura esiga a se stessa: ciò a che tenda con le sue forze nel modo detto» (Principi della scienza morale, II, 1).
L’idea dell’essere, in riferimento all’essere reale e consistente degli enti che si presentano all’esperienza, rivela il bene che è l’essere stesso, in quanto ha un ordine intrinseco. E di qui si riscontra come nella struttura delle forme dell’essere agisca in profondità l’antico organismo delle proprietà trascendentali dell’essere.
Il sommo principio della morale sarà allora «segui nel tuo operare il lume della ragione» (ibid.), giacché questo corrisponde alla stessa idea dell’essere che manifesta gli enti nella loro realtà, per cui si determinerà in concreto nel principio «ama l’essere, ovunque lo conosci, in quell’ordine ch’egli presenta alla tua intelligenza» (I, 7).
Il conoscere impone qui un ritorno riflessivo sull’ente già conosciuto come suo riconoscimento, affinché l’azione morale si possa determinare liberamente, per cui Rosmini distingue tra l’atto del semplice conoscere e quello del riconoscere l’essere dell’ente, sul quale fonda il proprio concetto di libertà: «L’uomo, quando percepisce un oggetto incontanente lo conosce tale qual egli è: questo è l’atto della semplice conoscenza. Ma quando egli rivolge uno sguardo a questo oggetto già percepito e dice a se stesso: sì, egli è tale, egli è di tal pregio, allora lo riconosce: allora lo rafferma a se stesso, e rafferma con un atto volontario e attivo ciò che prima conosceva con un atto necessario e passivo; questo è l’atto della coscienza riflessa» (Fil. del Diritto - Sist. mor., I, 1). Ritroviamo qui la circolarità attivopassiva dell’antropologia rosminiana delle facoltà posta a fondamento strutturaledinamico dello statuto morale della coscienza.
La capacità dell’intelletto umano di attingere il bene assoluto dipende dal suo essere informato dall’idea dell’essere universale: «la volontà tanti beni può volere, quanti l’intelletto conoscere. Ella segue l’intelletto. Ora l’intelletto può conoscere sempre de’ beni maggiori, fino che egli non venga al bene completo, sommo, il bene stesso, l’essere stesso, l’assoluto: qui si ferma, perché è l’ultimo, l’infinito; qui dunque solo può e dee fermarsi la volontà; né il desiderio di questa potenza sarà esaurito giammai, se ella non giunge all’acquisto del bene essenziale». Così Dio, quale fonte di ogni altro bene, è la ragion d’essere dell’intero spettro della felicità soggettiva, sino agli infimi beni corporei, quando a lui ordinati. Infatti, all’intelletto medesimo è possibile cogliere «quel nesso pel quale tutti i beni, anche corporei, da lui scaturiscono, e sono certe cotali comunicazioni che l’esser supremo fa di se stesso; [...] e fra il bene corporeo e il bene essenziale non si può dare alcuna intrinseca opposizione e contrarietà, come non si dà opposizione tra il rigagnolo e il fonte; anzi, dove è l’uno, dee scorrer l’altro: e quindi veggiamo che col possesso del bene essenziale, di questo bene dell’intelletto, l’uomo non potrebbe essere privo di tutta quella felicità, della quale potesse esser capace nell’altra sua parte, cioè nella corporea» (Princ. d. sc. mor., III, 8).
L’uomo può così concepire la felicità sua quale arco teso tra la dimensione soggettiva e l’intrinseca realtà oggettiva del bene, che affonda le radici nell’essere reale stesso, tensione aperta all’adeguazione, da parte della volontà, dell’idealità, dove manifesta tutto il suo valore la dimensione antropologica della libertà.
Ma anche qui Rosmini riesce a compiere una sintesi tra i paradigmi alternativi dell’impianto eudaimonistico aristotelico, offerto dalla classicità, e deontologico kantiano, elaborato dalla sensibilità moderna, verso la quale il Roveretano non disdegna di porsi in ascolto, giacché il riconoscimento dell’essere nel suo ordine è fonte e garanzia di felicità quanto è, al tempo stesso, un dovere etico fondamentale. Tale dovere però, non si autodetermina formalisticamente su sé stesso, ma, come si è detto, in ordine all’essere nello spessore ontologico proprio degli enti assunti a termine dall’azione morale.
L’uomo, secondo Rosmini, «è meramente passivo verso la legge morale; egli riceve in sé questa legge, ma non la forma; è un suddito a cui la legge s’impone, non è un legislatore che la impone» (Princ. d. sc. mor., I, 4). Tale passività consiste nel fatto che il giudizio di valore è un atto di riconoscimento della realtà dell’essere nell’ordine oggettivo che presenta all’intelletto, non un conferimento soggettivo e arbitrario di senso.
Assume qui grande rilievo il concetto di personalità morale, che non coincide, per Rosmini, con la sola soggettività, ma costituisce il plesso derivante dall’unione di oggettività e soggettività. Così il bene della persona umana consiste nella sua adeguazione all’essere nel suo ordine.
La giustizia consisterà dunque nel dare a ciascun essere ciò che gli spetta, e nell’ordine dell’essere alcuni enti hanno statuto di persone, per cui andranno assunti a fine dell’azione, in quanto partecipano dell’essere ideale infinito, inizio e via all’essere reale infinito che è Dio, mentre altri enti hanno statuto di cose, e andranno assunti quali mezzi: «Iddio e l’uomo, ecco gli oggetti della morale, che tutta ha per oggetto il bene degli esseri intelligenti» (VII, 8).
Dalla morale al diritto
Sul concetto di persona come soggetto morale avente ragione di fine si fonda l’intero edificio della filosofia del diritto di Rosmini. Il diritto, definito «una potestà morale», ovvero «una facoltà di operare ciò che piace, protetta dalla legge morale che ne ingiunge ad altri il rispetto» (Filosofia del Diritto - Essenza del Diritto, I), è un attributo inscindibile della persona morale e si risolve tutto nel dovere morale che limita l’attività personale di ciascuno entro i confini che costituiscono la sfera del diritto, di cui rende per altri obbligatorio il rispetto. Il diritto non inerisce alla persona umana ma è la stessa persona in quanto investita di dignità infinita e di ragione di fine: «la persona dell’uomo è il diritto umano sussistente» (Fil. d. Dir., I, 49).
Il principio attivo supremo della persona, riconosciuto in sede antropologica nella volontà, è la stessa attività del diritto, e riceve dal lume della ragione (l’idea dell’essere) il principio di giustizia che abbiamo visto procedere dal riconoscimento dell’essere quale sommo principio della morale, «Ma poiché la dignità del lume della ragione (essere ideale) è infinita, perciò niente può stare sopra il principio personale, niente può stare sopra quel principio che opera di sua natura dietro un maestro e signore di dignità infinita; quindi viene che esso è principio naturalmente supremo, di maniera che nessuno ha diritto di comandare a quello che sta ai comandi dell’infinito» (I, 52).
Ecco che allora ogni azione che attenta alla supremazia della persona sulle attività sottoposte o allo stesso rapporto tra il soggetto personale umano e il bene oggettivo suo proprio, a partire dal legame con la verità e la facoltà di intenzionarla liberamente, si traduce in violazione del diritto fondamentale, cioè della persona stessa.
La libertà della persona, principio formale del diritto, è in grado di specificarlo e determinarlo nei beni particolari concretizzandosi nel concetto di proprietà quale «dominio che una persona ha di una cosa» (Fil. d. Dir. - Del principio della derivazione de’ diritti, II, 2) e che si articola a partire dalla proprietà che la persona ha sulla sua stessa natura (proprietà connaturale all’uomo), alla proprietà sui beni esterni (proprietà acquisita).
Il diritto sociale deve nutrirsi alla fonte del diritto naturale individuale, cosicché non deve esservi opposizione, né tanto meno prevaricazione da parte della società nei confronti della persona nella sua singolarità. La società deve arricchire il campo aggiungendo ai diritti della persona nuove relazioni e attività e, con ciò, ulteriori segmenti binomiali di diritti-doveri; per contro non può mai sottrarre diritti personali, col che verrebbe ad intaccare la fonte stessa del diritto: «si sciolga la società civile, s’egli è bisogno acciocché si salvino gl’individui [...]. Il cittadino deve servire all’uomo, e non questo a quello; la società è propriamente il mezzo, e gl’individui sono il fine» (Fil. d. Dir., 1660).
Tra le infinite forme di società possibili, tre sono necessarie, giacché «né potrebbe vivere sulla terra, né svilupparsi al conse-guimento della sua terrena perfezione e dei suoi immortali destini se non fosse ordinato e collegato insieme secondo gl’inviti della natura, le relazioni morali, i bisogni. V’ha dunque una organizza-zione necessaria dell’uman genere; v’hanno delle società di cui non si può far senza, perché condizioni di quell’organizzazione, anzi sue parti costitutive» (483). Esse sono la società teocratica (religione – voluta da Dio come legame di ogni individuo al suo Creatore che implica la sua unione con tutti i suoi simili, onde condividere i beni comuni di verità, virtù e felicità, costituisce il fondamento di ogni altra società), la società domestica (famiglia - composta dalla società coniugale (marito-moglie, che si coinvol-gono in pienezza di tutto il loro essere in unione reciproca) e dalla società parentale (genitori-figli, nei cui rapporti i diritti dei primi sui secondi riguardano la natura, non la persona, che quando è portata alla maturità piena assorbe, nel governo autonomo della natura, tutti i diritti)) e la società civile (Stato - sorge in forza della volontà di più nuclei familiari di affidare la conservazione e rego-lamentazione dei loro diritti ad un’unica mente, individuale o col-lettiva, chiamata governo). La società civile è universale (regola tutti i diritti), suprema, perpetua, ed ha come scopo il bene comune e, subordinatamente ad esso, sia il bene pubblico che il bene privato. Nella partecipazione alla società civile bisognerebbe distin-guere, per Rosmini, in ogni cittadino, ciò che pertiene al suo esse-re persona e ciò che pertiene alla sua natura. In quanto persona, ogni cittadino ha uguale dignità e dovrebbe concorrere con voto universale all’elezione degli organi di governo cui è affidata l’amministrazione dei soli diritti personali; in quanto natura, cia-scuno dovrebbe contribuire alla formazione della società in pro-porzione alla quota di beni materiali che mette in comune, in rap-porto alla proprietà di cui dispone. Rosmini tenta per questa via di risolvere la questione della compossibilità di un’eguaglianza cui la società deve tendere, riconoscendo a tutti in quanto persone l’essere soggetto di diritto in garanzia della dignità umana, e della differenza dovuta al diritto di proprietà che comporta un possesso di beni materiali differenziato per ogni soggetto, che sarebbe con-tro natura pretendere di pareggiare. Nella società civile due virtù garantiscono la conservazione dell’equilibrio: la giustizia, in rapporto al fine ultimo della società stessa, che mira alla piena realizzazione dell’uomo, e la prudenza, in rapporto al fine prossimo, che mira all’equa distribuzione delle risorse e dei beni.
Dal diritto alla politica
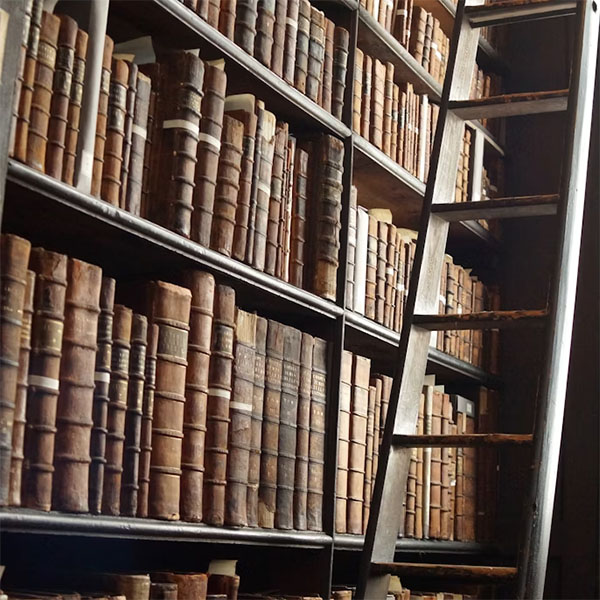
Determinare la distribuzione del bene senza che ne sia violata la giustizia è compito della filosofia della politica, che chiude, ponendosi coerentemente in derivazione dalla morale e dal diritto, il vasto campo dell’etica, il quale, a sua volta, nel prendere corpo grazie alla sua aderenza al piano ontologico dell’essere reale, riconosciuto grazie al lume della ragione costituito dall’essere ideale, salda la circolarità della circuminsessione delle forme dell’essere e conferisce salda unità al tutto.
Rosmini distingue nella società civile due ordini di beni, prossimi e remoti, ossia di utilità immediata (beni materiali) e di finalità ultima (beni morali). Di qui le due forze che muovono la società: una sorta di istinto sociale denominato da Rosmini ragione pratica delle masse, che mira ai beni immediati e particolari, e una tendenza contraria, denominata ragione speculativa degli individui, propria di quanti sono chiamati a governare la società secondo prospettive di lungo termine e sono in grado di subordinarvi i beni accidentali e le utilità finite e momentanee.
Anche in politica, è il senso della persona a fungere da principio orientativo e perno di tutto, e a motivare così l’idea di una società finalizzata alla massima felicità possibile di ciascuno dei suoi membri, stante il riconoscimento del loro diritto ad un reale bene comune, non ad un astratto bene pubblico. Come nella natura dell’uomo, «due sono le parti di ogni società umana, l’invisibile e la visibile [...]. A questa doppia società corrispondono le due specie di vincoli che la formano: vincoli interni ed invisibili [...], esterni e visibili» (Politica prima / Frammenti - fr. 2, p. 592). Così si ha una duplice relazione, simile a quella che comporta nella persona umana l’unità integrata di anima e corpo, che porta l’individuo a divenire socius mediante «un vincolo d’amore per rispetto alle persone» (quando «vede negli altri la propria similitudine») e «un vincolo di possesso per riguardo alle cose» (quando le riserva a un dato uso) (p. 600). Così individuo e società formano «quasi un’unica esistenza, una sola persona morale, [...]. Così diventa la società fine dell’uomo a quel modo che l’uomo è fine a sé medesimo» (601). È l’idea della società come di un uomo in grande, che assume la finalizzazione eudaimonistica in una compagine sociale in cui il valore del bene comune possa essere determinato in modo da non confliggere con la felicità individuale. «La felicità sociale consiste in quell’aumento di felicità individuale che prova l’uomo quando può goder questa in comunione con altri suoi simili» (602). Una prospettiva che non manca di caricarsi di un ulteriore significato in prospettiva teologica, e in rapporto a Lc 22,25-27 e alla forma particolare assunta dalla società ecclesiale, Rosmini ricorda che Cristo, «uomo eminentemente sociale [...] rivolgendosi ad associare veramente gli uomini, escluse dalla sua società il dominio e la signoria; come quella che dà bensì l’esistenza ad una società apparente, ma non reale»; così, egli «congiunse in tal modo la nozione della società colla nozione della libertà: dichiarò che essere uomo sociale veniva a significare il medesimo che essere uomo libero: estendere la società valeva quanto estendere la libertà: mentre tutti i membri della società formano una persona sola la quale ha un fine solo, di cui tutte le membra, secondo la loro proporzionata grandezza ed eccellenza partecipano» (608s).
Tra le tendenze politiche, Rosmini condanna ogni utopismo e in particolare il perfettismo, «cioè quel sistema che crede possibile il perfetto nelle cose umane, e che sacrifica i beni presenti alla immaginata futura perfezione» (Filosofia della politica - Sommaria cagione..., 14, p. 104) e che egli vede rappresentato nelle utopie socialiste del tempo, che concepivano il bene della società in astratto attendendosi «da un puro meccanismo l’universale prosperità», dimenticando però «che le macchine sociali non son di legno o di ferro formate» (Saggio sul comunismo e socialismo - Opuscoli politici, p. 93) fino a dissolvere i diritti naturali dei singoli cittadini, «che s’inabissano nell’assolutismo governativo» (103).
Rosmini è favorevole, contro le correnti conservatrici della Restaurazione, alla concessione delle Costituzioni, che riconosce frutto di una maturità giuridica e politica delle nazioni, ma che ritiene necessario siano bilanciate sul diritto di proprietà, col che rimane ammessa nel suo pensiero politico la diseguaglianza sociale, fatto che la società deve tendere a ripianare col provvedere che a tutti sia garantito il minimale per un’esistenza dignitosa, tale da permettere l’esercizio dei diritti fondamentali e inalienabili della persona. Tale prospettiva motiva la tesi della “doppia rappresentanza”, personale, quale diritto a una rappresentanza di diritti (passiva), in virtù della partecipazione alla vita civile nella pari dignità dell’esserepersona dei singoli, e reale, che esprime il dritto a una rappresentanza d’interessi (attiva) e si dà in rapporto al peso col quale il cittadino partecipa alla società con la propria quota parte di beni. Si è parlato per questo di neopatrimonialismo, per la concezione giuridicopolitica di Rosmini, peraltro sovente fraintesa come affetta da inaccettabili residui di conservatorismo classista, dove basterebbe, a smentita di una lettura così semplicistica, un’attenta considerazione della levitazione teologica della natura e destino della società umana, chiamata a realizzare ben altri ideali di fraternità e comunione, come si è in precedenza accennato.
Con la centratura del valore della persona e il riconoscimento della sua libertà e creatività quale fattore positivo di sviluppo, pur senza fughe in avanti verso derive libertarie, ma con un misuratissimo bilanciamento di istanza personalista e ragione societaria, di libertà individuale e responsabilità sociale, Rosmini è annoverato tra gli esponenti più equilibrati del Cattolicesimo liberale.
Pedagogia e cultura
Nell’ordine della carità intellettuale e, più propriamente, nella prospettiva di una concezione antropologica che guarda allo sviluppo integrale della persona, la riflessione pedagogica e sulla cultura è costante nel pensiero di Rosmini, sin dalle opere del periodo giovanile. Essa si impernia sul concetto di unità dell’educazione, unità nel fine, principio in sé di ogni unità, nelle dottrine (il che ci rimanda all’ideale enciclopedico rosminiano) e nelle potenze, cioè nel metodo d’insegnamento (Sull’unità dell’educazione, Intr.). A questo si aggiunge il principio della gradazione naturale delle idee, che va assecondato e seguito nell’educazione (Del principio supremo della metodica).
L’educazione, generatrice di cultura (nel senso più ampio e non nozionistico del termine), cui si lega a sua volta l’estetica, tende all’unificazione del soggetto in tutte le sue componenti: «l’educazione dee abbracciare la mente, il cuore e la vita dell’uomo. Ora il cuore, cioè la volontà cogli affetti dee rispondere alla mente, la vita rispondere al cuore. Se la mente dunque si conforma all’ordine oggettivo delle cose, se si ha in esso il tranquillo lume del vero, non il falso e confuso delle opinioni e pregiudizî, il cuore avrà il tipo su cui, per così dire, stamparsi, e la vita non sarà che una continua indagine del cuore. Se la vita dee essere un’incessante produzione del bene universale, nel cuore prima dee esservi la universale carità; e questa non può esservi nel cuore, se nella mente non v’ha la disposizione a non escludere niuna cognizione, ad abbracciarle tutte. L’universalità della mente imparziale produce l’universalità del cuore benevolo, e l’universalità del cuore benevolo produce l’universalità della vita buona» (Princ. supr. d. metodica, l. II, sez. V, a. VI, § 3).
L’importanza di quest’ambito di riflessione in Rosmini è tale da avergli guadagnato la considerazione di fondatore della scuola pedagogica italiana e da aver indotto, a partire da Gentile, una riconsiderazione dell’intera sua concezione filosofica alla luce della pedagogia quale interessante e preziosa chiave di lettura del sistema nella sua unità e organicità.
Alberto Peratoner
Facoltà Teologica del Triveneto

Bibliografia essenziale
- Prini, Introduzione a Rosmini, Roma - Bari, Laterza, 1997, pp. 202.
- Muratore, Conoscere Rosmini. Vita, pensiero, spiritualità, Stresa, Edizioni Rosminiane, 2002.
—————————————————
M.F. Sciacca, La filosofia morale di Antonio Rosmini, Firenze, 1938; Milano, Marzorati, 1960.
- Prini, Introduzione alla metafisica di A. Rosmini, Stresa, Ed. Sodalitas, 1953.
Atti del Congresso Internazionale di Filosofia Antonio Rosmini (StresaRovereto 20-26 luglio 1955), a cura di M.-F. Sciacca, Firenze, Sansoni, 1957, 2 voll.
- Schiavone, L’etica del Rosmini e la sua fondazione metafisica, Milano, Marzorati, 1962.
- Verondini, La filosofia morale di A. Rosmini, Bologna, Cappelli, 1967.
- Percivale, L’ascesa naturale a Dio nella filosofia di Rosmini, Roma, Città Nuova, 1977.
- Staglianò, La “teologia” secondo Antonio Rosmini . Sistematicacriticainterpretazione del rapporto fede e ragione, Brescia, Morcelliana, 1988.
P.P. Ottonello, L’ontologia di Rosmini, L’Aquila – Roma, Japadre, 1989.
M.A. Raschini (ed.), Rosmini pensatore europeo¸ Milano, Jaca Book, 1989.
K.-H. Menke, Ragione e Rivelazione in Rosmini. Il progetto apologetico di un’enciclopedia cristiana, Brescia, Morcelliana, 1997.
Rosmini e l'enciclopedia delle scienze, Atti del Congresso internazionale (Napoli, 22-25 ottobre 1997), a cura di P.P. Ottonello, Firenze, Olschki, 1998.
- Ferronato, La fondazione del diritto naturale in Rosmini, Padova, Cedam, 1998.
Il pensiero di Antonio Rosmini a due secoli dalla nascita, a cura di G. Beschin, A. Valle, S. Zucal, Brescia, Morcelliana, 1999, 2 voll.
- De Giorgi, Rosmini e il suo tempo. L’educazione dell’uomo moderno tra riforma della filosofia e rinnovamento della Chiesa (1797-1833), Brescia, Morcelliana, 2003.
- Grandis, Il dramma dell'uomo. Eros/Agape & Amore/Carità nel pensiero antropologico di Antonio Rosmini Serbati (1797-1855), Torino, San Paolo, 2003.
- Krienke, Wahrheit und Liebe bei Antonio Rosmini, Stuttgart, W. Kohlhammer, 2004.
- Lorizio, Antonio Rosmini Serbati, Roma, Lateran University Press, 2005.
Antonio Rosmini tra modernità e universalità, a cura di M. Dossi e M. Nicoletti, Brescia, Morcelliana, 2007.
- Peratoner, Enciclopedismo ontologico e Metafisica dell’unitotalità. La via di Antonio Rosmini alla deframmentazione dei saperi, «Marcianum», 4 (2008).
- Goisis, Il pensiero politico di Antonio Rosmini e altri saggi fra critica ed Evangelo, S. Pietro in Cariano (Vr), Gabrielli, 2009.
S.F. Tadini, Il problema di Dio nella metafisica rosminiana, Milano, Vita e Pensiero, 2015.
G.P. Soliani, Essere, libertà, moralità. Studi su Antonio Rosmini, Napoli, Orthotes, 2018.
Antonio Rosmini e la filosofia, «Divus Thomas», 123 (2020), 2.
Rosmini filosofo e teologo con Tommaso: unità di scienza e santità, in «Divus Thomas», 126 (2023), 1.
Profili della libertà in Antonio Rosmini, a cura di M. Ferronato e A. Peratoner, Sesto San Giovanni (Mi), Mimesis, 2024.
—————————————————
Padova, Facoltà Teologica del Triveneto, 2008; rev. Venezia, 2022; 2025