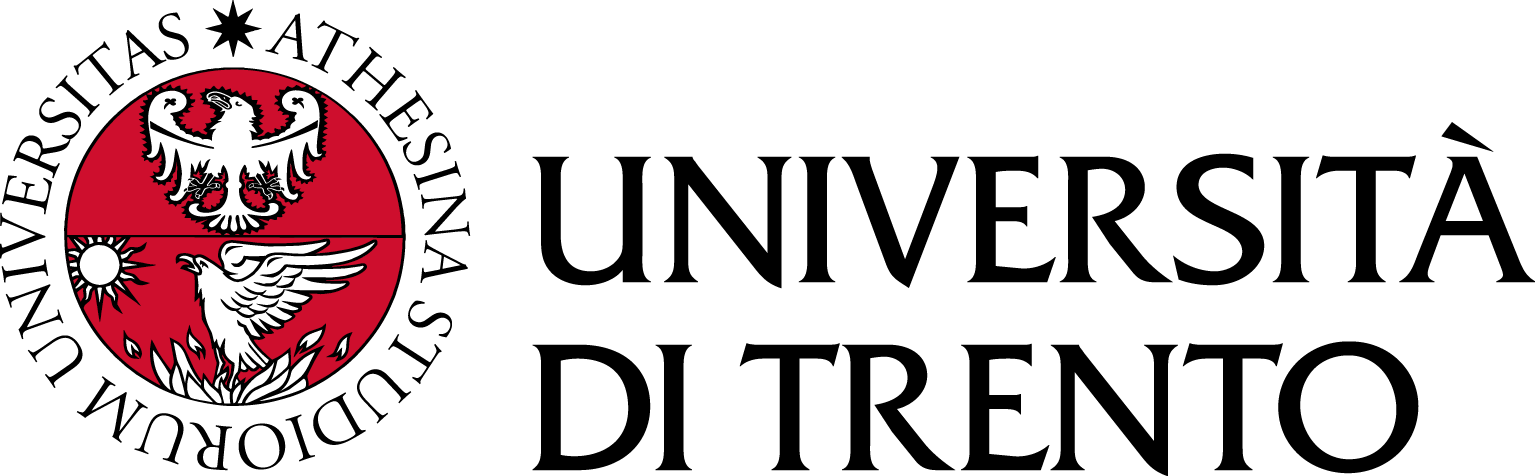Del Principio Supremo della Metodica e di alcune sue applicazioni in servigio dell'umana educazione: Introduzione
Del Principio Supremo della Metodica e di alcune sue applicazioni in servigio dell'umana educazione.
DEL PRINCIPIO SUPREMO DELLA METODICA E DI ALCUNE SUE APPLICAZIONI IN SERVIGIO DELL'UMANA EDUCAZIONE
Io stimo avervi qualcosa di scientifico destinato a divenir popolare, e questo scientifico è tutto ciò, che s'attiene alla verità. Rosmini
1.
La Metodica è una parte della Logica; e quando ella si prende in tutta la sua generalità, si può dire che sia la Logica stessa ; conciossiachè niente s'insegna nella Logica, che non abbia per iscopo di stabilire il metodo da tenersi nei nostri ragionari.
Ma l'opera presente non considera il metodo in tutta quella estensione di significato, di cui può essere suscettibile questa parola; e però noi dobbiamo dire qui sul principio quai confini poniamo alla nostra trattazione.
2.
La mente umana ha per oggetto la verità, e relativamente a questo suo oggetto nobilissimo essa esercita diversi uffici.
Alcuni di questi uffici riguardano la verità già conosciuta, altri la verità che ancora non conosce e di conoscere s'industria.
3.
Gli uffici della mente verso la verità conosciuta si possono ridurre a tre, che sono: 1° il comunicarla altrui; 2° il difenderla ; e 3º lo sceverarla dagli errori.
4.
Gli uffici della mente verso la verità non ancor conosciuta, e che cerca conoscere, si riducono parimente a tre, cioè: 1° a trovare le dimostrazioni delle verità note; 2° a trovare le conseguenze che danno le verità note collo svolgerle e coll' applicarle; e 3° finalmente, ad attingere coi nostri sensi, mediante osservazioni ed esperienze, de' novi dati sui quali possiamo istituire dei ragionamenti interamente nuovi.
5.
Ciascuno di questi uffici dell'umana mente ha il suo metodo, che è un complesso di regole direttrici della mente stessa in eseguire l'ufficio suo; laonde si possono distinguere sei specie di metodo, come si sono distinti sei uffici della mente verso la verità.
6.
Vi ha un metodo espositivo, che insegna a comunicare altrui nel modo migliore le nostre cognizioni; vi ha un metodo polemico, che insegna a difenderle ribattendone gli assalitori; vi ha un metodo critico, che insegna a separare ciò che è vero da ciò che è falso: questi sono i tre primi metodi che presiedono agli uffici della mente verso le verità conosciute. Gli altri tre sono: un metodo dimostrativo, che dà le regole acconce a formare delle esatte dimostrazioni; uno induttivo, che addita il modo onde si può da ciò che si conosce indurre e conchiudere a ciò che ancora non si conosce, sviluppando le contezze che abbiamo, quasi pochi germi di quelle molte più che non abbiamo; e finalmente c'è un metodo, che chiamerò percettivo-induttivo, il quale non si contenta d'indurre e conchiudere, da certi dati che si hanno, varie nuove notizie, ma ci conduce a trovare dei dati nuovi del tutto, mediante nuovi fenomeni ch'egli destramente fa nascere ed apparire ai nostri sensi: questi sono i tre metodi, che presiedono agli uffici della mente verso le verità da conoscersi. Questo ultimo solo è propriamente il metodo sperimentale: il metodo baconiano: quello, a cui si devono gl'immensi progressi fatti dalla Fisica nei moderni tempi (1).
7.
Ora, di tutti questi metodi niuno, eccetto il primo che prescrive le regole di comunicare altrui la verità, forma l'argomento dell'opera nostra presente; gli altri esigono delle trattazioni a parte; tutti gli abbraccia, come dicevamo, la Logica, della quale scienza il nostro scritto non presume di essere, per così dire, che un solo brandello.
Ma, oltre essere un brandello della scienza dell'arte logica, egli è ancora qualcos'altro, dico qualcosa di più.
8.
Il metodo espositivo, di cui si occupa la scienza del diritto ragionare, contiene le regole, secondo le quali taluno può acconciamente comunicare altrui le proprie cognizioni, ed è però il metodo che presiede all'insegnamento in generale. Ma, dato questo metodo, un maestro o istitutore qualsiasi è obbligato di applicarlo egli stesso alla scuola che fa; e quest'applicazione, questo uso delle regole del metodo che eseguisce il maestro co' suoi discepoli, è ella stessa un'arte, ed ha ella stessa dei principî fissi e molto utili a sapersi distintamente. L' adunare questi principî, l'ordinarli e il semplificarli è ciò che toglie a fare la Pedagogica, scienza che contiene i documenti della grand'arte di educare la gioventù. Or egli è alla Pedagogica, che noi abbiamo vôlti i pensieri: poco ci move la vaghezza di esporre, mediante sottili ricerche, delle leggi meramente speculative del pensare, lasceremmo ben volentieri a chi di maggior ozio è fornito, che noi non siamo, un tale assunto, se non si trattasse di nulla più. Ma noi stringe grandemente il bisogno di tanti buoni maestri, che ogni dì confessano andar tentoni, privi di scorta pel vasto e pericoloso campo dell'ammaestrare; ci stringono i loro lamenti, le loro sparse fatiche; ci move l'affetto della cara gioventù e la carità verso il nostro genere, che ognora perendo vecchio e viziato, ognora rinasce fresco e incorrotto in novelle generazioni, le quali, come verdeggianti rampolli di antico ceppo, ogni vaghezza alla vista e ogni abbondanza di soavi frutti da prima promettono, ma poi anch'esse imbastardiscono e si disseccano per mancamento di arte, di mani industri abbastanza a proteggerle da esterni insulti, a sostenerle, a inaffiarle avvizzite, non lasciandole cadere miseramente per terra e rimboschire e incespare e marcire; rimanendosi tuttavia l'umanità quella di prima, se non peggiore.
9.
Vero è, che nel secolo nostro sentesi universalmente la necessità che le scuole procedano con un metodo evidente e sicuro, e si cercano da per tutto i principi del metodo desiderato; e parte dalle meditazioni de' più acuti ingegni, parte dall'esperienza de' più zelanti educatori si traveggono e pressochè si colgono; il che deve essere invito a tutti quelli che sono da ciò, o hanno speranza di poter apprestar qualche aiuto in tanto bisogno, di occuparsi all'opera comune con tutte lor forze. Ma in pari tempo la diversità delle opinioni e dei tentativi, le vie diverse per le quali ciascun educatore s'incammina, e le contese tra loro apertamente dimostrano, che manca ancora all'arte del metodo, di cui parliamo, una base ferma, da tutti ammessa e tale, che ove s'intenda, niuno possa non ammettere. Que' governi medesimi che assunsero di dirigere l'istruzione, e che certo avrebbero alle mani tanti mezzi di farlo, vacillano ancora ne' loro passi; e se in quelle nazioni nelle quali l'istruzione è guidata dalla pubblica autorità, ella si vede procedere d'un andamento più regolare, di rado poi avviene, che le scuole sottomesse a prescrizioni uniformi e inalterabili non sieno le ultime a ricevere i miglioramenti, o non mettano ostacolo a provarli, rendendo fino impossibili gli esperimenti che li producono, ovvero che dalle buone invenzioni straniere non si contentino di prendere la scorza, lasciato il midollo e lo spirito. Egli è per queste cagioni, che noi intendiamo, che l'indole dell'opera presente sia ancora più pedagogica che logica; e che se essa, considerata in quanto si propone di additare le regole principali del metodo espositivo, è un brano dell'arte del pensare, considerata poi in quanto ella si propone di volgere queste stesse regole a farne le prime applicazioni all'ammaestramento della gioventù, ella è una parte dell'arte dell'educazione.
10.
Se con questo lavoro noi abbiamo ottenuto il nostro intento, non sta a noi il giudicarlo, e solo il tempo, il quale suole svolgere i semi delle dottrine sparsi dagli scrittori nelle società, come quelli delle piante consegnati dall'agricoltore alla terra, potrà deciderlo coi frutti stessi. Intanto, se solo un minimo aiuto verrà da queste carte alla buona istituzione della nostra gioventù, io crederò di avere troppo bene speso il mio tempo e i miei peṇsieri. In caso contrario poi, non sarà forse disutile l'aversi intavolata una discussione di buona fede su delle questioni attenenti a sì importante materia: e alla peggio, quand’anche nulla ci fosse in quanto dirò, da giovarsene il mondo, quelli che amano con sincerità i loro simili sapran valutare le intenzioni che mi fecero prender questa fatica, e s'accorgeranno, io spero, che al battito del loro cuore risponde quello del mio. Vengo ora ad espor brevemente, da quale aspetto io creda di dover riguardare la materia per non ripetere troppo di quello che già fu acconciamente detto da molti, e per condurre i ragionamenti a quella unità dove sempre risiede la evidenza, e si trova la prima e pura scaturigine di qualsiasi disciplina.
11.
Molte possono essere le regole speciali a cui soggiace il metodo espositivo, nè sono punto ignote. Ma sembra a noi, che non solo maggior chiarezza verrebbe a ciascuna d'esse, quando tutte riferir si potessero ad una sola, ma ben anco maggior facilità d'osservare puntualmente quel metodo, quando invece di tante ci varrebbe quell'una; e con una fedele applicazione di essa potremmo trovare ciò che cerchiamo, cioè il metodico andamento del nostro ragionare, senza darci cura di più. Laonde noi stimiamo di volgere principalmente le nostre ricerche a trovare il principio supremo dal quale tutto il metodo espositivo discende; il che non sappiamo essersi fin qui fatto da nessun altro. Così la trattazione riducesi a stato e condizione di-scienza: conciossiachè in niuna discussione può avervi scientifica esattezza e vero sistema, se non si ordinano le cognizioni più speciali sotto le più generali, e le generali sotto quella generalissima che di tutte è capo e madre feconda. In quest'ultima solamente trova suo riposo la mente umana, che non è appagata giammai, se non vedesi pervenuta all'ultimo anello della catena, all'ultima semplicissima assoluta ragione.
Che se guadagnerem tant'altezza, piuttosto che di noia e fatica, ci riuscirà di ricreamento e diletto in riguardare gl'immensi piani che ci stan sotto, i quali abbraccerem d'uno sguardo nel loro complesso, nel loro ordine, nella loro bellissima varietà, e potremo a nostro grand'agio considerare tutte le parti e misurarle e tra loro paragonarle. Voglio dire, che la mente, posseditrice d'un alto principio di scienza, domina, per così dire, la scena delle innumerevoli, sempre nuove, conclusioni che da quel principio derivano, e può trarle fuora a sua voglia e ordinarsele come meglio le viene e ricercarne il valore e tra loro paragonarle. Il perchè senza più poniam mano a quella principale ricerca, da cui tutte le cose, che in appresso sarem per dire, verremo di mano in mano, quasi conclusioni assai facili, raccogliendo.